|
Il lager di Auschwitz era composto di 3 campi maggiori e di
circa 35 sottocampi.
I tre campi principali erano:
- Auschwitz 1, ex caserma polacca detta all'epoca il campo principale
- Auschwitz 2 Birkenau, il grande campo in baracche, di cui iniziò
la costruzione nell'ottobre del 1941, con le 4 grandi camere a gas ed i crematori
annessi.
- Auschwitz 3 Monowitz, il campo costruito a fianco della fabbrica
I.G.Farben di Buna, dove furono internati, fra gli altri,
Primo Levi, Elie Wiesel e Jean Améry.
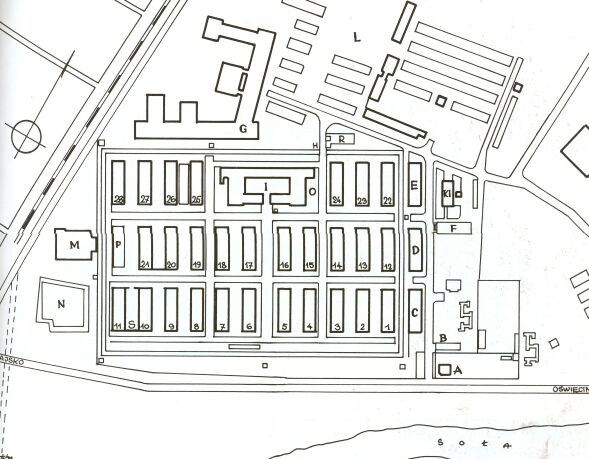
Mappa di Auschwitz 1
A-Villa del comandante del campo
B-Case della guarnigione del campo
C-Uffici del comandante del campo
D-Uffici dell'amministrazione del campo
E-Ospedale delle SS
F-Uffici della Sezione politica (Gestapo)
G-Registrazione dei nuovi prigionieri
H-Cancello di ingresso con la scritta Arbeit macht frei (il lavoro rende liberi)
I-Cucine
KI-Camera a gas e crematorio I
L-Magazzini, garages e laboratori
M-Magazzini per gli oggetto depredati ai deportati e luogo di custodia del gas
Zyklon B
N-Pozzi per i cadaveri e luoghi di esecuzioni
O-Luogo dove suonava l'orchestra del campo all'uscita e al ritorno dei deportati
dal lavoro forzato
P-Lavanderia
R-Posto di guardia delle SS
S-Il muro nero, dove venivano uccisi i prigionieri tramite fucilazione o con
un colpo di pistola alla nuca
1-28-Baracche dei prigionieri
11-Blocco della morte, dove risiedeva il Sonderkommando del crematorio I e dove
erano detenute le persone prima dell'uccisione
10-Blocco di medicina sperimentale, dove il dott.Clauberg sperimentava sui detenuti
la sterilizzazione
4-Blocco dove era scrivano Burger, uno dei leader della resistenza segreta del
campo
24-Blocco al cui piano inferiore abitava l'orchestra dei detenuti ed al cui
piano superiore era il bordello del campo
20-21-Infermeria dei detenuti, dove la SS Klehr uccideva con le iniezioni di
fenolo

Mappa di Auschwitz 2-Birkenau
A-Ingresso principale e torre del corpo di guardia
BI-Settore I
BII-Settore II
BIII-Settore III, in costruzione e mai terminato (soprannominato Messico
perché gli internati di questa zona, che erano gli ultimi arrivati al campo,
spesso vi pernottavano all'aperto, avendo solo una coperta per il freddo). Vi
erano circa 10.000 internati, per la maggior parte provenienti dalle deportazioni
dall'Ungheria
BIa-Lager femminile, in funzione a partire dall'agosto 1942
BIb-Il primo settore ad essere costruito, in funzione dal marzo 1942. Fu all'inizio
Lager maschile. Dal 1943 divenne parte del Lager femminile. Alma Rosè dirigeva
l'orchestra di BI. Fra BI e BII fu impiccata la detenuta Mala Zimetbaum che era
riuscita a scappare, ma era poi stata ripresa
BIIa-Area della quarantena
BIIb-Campo delle famiglie degli ebrei provenienti dal ghetto di Theresienstadt.
Erano 5006 persone. Ne morirono 1040 di stenti in 6 mesi. I sopravvissuti furono
tutti condotti alle camere a gas il 7 marzo 1944, esattamente 6 mesi dopo il loro
arrivo (solo 70 prigionieri in giovanissima età furono risparmiati). La
baracca 30 di BIIb era il famigerato blocco sperimentale.
BIIc-Dal 16 maggio 1944, campo degli ebrei provenienti dall'Ungheria
BIId-Campo maschile con internati di diversa provenienza
BIIe-Dal 26 febbraio 1943, campo degli zingari
BIIf-Area di stazionamento degli internati ammalati (Infermeria), alle
dipendenze, fra gli altri, di J.Mengele.
C-Case della guarnigione delle SS del campo e loro quartier generale
D-Magazzini in cui venivano conservati tutti i beni rapinati agli internati. Il
settore era soprannominato Canada, perché vi si trovava ogni genere
di beni
E-La Rampa. Piattaforma di arrivo dei treni, dove avveniva la selezione
fra gli ebrei destinati alle camere a gas e quelli che erano internati nel campo
e smistati ai vari settori
F-Docce (Sauna), dove venivano spogliati tutti i nuovi arrivati al campo
G-Pozzi ed aree in cui venivano bruciati i corpi all'aria aperta
H-Fosse comuni dei prigionieri di guerra russi
I-Prima camera a gas provvisoria (la Casa rossa)
J-Seconda camera a gas improvvisata (la Casa bianca)
KII-Camera a gas e crematorio II
KIII-Camera a gas e crematorio III
KIV-Camera a gas e crematorio IV
KV-Camera a gas e crematorio V
L-Latrine e lavabi comuni
NB Il sistema di numerazione delle baracche dei settori BIIc, BIId e BIIe era
lo stesso del settore BIIb
Auschwitz.
A History in photographs
The Auschwitz-Birkenau State Museum, Oswiecim,
1993
Le foto sono, in massima parte, opera delle SS, che ripresero sia la costruzione
del campo, sia le selezioni sulla rampa.
Quattro foto sono della resistenza interna al campo, inviate in Occidente, insieme
a notizie su tutto ciò che avveniva nel campo, compresi i nomi dei comandanti
delle SS che furono letti nei programmi di Radio Londra.
Infine le foto prese alla liberazione del campo dai sovietici, insieme con le
foto e i documenti sotterrati dai Sonderkommando
vicino ai crematori e recuperate nel dopoguerra.
I sopravvissuti alla prima selezione venivano immessi nel campo con numeri di
matricola in ordine crescente, tatuato sul braccio. Furono registrare circa 405.000
persone.
Nel documento di ingresso, venivano apposte tre foto dell'internato. Il libro
ne mostra alcune delle circa 60.000 superstiti.
Il libro è curato dal Museo di stato Auschwitz-Birkenau.
Bibliografia
KL Auschwitz za lata 1942-1980
PMO, Auschwitz, 1991
Questo repertorio bibliografico, curato dal Museo di
stato di Auschwitz, segnala tutti gli articoli ed i libri riguardanti il Lager
di Auschwitz, dal 1942 al 1980.
Il numero di opere (quasi 2000 titoli) indica, già di per sè, lo
sforzo enorme di ricordare e di descrivere.
Danuta Czech
Kalendarz Wydarzen w KL Auschwitz
Wydawnictwo Panstwowego Muzeum w Oswiecimiu-Brzezince,
1992
Il museo di Auschwitz ha pubblicato un importantissimo testo, il
Calendario, nel quale tutti i fatti sicuramente accertati
della storia del campo vengono segnalati in ordine cronologico, giorno per giorno.
Anche i numeri dei convogli giornalieri ferroviari in arrivo insieme ai numeri
di matricola degli immessi nel campo, dopo le selezioni, sono indicati in quest'opera.
Questo studio esiste, per ora, solo in lingua polacca.
Il volume segnala, al 23 ottobre 1943, l'arrivo del primo convoglio da Roma, con
1035 ebrei romani. Di essi vengono immessi nel campo 149 uomini, con i numeri
da 158491 a 158639, e 47 donne, con i numeri da 66172 a 66218. Gli altri 839 vengono
immediatamente condotti alle camere a gas ed uccisi.
Till
Bastian
Auschwitz e la “menzogna su Auschwitz”
Bollati Boringhieri, Torino, 1995
Till Bastian, allo scopo di confutare
i cosiddetti revisionisti (coloro che cercano di minimizzare la portata dello
sterminio), ripercorre, a partire dagli studi di Danuta
Czech, le principali date del campo di
Auschwitz:
Il 20 maggio 1940 giunge ad Oswiecim il sergente maggiore delle SS Gerhard
Palitzsch, futuro caporapporto del campo di concentramento, accompagnato da
30 “detenuti criminali tedeschi” provenienti dal campo di Sachsenhausen.
Costoro vengono nominati “prigionieri funzionari”; sono la longa manus delle SS,
e instaureranno nel campo un regime di terrore. Bruno Brodniewitsch,
prigioniero con il numero di matricola I, ottiene la funzione di “anziano del
campo”.
14 giugno 1940: mentre i soldati tedeschi entrano a Parigi e sfilano sugli Champs-Elysées,
i primi detenuti polacchi giungono al campo di concentramento di Auschwitz:
728 persone provenienti dalla prigione di Darnow, che ricevono i numeri
dal 31 al 758. Il capitano delle SS Karl Fritsch li “saluta” con un discorso
in cui tra l'altro dice: “Non siete venuti in un sanatorio, ma in un campo di
concentramento tedesco, da cui non si esce che per il cammino del crematorio!”
7 luglio 1940: muore nel campo di concentramento di Auschwitz il primo
prigioniero, giunto dal carcere di Wiswicz Nowy con un convoglio di 313
prigionieri politici (che ricevono i numeri dal 759 al 1071): era l'ebreo polacco
David Wingoczweski. Durante un appello di punizione, crolla dopo molte
ore in cui è stato costretto a restate ininterrottamente in piedi. L'appello,
durato 20 ore, era stato ordinato a causa della fuga di un altro prigioniero.
1 marzo 1941: Heinrich Himmler ispeziona per la prima volta personalmente
il campo di concentramento di Auschwitz e ordina al comandante Hoess
tra l'altro:
- di ristrutturare l'attuale campo di Auschwitz in modo di far posto a
30.000 prigionieri (si chiamerà poi “campo principale” o “Auschwitz 1”);
- di costruire sul terreno del villaggio Brzezinka (=“Birken-Au”) un secondo
campo destinato inizialmente a 100.000 prigionieri di guerra (poi chiamato “Auschwitz-Birkenau”
o “Auschwitz II);
- di destinare 10.000 prigionieri ai lavori di costruzione della fabbrica della
IG-Farben, alloggiandoli nelle caserme del villaggio Monowice (“Auschwitz-Monowice”
o “Auschwitz III”).
18 luglio 1941: per la prima volta giungono ad Auschwitz alcune centinaia di prigionieri
di guerra sovietici che vengono sistemati nel Blocco 11; nel giro di pochi giorni
vengono tutti fucilati o uccisi in altro modo.
29 luglio 1941 (data probabile): Hoess conferisce con Himmler a
Berlino.
agosto 1941: Karl Adolf Eichmann, capo della “Sezione Ebrei” della Direzione
centrale per la sicurezza nazionale, incontra Hoess ad Auschwitz per discutere
i dettagli del programma di annientamento. Entrambi si rendono perfettamente conto
che è impossibile procedere a fucilazioni di massa, per il rischio che
a lungo andare l'uccisione di donne e bambini avrebbe finito col pesare eccessivamente
sui soldati delle SS! E così essi preferiscono lo sterminio con il gas
asfissiante.
3 settembre 1941 (data probabile): circa 250 prigionieri selezionati dal medico
del campo Dottor Siegfried Schwela nell'infermeria, e 600 prigionieri di
guerra sovietici vengono uccisi con Zyclon B nelle celle situate negli scantinati
del Blocco 11. “Io stesso ho assistito all'operazione protetto da una maschera
antigas. La morte avveniva nelle celle stipate al massimo subito dopo l'immissione
del gas. Solo un grido breve e già soffocato, ed era tutto finito” (Hoess).
Questo ricordo, sottoscritto nella prigione di Cracovia dal Comandante del lager,
in seguito giustiziato sul piazzale del campo da lui comandato, non corrisponde
completamente a verità: giacche la mattina del 4 settembre il caporapporto
Gerhard Palitzsch, che ha aperto le porte delle celle protetto dalla maschera
antigas, constata che alcuni prigionieri sono ancora in vita; le porte quindi
vengono di nuovo chiuse e viene immesso nuovo gas Zyklon B. Nella notte i cadaveri
vengono portati nel crematorio e bruciati; l'operazione dura alcuni giorni.
11 novembre 1941: il giorno della festa nazionale polacca nei locali del Blocco
11 il Rapportführer Gerhard Palitzsch uccide 151 detenuti polacchi
con un colpo alla nuca sparato da una pistola di piccolo calibro.
15 febbraio 1942: giunge ad Auschwitz il primo convoglio di ebrei destinati allo
sterminio. Un numero imprecisato di persone viene ucciso con Zyklon B nelle camere
a gas del crematorio I del campo principale di Auschwitz; i cadaveri vengono inceneriti.
4 luglio 1942: la direzione del campo di concentramento di Auschwitz escogita
il metodo della “selezione sulla banchina ferroviaria”. Da un convoglio di ebrei
provenienti dalla Slovacchia - circa 1000 persone - vengono selezionati 264 uomini
e 108 donne abili al lavoro; gli altri (donne incinte, bambini sotto i 14 anni,
malati e vecchi) vengono condotti alle camere a gas e uccisi. la selezione viene
fatta da un medico delle SS dopo aver fatto schierare i nuovi venuti - separando
gli uomini dalle donne - lungo i marciapiedi.
4 marzo 1942: mentre nuovi convogli continuano ad arrivare incessantemente ad
Auschwitz per la selezione in prigionieri “da utilizzare” e altri “da eliminare”,
quel giorno vengono inaugurati per la prima volta i forni del nuovo crematorio
II ad Auschwitz-Birkenau. Il 13 marzo nella camera a gas del crematorio vengono
uccise 1500 persone tra uomini, donne e bambini del ghetto B di Cracovia. le camere
a gas e il crematorio, che hanno una capacità di 2000 persone, il 31 marzo
passano ufficialmente dalla Direzione centrale dell'edilizia all'amministrazione
locale del campo di concentramento. Questo passaggio era già avvenuto il
22 marzo per il crematorio IV al quale erano aggregate tre camere a gas con capacità,
rispettivamente, di 1500, 800 e 150 persone.
4 aprile 1943: il crematorio V, strutturalmente uguale al crematorio IV, viene
trasferito all'amministrazione locale e lo stesso avviene per il crematorio III
(strutturalmente uguale al crematorio II). Il maggiore delle SS Karl Bischoff,
che dirige i lavori di costruzione, comunica a Berlino che in questo modo ad Auschwitz
si sarebbe riusciti ad incenerire 4756 cadaveri in 24 ore.
Autunno 1943: i campi di sterminio di Sobibor e di Treblinka, posti
a 300 chilometri a nord-est di Auschwitz sul confine orientale del Governatorato
generale di Polonia, cessano la loro opera di sterminio. Il campo di sterminio
di Belzec, anch'esso sul Bug, è stato smantellato già nel
dicembre 1942 (come risulta... con tutta probabilità a Belzec sono state
uccise con il monossido di carbonio 600.000 persone, a Sobibor 250.000 e a Treblinka
974.000, quasi tutti ebrei...; in alcuni di questi campi non esistevano crematori
e i cadaveri venivano bruciati in grandi fosse). Dopo la fine dei massacri in
questi campi, il campo di concentramento di Auschwitz-Birkenau diventa il più
grande centro di sterminio che il mondo abbia mai visto.
Rudolf Hoess, che aveva visitato personalmente il campo di sterminio di
Treblinka, andò fiero fino alla sua morte dei miglioramenti che
aveva saputo apportare ad Auschwitz rispetto ad altri campi:
“Il comandante del lager di Treblinka mi disse che nel giro di sei mesi avrebbe
eliminato 80.000 prigionieri. Il suo compito principale era l'eliminazione di
tutti gli ebrei del ghetto di Varsavia: Impiegava come gas il monossido, e a suo
parere i suoi metodi non erano molto efficaci. Quando io costruii l'impianto di
sterminio di Auschwitz, adoperai lo Zyklon B (...). Un altro miglioramento consistette
nella costruzione di camere a gas capaci di contenere 2000 persone in una sola
volta, mentre le dieci camere a gas di Treblinka riuscivano a contenerne soltanto
200 alla volta (Hoess, dichiarazione giurata dinanzi al tribunale di Norimberga,
5 aprile 1946).
19 marzo 1944: l'Ungheria viene occupata dalle truppe tedesche; immediatamente
anche gli ebrei ungheresi fino a quel momento risparmiati, vengono inclusi nel
programma della “soluzione finale”. Dal maggio 1944, 400.000 ebrei ungheresi -
una cifra confermata anche da Hoess nel suo memoriale di Cracovia - vengono deportati
ad Auschwitz e quasi senza eccezione uccisi nelle camere a gas. Per facilitare
la selezione e abbreviare il tragitto verso le camere a gas viene costruita ad
Auschwitz-Birkenau quella banchina ferroviaria a tre marciapiedi che si può
vedere ancora oggi. “In media giungono a Birkenau 10.000 persone al giorno (...).
Tutti i crematori lavorano al massimo” (Broad). Si arriva a uno sterminio
di massa che neanche Auschwitz ha mai visto in questa forma” (id.). Poiché
la capacità delle camere a gas e dei crematori in particolare non sempre
è sufficiente, per le continue riparazioni di cui hanno bisogno, viene
rimesso in funzione il Bunker n.2 (la “casetta bianca”). Nel vicino bosco di betulle
vengono scavate numerose fosse di grandi dimensioni nelle quali giorno e notte
si bruciano i cadaveri. Per accellerarne l'incenerimento, i prigionieri delle
squadre speciali incaricate di questi compiti prelevano il grasso che fuoriesce
dai cadaveri che bruciano, e lo spargono di nuovo sui corpi.
2 maggio 1944: giungono ad Auschwitz un primo e un secondo trasporto di ebrei
ungheresi; dopo la selezione, 2698 vengono avviati alle camere a gas.
Il 26 maggio 1944 l'arrivo e il destino di tali convogli viene fotografato dalle
SS. Dalle fotografie, tra l'altro, è possibile individuare il medico di
campo delle SS Thilo che procede alla selezione sulla banchina.
2-3 agosto 1944: nel pomeriggio del 2 agosto, su 4000 zingari che si trovano in
quel periodo ad Auschwitz (circa 3000 nel “campo per famiglie di zingari BIIe”
a Birkenau), 1408 - 918 uomini e 490 donne - vengono portati alla banchina ferroviaria
dove li attende un treno merci vuoto; alle 19 il treno lascia Birkenau in direzione
Buchenwald, dove arriva il giorno dopo. Dopo l'appello serale giunge l'ordine
di chiudere nelle baracche tutti i prigionieri del campo di Auschwitz-Birkenau
e quelli del “campo per famiglie di zingari BIIe”. Il campo viene circondato dalle
SS. nella notte 2897 donne, uomini e bambini vengono trasferiti con dei camion
nelle camere a gas e uccisi; poiché i forni del crematorio in quel momento
non funzionano, i cadaveri vengono bruciati all'aperto.
Gli “zingari” sono ancora oggi ritenuti vittime di Auschwitz di seconda classe.
Essi avevano un numero di matricola a parte, che era preceduto dalla lettera Z.
Il loro calvario e la loro morte viene spesso dimenticata nelle esposizioni ufficiali.
18 gennaio 1945: il prigioniero Engelbert Marketsch viene trasferito dal
campo di concentramento di Mauthausen ad Auschwitz e riceve l'ultimo numero di
matricola dato a un prigioniero: il numero 202499. Su 32.000 prigionieri che in
quel periodo si trovano ancora ad Auschwitz, la maggior parte viene evacuata;
lo stesso avviene ad Auschwitz-Monowitz (oltre 35.000 prigionieri). Complessivamente
quasi 60.000 prigionieri vengono trasferiti in campi di concentramento posti in
zone più orientali, o a marce forzate o dopo giorni di viaggio in treni
merci con vagoni talvolta scoperti; in queste marce di evacuazione trovano la
morte ancora 10.000 prigionieri.
27 gennaio 1945: quel sabato, alle 9 di mattina, compare il primo soldato sovietico
sulla spianata del campo di concentramento. Auschwitz è liberata. Circa
7.000 prigionieri malati ed esausti si trovano ancora nel lager. Quasi 1.000 muoiono
nei giorni e nelle settimane successive.
Jean
Claude Pressac
Le macchine dello sterminio
Feltrinelli, Milano, 1994
L'autore, che era stato un “revisionista”, avendo avuto accesso agli archivi della
Bauleitung (la Direzione delle
costruzioni) di Auschwitz, ora in mano sovietica, ricostruisce l'aspetto tecnico
del processo di sterminio.
Secondo il suo lavoro, la stima dei morti, per il solo campo di
Auschwitz, oscilla da 631.000 a 711.000 persone uccise,
di cui da 470.000 a 550.000 ebrei gassati, non iscritti nei registri del campo
(e, quindi, il numero più variabile), 126.000 internati registrati deceduti,
per stenti o fucilazione o altro (ebrei e non ebrei), 35.000 fra prigionieri di
guerra sovietici, zingari, e altre categorie. La sua stima è la più
bassa fra tutti gli studiosi del campo.
Ber
Mark
Des voix dans la nuit. La résistance juive a
Auschwitz-Birkenau
Plon, Parigi, 1982
Il testo è composto di due parti. La prima è
uno studio documentatissimo di tutto ciò che si sa sul movimento ebraico
di resistenza interno al campo.
La seconda parte pubblica i documenti di Zalman Gradowski,
Zalman Lewental e
Leib Langfus, ebrei del Sonderkommando
di Auschwitz-Birkenau, che
sotterrarono i loro scritti vicino ai crematori, prima di essere uccisi.
Nella prefazione al volume Elie Wiesel
così scrive:
Allora io ignoravo, oggi lo so: l'inferno non è lo stesso dappertutto.
Esistono mille modi di subire il terrore e di attendere la morte. Bruciare cadaveri
è fra i più crudeli. Il Sonderkommando bruciava cadaveri.
Gli assassini tedeschi uccidevano e i becchini prendevano le vittime e le gettavano
nei forni. Poi, dopo qualche settimana, gli assassini prendevano i becchini e
li sostituivano con dei nuovi arrivati. E il cielo lassù diventava cenere.
E in basso, in campo, noi ci domandavamo: come può un essere umano fare
questo lavoro senza degradarsi, senza provare odio e disgusto verso se stesso?
Nessuno poteva risponderci per la semplice ragione che un abisso separava i becchini
da noialtri detenuti. Noi non potevamo capirli. Io continuo a non capirli, eppure
ho letto da allora tanti diari e racconti che alcuni di loro ci hanno lasciato.
Ne ho letti degli estratti in jiddish quando furono scoperti negli anni sessanta;
li rileggo adesso in traduzione francese. Finita la lettura, mi sento incapace
di accostarmi a un'altra opera o di fare un'altra cosa. Mi chiudo in me stesso
e ascolto i cronisti del Sonderkommando: Zalman Gradowski, Zalman
Lewental e Leib Langfus. Ed è come se li vedessi davanti
a me: ciascuno ha il suo stile, la sua lingua, la sua collera. Ciò che
hanno in comune è un bisogno irresistibile di deporre per la Storia e anche,
a volte, di giustificarsi davanti ad essa. “... tuttavia in campo ci siamo profondamente
intesi sulla natura del nostro destino e meglio ancora sul nostro dovere
- dice Zalman Lewental. - Ci siamo, è vero, consultati a lungo per
decidere se dovevamo ancora continuare questa vita... Abbiamo deciso che ognuno
di noi non doveva restare passivo e che un fine doveva essere stabilito”.
Il fine? Preparare l'insurrezione, scrivere fatti e impressioni, nomi e cifre
di comunità annientate; in breve: assumersi la doppia condizione di vittime
e testimoni.
Zalman Gradowski supplica, in un
frammento, perché ogni testo sia ritrovato:
Cercatore, cerca dappertutto, in ogni briciola di terra. Documenti, i miei e quelli
di altre persone, vi sono sepolti, documenti che gettano una luce cruda su tutto
quello che è accaduto qui...
Nel dovere di raccontare sembra assumere un senso anche la vita
di questi uomini.
Conoscono l'angoscia e il dubbio, la nostalgia e il rimorso, conoscono perfino
la speranza: per questo si armano, per questo scrivono. La loro ossessione: resistere
al carnefice, combattendo l'oblio. “Bisogna che gli uomini sappiano e se ne ricordino;
bisogna”. La crudeltà sistematica e omicida degli assassini, l'agonia lenta
e lucida delle vittime, la generosità dei bambini, il coraggio delle ragazze
nelle camere a gas: bisogna che le generazioni future sappiano. “Ricordatevi che
siamo andati alla morte con molta fierezza e in perfetta coscienza” disse una
giovane ebrea polacca ai membri del Sonderkommando: Leib Langfus
l'ha udita. Così come ha udito gli ebrei e i polacchi cantare i loro inni
nazionali.
Il tempo non ha conservato intatti questi documenti.
Nessun documento contiene altrettante domande; nessun volume è stato composto
con maggior rigore o lucidità. Le cancellature, gli stessi spazi bianchi
hanno la loro importanza; e il loro peso simbolico. Dal momento che i manoscritti
sono danneggiati - dall'umidità, dalla terra e dal tempo - non sapremo
mai tutto ciò che uno Zalman Lewental voleva comunicarci. Di Auschwitz
non si saprà mai tutto. Certe esperienze non si comunicano, e certamente
non con la parola. Solo chi ha vissuto Birkenau si ricorderà di Birkenau.
Chi non ha visto i suoi amici andarsene per diventare becchini o fumo non capirà
mai perché la vista di una semplice ciminiera ci fa respirare faticosamente.
Questi racconti li leggerete con affanno, e non vi lasceranno più.
Leon
Poliakov
Auschwitz
Veutro editore, Roma, 1968
Poliakov descrive il campo di Auschwitz
e pubblica importanti testimonianze relative ad esso. Così
Dow Paisikovic, originario della Cecoslovacchia, racconta
della sua fuga e della vita dei Sonderkommando,
nella deposizione resa al processo di Auschwitz
il 17 ottobre 1963:
Fino all'evacuazione da Auschwitz si salvarono in tutto 82 elementi del
Sonderkommando: eravamo noi, quelli del crematorio II. Al momento dell'evacuazione,
18.1.1945, il presidio SS era già in piena disorganizzazione. Noi ne approfittammo
per scappare nel campo D. Nella corsa, un buon numero fu ucciso dai proiettili,
non saprei dire quanti, perché mi preoccupavo solo di arrivare al più
presto al campo. Tutti i prigionieri del campo D furono portati nel campo principale
di Auschwitz; è la che le SS, di notte, si mettevano alla ricerca di coloro
che erano stati addetti ai crematori e che essi erano in grado di riconoscere
per aver fatto parte del Sonderkommando. Naturalmente nessuno si presentava
all'appello. Chiunque venisse scoperto era immediatamente fucilato. Io e mio padre
ci nascondemmo sotto un letto. Non posso dire altro, se non che anche Filip
Muller e Bernard Sakal (che ora vive in Israele ed è originario
di Bialystok) hanno potuto salvare la vita.
Al Sonderkommando II c'era anche un certo Léon, il cuciniere,
un ebreo polacco che aveva vissuto a Parigi; era esonerato dal lavoro del Sonderkommando
perché addetto alla cucina delle SS. Era obbligato al servizio del crematorio
solo se c'era veramente molto lavoro. Eravamo molto legati e, per questo, sapevo
che Léon aveva preso degli appunti fin dal momento in cui fu destinato
al Sonderkommando. Ha tenuto una specie di diario ed ha preso nota dei
delitti delle SS ed anche di alcuni nomi di criminali SS. Inoltre ha raccolto
documenti, passaporti, ecc., trovati nei vestiti degli assassinati e che gli sembravano
importanti. Nessuno di noi ha letto quegli appunti ma io sapevo che esistevano.
Il mercoledì precedente la rivolta io ho sotterrato tutti i documenti in
un posto che ho fissato con cura nella mia memoria.
Le carte erano in un grande recipiente di vetro (della capacità di cinque
litri circa), ingrassato ed ermeticamente chiuso e messo in una cassa di cemento
appositamente colato, spalmata all'interno di grasso e poi chiusa con cemento.
Vi abbiamo messo anche capelli, denti, ecc., presi dalle salme ma nessun oggetto
di valore per evitare che coloro che un giorno abbiano a trovare la cassa non
siano tentati di farla sparire per appropriarsi dei valori. Il rabbino di Makow
e Zalmen Rosenthal presero altri appunti che vennero sotterrati altrove
- non so dove.
Per finire vorrei descrivere come si svolgeva un'operazione di gassaggio. Abbiamo
visto come si procedeva alle selezioni all'arrivo dei convogli alla banchina.
Quelli che erano selezionati per il lavoro venivano portati ai settori C e D del
campo, quelli destinati alle camere a gas venivano invece portati al FKL (campo
di concentramento femminile). Quanti erano in grado di marciare arrivavano al
crematorio a piedi, gli altri erano caricati su autocarri. Al crematorio si faceva
ribaltare l'autocarro e si gettavano a terra i malati. Un'ambulanza con la Croce
Rossa portava i recipienti del gas.
I deportati venivano condotti negli spogliatoi e le SS ordinavano di spogliarsi.
Gli si diceva che dovevano lavarsi. Ogni gancio degli spogliatoi portava un numero
che le vittime erano invitate a tenere bene in mente. Tutti quelli che avevano
ancora con sè dei pacchi dovevano depositarli davanti agli spogliatoi.
Questi effetti erano poi trasportati al Canada con automezzi. Si cominciava
sempre dalle donne e dai bambini. Appena spogliati, le SS li portavano alla camera
a gas. Gli dicevano che bisognava aspettare che arrivasse l'acqua. Poi si dovevano
spogliare gli uomini e andare anche loro nella camera a gas. Ognuno doveva legare
le scarpe e portarle con sé. Prima di entrare nella camera a gas, passando,
doveva consegnare le scarpe a due prigionieri addetti alla raccolta.
La maggior parte non sapeva quale sorte li aspettasse. Qualche volta invece lo
sapevano e allora, per lo più, pregavano. A noi era proibito parlare con
i deportati dei convogli. Dopo che le donne si erano spogliate ed erano entrate
nella camera a gas, un Kommando composto da noi doveva prendere i vestiti e portarli
al Canada; gli uomini venivano così introdotti in uno spogliatoio
vuoto, che aveva tutta l'apparenza di un vero e proprio spogliatoio. Quelli che
non erano in grado di spogliarsi da soli dovevano venire aiutati da prigionieri
del nostro Kommando. Per ogni due di noi c'era una SS di sorveglianza.
A questo lavoro venivano destinati soltanto prigionieri che alle SS sembrassero
particolarmente degni di fiducia. Inoltre ad ogni gassaggio presenziavano numerosi
ufficiali SS.
Il gas veniva immesso, nel nostro crematorio, dall'Olandese o dal
rosso, che si davano il cambio. Si mettevano la maschera antigas.
Spesso il gas non arrivava al momento giusto. Le vittime allora dovevano aspettare
abbastanza a lungo nella camera a gas. Si sentivano le grida da molto lontano.
Spesso le SS si abbandonavano anche ad eccessi particolarmente sadici. Fucilavano
i bambini nelle braccia delle madri proprio davanti alla camera a gas oppure li
sbattevano contro il muro. Se una vittima diceva una sola parola contro le SS,
era fucilata sul posto. Di solito questi eccessi avevano luogo solo quando erano
presenti degli ufficiali superiori. Quando la camera a gas era troppo piena, spesso
vi venivano lanciati dentro, al di sopra delle teste di quelli che già
vi erano ammassati, dei bambini che altrimenti non avrebbero potuto entrarci.
Per effetto dell'eccessivo ammassamento delle vittime, alcune morivano calpestate.
Le SS ci ripetevano spesso che non avrebbero lasciato sopravvivere alcun testimone.
Paisikovic conclude con la formula
dei testimoni del processo sui fatti di Auschwitz:
Questa descrizione corrisponde perfettamente, in ogni suo punto, alla verità
ed è stata da me fatta in fede e coscienza.
Hermann
Langbein
Uomini ad Auschwitz
Mursia, Milano, 1984
H. Langbein, internato austriaco,
in Auschwitz 1, membro del
movimento clandestino di resistenza e segretario del dott.
Wirths, ufficiale medico delle SS, scrive questo libro
nel 1972.
Così Primo Levi commenta
la sua opera:
Il libro si distanzia nettamente da tutte le opere finora comparse sull'argomento
per il suo estremo sforzo di obiettività... Il titolo originale, Menschen
in Auschwitz, è pregnante, e comprende in sé l'assunto e la
specificità dell'opera, perché Mensch è, in tedesco,
l'essere umano...
Langbain studia l'uomo relegato in condizioni estreme. Tali sono i prigionieri
entro il filo spinato, ma tali sono anche i componenti della costellazione degli
aguzzini, giunti anch'essi, volontariamente o no, agli estremi confini di quanto
un uomo può commettere o sentire.
Su loro Langbein si curva, con severa curiosità, non solo per condannarli
o assolverli, ma in un disperato sforzo di capire come si possa arrivare a tanto.
E' forse il solo tra gli storici moderni che abbia dedicato tanta attenzione a
questo tema.
La sua conclusione è inquietante. I grandi responsabili sono Menschen
anche loro; la materia prima di cui sono costituiti è la nostra, e per
trasformarli in freddi assassini di milioni di altri Menschen non è
occorsa molta fatica né autentica costrizione: è bastato qualche
anno di scuola perversa e la propaganda del dott. Goebbels. Salvo eccezioni non
sono mostri sadici, sono gente come noi, irretiti dal regime per la loro pochezza,
ignoranza o ambizione.
Pochi sono anche i nazisti fanatici, poiché il periodo che Langbein trascorre
ad Auschwitz, il “più denso di avvenimenti”, dal 1942 al 1944, è
anche quello del declino dell'astro di Hitler davanti alle sconfitte militari.
Il testo raccoglie tutti i fatti di cui
Langbein è stato testimone, insieme ad un numero
impressionante di fatti relativi ad altre persone, sia deportati, sia tedeschi,
di cui l'autore è venuto a conoscenza.
Questa è la storia di Alma Rosé
e dell'orchestra femminile di Birkenau:
Anche nel Lager femminile di Birkenau fu costituita un'orchestra. Dato che la
capo Lager Mandel era particolarmente amante della musica, questa
orchestra poté essere diretta da un'ebrea, Alma Rosé, il
cui padre era stato il primo violino dei Wiener Philarmoniker e aveva diretto
il celebre quartetto Rosé. Alma continuò la tradizione
di famiglia. Si sposò con un olandese e da quel paese venne deportata nel
1943. Ad Auschwitz venne internata nel Blocco sperimentale 10. Un giorno si stava
organizzando la festa di compleanno di un pezzo grosso e fu chiesto se qualcuno
sapesse suonare il violino. La Rosé si fece avanti. Il suo virtuosismo
fece una tale impressione sulle sorveglianti che avevano presenziato alla festa
che esse parlarono della Rosé alla capo Lager. Essa la fece trasferire
al Lager femminile e la nominò capo dell'orchestra...
Benché Alma Rosé si trovasse in una posizione notevolmente
meno privilegiata del suo collega nel Lager principale, il capo-cuciniere polacco
Nyerichlo, non ricercò mai il favore della direzione del Lager in
modo così servile come lui. Al contrario: accadde che, durante un concerto,
si interrompesse nel bel mezzo perché un gruppo di sorveglianti SS chiacchierava
e rideva ad alta voce. Quando le amiche le fecero notare che avrebbe potuto essere
punita per quest'atto, ella rispose semplicemente: “Così non posso suonare”.
Le sorveglianti presero atto in silenzio di questo rimprovero della prigioniera
Rosé.
Manca Svalbovà paragona la Rosé ad un uccello che non riusciva
ad abituarsi ad essere tenuto in gabbia e che continuamente sbatteva le ali ferendosi
a sangue. Il Lager non risparmiò neppure questa sensibile artista che,
nel mare di baracche di Birkenau, viveva nel suo mondo di musica come su un'isola.
Alma Rosé morì il 4 aprile 1944. Ancora il giorno prima era
in salute. Intorno alla sua morte fiorirono leggende. Alcuni suppongono che si
sia avvelenata. La Rosé aveva fatto spesso visita al Lager per famiglie
di Theresienstadt. Quando, alcune settimane prima, quelli che vi erano internati
erano stati mandati alle camere a gas, essa ne era stata sconvolta. Altri invece
sostengono di sapere che ella fu avvelenata da sorveglianti delle internate che
erano gelose di lei.
Rudolf
Hoess
Comandante ad Auschwitz. Memoriale autobiografico di
Rudolf Hoess
Einaudi, Torino, 1985
... nell'estate del 1941 Himmler gli comunica “personalmente”
che Auschwitz sarà qualcosa di diverso da un luogo d'afflizione:
deve diventare “il più grande centro di sterminio di tutti i tempi”: si
aggiusti lui, con i suoi collaboratori a trovare la tecnica migliore.
Hoess non batte ciglio, è un ordine come gli altri, e gli ordini
non si discutono. Ci sono già esperienze condotte in altri campi, ma i
mitragliamenti in massa e le iniezioni tossiche non sono convenienti, ci vuole
qualcosa di più rapido e sicuro; soprattutto, bisogna evitare i bagni di
sangue, perché demoralizzano gli esecutori. Dopo le azioni più sanguinose
alcuni SS si sono uccisi, altri si ubriacano metodicamente; ci vuole qualcosa
di asettico, di impersonale, per salvaguardare la salute mentale dei militi.
L'asfissia collettiva con i gas di scarico dei motori è un buon inizio,
ma va perfezionata. Hoess ed il suo vice hanno l'idea geniale di usare il Cyclon
B, il veleno che si usa per i topi e le blatte, e tutto va per il meglio. Hoess,
dopo il collaudo eseguito su 900 prigionieri russi, prova un “grande conforto”:
l'uccisione in massa è andata bene, sia come quantità che come qualità;
niente sangue, niente traumi. Tra il mitragliare gente nuda sul bordo di una fossa
da loro stessi scavata, e il buttare una scatoletta di veleno dentro un condotto
d'aria, la differenza è fondamentale. La sua massima aspirazione è
raggiunta: la sua professionalità è dimostrata, è lui il
miglior tecnico della strage. I colleghi invidiosi sono sconfitti.
Le pagine più ripugnanti del libro sono quelle in cui Hoess si attarda
a descrivere la brutalità e l'indifferenza con cui gli ebrei addetti allo
sgombero dei cadaveri attendono al loro lavoro. Contengono un immondo atto d'accusa,
una chiamata di correo, quasi che quegli infelici (non erano esecutori d'ordini
anche loro?) potessero addossarsi la colpa di chi li aveva inventati e delegati.
Il nodo del libro, e la sua bugia meno credibile, sta (in questo punto): davanti
all'uccisione dei bambini, dice Hoess, “provavo una pietà cosi immensa
che avrei voluto scomparire dalla faccia della terra, eppure non mi fu lecito
mostrare la minima emozione”. Chi gli avrebbe impedito di “scomparire”?
Neppure Himmler, il suo capo supremo, che, malgrado l'ossequio che Hoess gli tributa,
traspare da queste pagine nel doppio aspetto del demiurgo e di un idiota pedante,
incoerente ed intrattabile.
Neppure nelle ultime pagine, che assumono il tono di un testamento spirituale,
Hoess riesce a misurare l'orrore di quanto ha commesso, ed a trovare l'accento
della sincerità.
“Oggi comprendo che lo sterminio degli ebrei fu un errore, un colossale errore”
(si noti non “una colpa”). “L'antisemitismo non è servito a nulla, al contrario
il giudaismo se ne è giovato per avvicinarsi maggiormente al suo obiettivo
finale”.
Poco dopo afferma di sentirsi “venir meno” nell'”apprendere quali spaventose torture
si applicassero ad Auschwitz ed in altri campi”: se si pensa che chi scrive così
sa già che sarà impiccato, si rimane attoniti davanti a questa sua
ostinazione di mentire fino all'ultimo respiro. L'unica spiegazione possibile
è questa, Hoess, come tutti i suoi congeneri..., ha trascorso la vita facendo
sue le menzogne che impregnavano l'aria a cui attingeva, e quindi mentendo a sé
stesso.
Questo il commento di Primo Levi,
nella prefazione all'edizione italiana del libro.
Hoess passa completamente sotto silenzio alcuni aspetti
della vita del campo. Come nella maggior parte dei memoriali delle SS, viene taciuta
la corruzione presente ai massimi livelli di questo corpo. Mentre si dichiara
l'obbedienza assoluta alla gerarchia nazista e agli “ideali” della nazione tedesca,
in realtà essa è trasgredita continuamente, per interessi privati
o familiari, come il benessere e l'arricchimento.
Così descrive questo aspetto Hermann Langbein,
in Uomini ad
Auschwitz:
Come comandante egli ha spesso ripetuto ai suoi sottoposti il rigido divieto di
Himmler di impossessarsi di beni altrui. Stanislaw Dubiel riferisce
come si comportava lo stesso Hoess. Se il comandante dava un ricevimento,
la signora Hoess diceva a Dubiel di quali generi alimentari avesse
bisogno. Dubiel descrisse poi davanti a un tribunale polacco come se li
doveva procurare:
All'inizio io portavo la roba in un cesto fuori del magazzino
dei viveri per gli internati, gestito dall'Unterscharfuhrer
Schebeck; più tardi utilizzavo un'auto. Dal
deposito dei generi commestibili portavo fuori, per l'uso privato di casa
Hoess, zucchero, farina, margarina, diversi tipi di
lievito, verdure per minestra, pasta, fiocchi d'avena, cacao, cannella, piselli
e altri prodotti. La signora Hoess
non era mai soddisfatta, mi parlava in continuazione di quello che ancora le mancava
per il suo ménage domestico. I generi alimentari che io procuravo non li
usava solo per casa sua, ma li spediva anche a diversi suoi parenti in Germania.
Dovevo anche preoccuparmi di rifornire la cucina di casa
Hoess di carne dal macello e di latte sempre fresco.
Per tutto quello che andava a finire in casa sua dai depositi di commestibili
e dal macello del Lager Hoess
non ha mai pagato nulla.
Ogni giorno Dubiel portava a Villa Hoess dalla latteria del Lager cinque
litri di latte. In base alle tessere, alla famiglia Hoess sarebbe spettato solo
un litro e un quarto. Nel corso di un anno Dubiel dovette “organizzare”
tre sacchi di zucchero da 85 kg l'uno. A Villa Hoess ebbe modo di vedere casse
che contenevano ciascuna 10.000 sigarette della marca jugoslava Ibar. Con queste
sigarette, ufficialmente destinate allo spaccio degli internati, la signora
Hoess si pagava qualche lavoro nero fatto dai prigionieri. Aveva inculcato
a Dubiel che nessun uomo delle SS sarebbe dovuto venire a sapere qualcosa
di tutto ciò, in quanto Hoess aveva vietato non solo di “organizzare”,
ma anche di effettuare lavori neri e aveva minacciato severissime punizioni. Marta
Fuchs, una sarta che era stata deportata da Bratislava per motivi razziali,
dovette lavorare diversi mesi in casa Hoess con alcune aiutanti. Una camera sulla
mansarda venne attrezzata come sartoria. Le stoffe venivano apertamente portate
fuori del Kanada.. Un'altra ebrea, soprannominata Manza, aveva lavorato
come pettinatrice presso la signora Hoess. Essa approfittò di questa
tendenza a far lavorare gli internati per sé e convinse la signora Hoess
a richiedere ancora qualcuna che facesse lavori di maglieria per i suoi figli.
Così un'altra prigioniera poté arrivare a un posto di lavoro sicuro
e protetto e la signora Hoess poté avere una schiava personale in
più. Dopo che si era sparsa la voce di lavori neri nella villa del comandante,
la signora Hoess fece attrezzare una sartoria nell'edificio del comando
e lì si continuò a lavorare, cosa che offrì anche ad altre
mogli di ufficiali la possibilità di approfittarne. Tuttavia anche durante
questo periodo Marta Fuchs e un'altra sarta furono chiamate per breve tempo
a lavorare a Villa Hoess dov'erano occupate anche due testimoni di Geova, una
come cuoca e l'altra come cameriera. Il nome di una è conosciuto: Sophie
Stipel, di Mannheim.
Emerge una immagine totalmente difforme dallo stereotipo che le
SS hanno addotto per difendersi dai loro crimini, ben diverso dalla realtà
di integerrimi servitori dello Stato, disposti a qualsiasi sacrificio per lo sviluppo
del Reich!
Il direttore medico di Auschwitz, quando la famiglia Hoess se ne andò dal
campo, il 26 novembre 1944, scrisse alla propria famiglia ciò che
Baer, nuovo comandante del campo, aveva riferito:
Lui [il comandante Baer], mi ha raccontato della casa e
del giardino di Hoess; è vergognoso com'era tutto pieno di lusso, senza
senso di responsabilità. Furono necessari due vagoni ferroviari e non so
quante casse per il trasloco! Spiacevole...
Evidentemente non tutti gli ordini di Himmler erano sacri allo
stesso modo per Hoess.
Un fatto ulteriore testimonia della corruzione nei reparti SS
di Auschwitz.
Non poteva essere ignorato neanche da Eichmann quello che tutti sapevano.
Tuttavia egli osò sostenere: “Hoess era la modestia in persona”.
Se possibile ancora più falsa è l'idealizzazione di Eichmann
quando dice: “Hoess conduceva una vita familiare esemplare”. Dovrebbe aver
saputo che uno dei motivi del trasferimento di Hoess era costituito dal
fatto che era stata scoperta una relazione che egli aveva allacciato con una prigioniera
di nome Eleonore Hodys. Il giudice delle SS che dirigeva la commissione
d'inchiesta, Morgen, arrivò a scoprire ad Auschwitz questo fatto
e dichiarò a questo proposito:
Sono sicuro che il trasferimento di
Hoess a Berlino
fosse collegato dal procedimento da me avviato. Evidentemente in questo modo
Pohl voleva ottenere di essere lui il giudice di competenza
per l'operato di Hoess per
poterlo così prendere sotto la sua tutela.
Il dott. Morgen conferma che fu mostrato ad Hoess il protocollo
redatto con la Hodys in merito a questa relazione e al tentativo di Hoess
di mandarla a finire nel Bunker per farla morire di fame dopo che la cosa era
divenuto nota.
Tutto ciò avveniva sotto gli occhi della
sig.ra Hoess, che viveva con il marito in Villa, ai
margini del campo.
Hoess, allontanato dal campo fu
poi richiamato a comandarlo, quando cominciò lo sterminio degli ebrei ungheresi,
di vastissime proporzioni, quello per cui fu allestita la
rampa ad Auschwitz-Birkenau.
Era evidentemente l'unico ritenuto in grado di svolgerlo nel migliore dei modi.
Elie
Wiesel
La notte
Giuntina, Firenze, 1980
Mai dimenticherò quella notte, la prima notte nel campo,
che ha fatto della mia vita una lunga notte e per sette volte sprangata.
Mai dimenticherò quel fumo.
Mai dimenticherò i piccoli volti dei bambini di cui avevo visto i corpi
trasformarsi in volute di fumo sotto un cielo muto.
Mai dimenticherò quelle fiamme che consumarono per sempre la mia Fede.
Mai dimenticherò quel silenzio notturno che mi ha tolto per l'eternità
il desiderio di vivere.
Mai dimenticherò quegli istanti che assassinarono il mio Dio e la mia anima,
ed i miei sogni, che presero il volto del deserto.
Mai dimenticherò tutto ciò, anche se fossi condannato a vivere quanto
Dio stesso. Mai.
Deportato nel 1944, con tutta la famiglia,
Wiesel giunge ad Auschwitz-Birkenau,
dove vede subito sparire la madre e la sorella. Riesce a rimanere insieme al
padre nel campo di Auschwitz-Monowitz,
lo stesso di Primo Levi.
A differenza di quest'ultimo che è in infermeria, quando il fronte russo
costringe i tedeschi alla ritirata, Wiesel insieme a decine di migliaia di deportati
compie la marcia forzata di evacuazione del campo (la maggior parte dei deportati
sopravvissuti morirono in questa marcia).
E' costretto a raggiungere a piedi ed in treno Buchenwald
dove il padre muore tra il 28 e il 29 Gennaio 1945, ormai sfinito. Il 10 aprile
il primo carro armato americano si presenta alle porte di Buchenwald.
Primo
Levi
Se questo è un uomo
Einaudi, Torino, 1986
Primo Levi scrive il suo primo (e unico per
dieci anni) libro nel 1946. Non è un romanzo, e Levi non è uno
scrittore; è una testimonianza, a caldo, dell'anno passato a
Buna-Monowitz, un sottocampo di
Auschwitz.
La sua prosa è lucida, fredda, ciascuna parola è calibrata con
precisione (a mio parere cade a pennello per Levi quello che Guido Ceronetti
dice di Dante: “l'inesorabile monacatura del verso”); Levi rende testimonianza,
è in qualche modo tenuto, costretto a farlo (un sogno-incubo ricorrente
- in Lager e fuori - per moltissimi sopravvissuti è quello di raccontare
quello che si è visto e vissuto, senza essere ascoltati); raramente esprime
un giudizio, lo fa quando parla di una bambina di pochi anni che era con lui
nel campo di transito di Carpi-Fossoli,
e per poche righe, quando parla di Alberto,
il suo magnifico amico, che scompare nella marcia di evacuazione da Auschwitz
nel gennaio del 1945.
Alberto è il mio migliore amico. Non ha che ventidue anni,
due meno di me, ma nessuno di noi italiani ha dimostrato capacità di
adattamento simili alle sue. Alberto è entrato in Lager a testa alta,
e vive in Lager illeso e incorrotto. Ha capito prima di tutti che questa vita
è guerra; non si è concesso indulgenze, non ha perso tempo a recriminare
e a commiserare sé e gli altri, ma fin dal primo giorno è sceso
in campo. Lo sostengono intelligenza e istinto: ragiona giusto, spesso non ragiona
ed è ugualmente nel giusto. Intende tutto al volo: non sa che poco francese,
e capisce quanto gli dicono tedeschi e polacchi. Risponde in italiano e a gesti,
si fa capire e subito riesce simpatico. Lotta per la sua vita, eppure è
amico di tutti. “Sa” chi bisogna corrompere, chi bisogna evitare, chi si può
impietosire, a chi si deve resistere.
Eppure (e per questa sua virtù oggi ancora la sua memoria mi è
cara e vicina) non è diventato un tristo. Ho sempre visto, e ancora vedo
in lui, la rara figura dell'uomo forte e mite, contro cui si spuntano le armi
della notte.
Non sono però riuscito a ottenere di dormire in cuccetta con lui, e neppure
Alberto ci è riuscito, quantunque nel Block 45 egli goda ormai di una
certa popolarità. E' peccato, perché avere un compagno di letto
di cui fidarsi, o con cui almeno ci si possa intendere, è un inestimabile
vantaggio; e inoltre, adesso è inverno, e le notti sono lunghe, e dal
momento che siamo costretti a scambiare sudore, odore e calore con qualcuno,
sotto la stessa coperta e in settanta centimetri di larghezza, è assai
desiderabile che si tratti di un amico.
Levi non giudica, racconta, con un rigore morale straordinario (o spaventoso?),
esclusivamente cose che lui ha vissuto personalmente; cosa hanno fatto i tedeschi,
cosa hanno fatto i deportati.
Nell'ottobre 1944 i nazisti decidono una nuova selezione. I selezionati saranno
avviati l'indomani alle camere a gas. Per gli altri la speranza di sopravvivenza
continuerà. Levi non viene selezionato.
Così racconta del ritorno a sera nelle baracche:
Adesso ciascuno sta grattando attentamente col cucchiaio il fondo della gamella
per ricavarne le ultime briciole di zuppa, e ne nasce un tramestio metallico
sonoro il quale vuol dire che la giornata è finita. A poco a poco prevale
il silenzio, e allora, dalla mia cuccetta che è al terzo piano, si vede
e si sente che il vecchio Kuhn prega, ad alta voce, col berretto in testa
e dondolando il busto con violenza. Kuhn ringrazia Dio perché
non è stato scelto.
Kuhn è un insensato. Non vede, nella cuccetta accanto, Beppo
il greco che ha vent'anni, e dopodomani andrà in gas, e lo sa, e se ne
sta sdraiato e guarda fisso la lampadina senza dire niente e senza pensare più
niente? Non sa Kuhn che la prossima volta sarà la sua volta? Non
capisce Kuhn che è accaduto oggi un abominio che nessuna preghiera
propiziatoria, nessun perdono, nessuna espiazione dei colpevoli, nulla insomma
che sia in potere dell'uomo di fare, potrà risanare mai più?
Se io fossi Dio, sputerei a terra la preghiera di Kuhn.
Il 7 ottobre 1944 il Sonderkommando
del Crematorio IV di Auschwitz-Birkenau
si rivolta, riuscendo a distruggere la camera a gas, prima di essere completamente
sterminato.
Monowitz è distante
alcuni chilometri, ma anche lì alcuni uomini della resistenza del campo
erano al corrente dei fatti ed avevano supportato la rivolta. L'ultimo di essi
viene scoperto e condannato a pubblica impiccagione dinanzi a tutti gli internati
di Buna-Monowitz.
Il mese scorso, uno dei crematori di Birkenau è stato fatto saltare.
Nessuno di noi sa (e forse nessuno saprà mai) come esattamente l'impresa
sia stata compiuta: si parla di Sonderkommando, del Kommando Speciale
addetto alle camere a gas e ai forni, che viene esso stesso periodicamente sterminato,
e che viene tenuto scrupolosamente segregato dal resto del campo. Resta il fatto
che a Birkenau qualche centinaio di uomini, di schiavi inermi e spossati
come noi, hanno trovato in se stessi la forza di agire, di maturare i frutti
del loro odio.
L'uomo che morrà oggi davanti a noi ha preso parte in qualche modo alla
rivolta. Si dice che avesse relazioni cogli insorti di Birkenau, che
abbia portato armi nel nostro campo, che stesse tramando un ammutinamento simultaneo
anche tra noi. Morrà oggi sotto i nostri occhi: e forse i tedeschi non
comprenderanno che la morte solitaria, la morte di uomo che gli è stata
riservata, gli frutterà gloria e non infamia.
Quando finì il discorso del tedesco, che nessuno poté intendere,
di nuovo si levò la prima voce rauca: - Habt ihr verstanden? - (Avete
capito?)
Chi rispose “Jawohl”? Tutti e nessuno: fu come se la nostra maledetta rassegnazione
prendesse corpo di per sé, si facesse voce collettivamente al di sopra
dei nostri capi. Ma tutti udirono il grido del morente, esso penetrò
le grosse antiche barriere di inerzia e di remissione, percosse il centro vivo
dell'uomo in ciascuno di noi: - Kameraden, ich bin der Letzte! - (Compagni,
io sono l'ultimo!)
Vorrei poter raccontare che di fra noi, gregge abietto, una voce si fosse levata,
un mormorio, un segno di assenso. Ma nulla è avvenuto. Siamo rimasti
in piedi, curvi e grigi, a capo chino, e non ci siamo scoperta la testa che
quando il tedesco ce l'ha ordinato.
La botola si è aperta, il corpo ha guizzato atroce; la banda ha ripreso
a suonare, e noi, nuovamente ordinati in colonna, abbiamo sfilato davanti agli
ultimi fremiti del morente.
Ai piedi della forca, le SS ci guardavano passare con occhi indifferenti: la
loro opera è compiuta, e ben compiuta. I russi possono ormai venire:
non vi sono più uomini forti fra noi, l'ultimo pende ora sopra i nostri
capi, e per gli altri, pochi capestri sono bastati. Possono venire i russi:
non troveranno che noi domati, noi spenti, degni ormai della morte inerme che
ci attende.
Distruggere l'uomo è difficile, quasi quanto crearlo: non è stato
agevole, non è stato breve, ma ci siete riusciti, tedeschi. Eccoci docili
sotto i vostri sguardi: da parte nostra nulla più avete a temere: non
atti di rivolta, non parole di sfida, neppure uno sguardo giudice.
Alberto ed io siamo rientrati in baracca, e non abbiamo potuto guardarci
in viso. Quell'uomo doveva essere duro, doveva essere di un altro metallo del
nostro, se questa condizione, da cui noi siamo stati rotti, non ha potuto piegarlo.
Perché, anche noi siamo stati rotti, vinti: anche se abbiamo saputo adattarci,
anche se abbiamo finalmente imparato a trovare il nostro cibo e a reggere alla
fatica e al freddo, anche se ritorneremo.
Abbiamo issato la menaschka sulla cuccetta, abbiamo fatto la ripartizione, abbiamo
soddisfatto la rabbia quotidiana della fame, e ora ci opprime la vergogna.
Se questo è un uomo,
è preceduto da una poesia, Shemà
(cioè Ascolta, in
ebraico), scritta immediatamente dopo il suo rientro a Torino (Auschwitz viene
raggiunto dall'Armata Rossa il 27 gennaio del 1945, Levi arriva a Torino il
19 ottobre dello stesso anno, dopo un epico viaggio attraverso l'Europa devastata):
è una preghiera-maledizione rivolta a tutti, in ogni tempo e in ogni
luogo, perché sappiano e ricordino e meditino su quanto è avvenuto
nell'Europa dei lager.
Il libro, rifiutato da Einaudi, viene pubblicato da un piccolo editore nel '47.
Qui si arresta la sua attività di scrittore: Levi è in chimico,
lo è per vocazione, nel '47 ha trent'anni, lavora, si sposa, ha due figli,
parla e racconta delle sue esperienze.
Nel '56 Einaudi pubblica Se questo è un uomo,
che ha finalmente un grande riscontro di critica e di pubblico. Fino al '77
(quando va in pensione, a sessant'anni), Levi esercita tre attività (mestieri
come li chiama lui), la fabbrica di vernici, come chimico, conferenze ed incontri
soprattutto con giovani studenti, per questo obbligo di testimonianza, e poi
scrive, pubblicando prima con pseudonimi e poi con il suo vero nome, racconti
e poesie.
Nel 1982 pubblica il suo primo, ed unico, romanzo:
Se non ora, quando. Nel 1986 pubblica il suo ultimo
libro, I sommersi e i salvati,
doloroso sommario di una vita di riflessioni sul suo anno di lager e sull'universo
concentrazionario. L'undici aprile del 1987, a settant'anni, si suicida.
Primo Levi era un uomo memoria.
Era ben cosciente di essere stato veramente e solamente un numero, in lager;
in conseguenza diretta di ciò era ben cosciente che l'essere sopravvissuto
significava che qualcun altro era morto al suo posto, e a questo altro, sommerso
perché era stato meno scaltro, o meno cattivo, o semplicemente meno fortunato,
sentiva di dover qualcosa.
Vergogna di non essere morti, ce l'ho anch'io: è stupido ma ce
l'ho. E' difficile spiegarla. E' l'impressione che gli altri siano morti al
tuo posto; di essere vivi gratis, per un privilegio che non hai meritato, per
un sopruso che hai fatto ai morti. Essere vivi non è una colpa, ma noi
la sentiamo come una colpa. (Se non ora, quando, pag. 219.)
Da questo senso di colpa di essere sopravvissuti, comune a moltissimi reduci,
deriva il dovere di testimoniare, e di continuare a farlo. Qualche giorno prima
di morire Levi si era lamentato con una sua amica per la sua memoria che cominciava
a svanire.
Comunque sia Levi era un grande scrittore e non ha scritto solo di lager e di
nazisti; con grande ironia poteva parlare di animali domestici o di fisica quantistica
o di storie preistoriche, o anche quando racconta del lager trova la forza di
farlo con l'ironia, che gli è propria, e che forse ha contribuito a salvargli
la pelle, almeno nel '44.
Paul
Steinberg
Un altro mondo
Parma, Guanda, 1997
Paul Steinberg, ebreo parigino,
nato a Berlino nel 1926, viene
deportato ad Auschwitz nel
1943, ancora adolescente.
Mi ha preso la curiosità di rileggere il libro di Primo Levi, quello
che è stato decisivo per la sua vocazione letteraria: Se questo
è un uomo. L'avevo solo scorso quando era apparso in Les temps
modernes verso il 1950. A quell'epoca, evitavo come la peste tutto quello
che si riferiva alla deportazione.
Scopro con stupore che lui parla a lungo di me, cambiando qualche particolare.
Mi chiama Henri, per esempio. Mi attribuisce ventidue anni, mentre ne avevo
appena diciotto, e una vasta cultura scientifica e letteraria, il che è
quanto meno eccessivo.
Tutto il resto non lascia spazio a dubbi. Imberbe, poliglotta : francese,
inglese, tedesco, russo. Intrattiene relazioni privilegiate con i prigionieri
di guerra inglesi. Mio fratello, morto al campo nell'inverno 1943-44: Philippe.
I miei intrighi per crearmi relazioni utili tra i capi-blocco e altri Prominent
del campo.
Strana impressione quella di vedersi a cinquant'anni di distanza attraverso lo
sguardo di un osservatore neutrale e sicuramente oggettivo.
Dalla sua descrizione esce l'immagine di un individuo piuttosto antipatico, insipido,
che considerava una piacevole compagnia, ma che non provava il minimo desiderio
di rivedere.
Pare che sappia che sono sopravvissuto, mi chiedo come. Deve aver senz'altro visto
giusto! Io ero probabilmente quell'essere obnubilato dall'idea di sopravvivere;
“chiuso in sé come in una corazza” dice Levi, e che sapeva attirarsi la
benevolenza e la pietà dei potenti, all'occorrenza, mostrando “le cicatrici
che ha sugli stinchi”. Un combattente solitario, freddo, calcolatore, che “sui
modi di sopravvivere in Lager possiede una teoria completa e organica”.
Se guardo, da osservatore neutrale, l'immagine che lui ha avuto di me, ebbene
dovevo essere stato proprio così, ferocemente determinato a fare qualsiasi
cosa per vivere, pronto ad usare tutti i mezzi a mia disposizione e con il dono
di saper risvegliare la simpatia e la compassione.
La cosa più strana di questo rapporto che sembra aver lasciato tracce così
precise nella sua memoria è che io non ho di lui alcun ricordo. Forse perché
avevo ritenuto che non potesse essermi utile? Questo confermerebbe a pieno il
suo giudizio.
Adesso provo un vero dispiacere. Primo Levi è morto. Non ho mai preso atto
del suo giudizio. Ha detto : “Darei molto per conoscere la sua vita di uomo
libero”. Sarei forse riuscito a cambiare il verdetto? A far valere le mie attenuazioni?
Non saprò mai se ho il diritto di sollecitare la clemenza della giuria.
Si è colpevoli di sopravvivere?
Nicola
Caracciolo
Gli ebrei e l'Italia durante la guerra 1940-1945
Bonacci Editore, Roma, 1986
Fra le molte interviste del libro, stralciamo
alcuni passi del dialogo fra Nicola Caracciolo
e Primo Levi (le interviste
sono state realizzate per una serie di documentari televisivi, trasmessi dalla
RAI)
Primo Levi
Il popolo tedesco di allora era un popolo di “Ja Sager”, di dicitori di “sì”,
un popolo obbediente, un popolo disciplinato nel bene e nel male: accettava
l'obbedienza prussiana. Io ho letto dei libri allucinanti sulla scuola tedesca
di allora, come la scuola abbia contribuito in modo preponderante a costruire
lo stato nazista in pochi anni...
Il culto della disciplina, il culto dell'obbedienza, il rifiuto dell'individualità,
vista come disordine...
Il Lager era organizzato in modo tale che i nostri contatti con le SS erano
ridotti a nulla: il campo era autogestito, le SS delegavano dei funzionari all'interno
del campo.
Nicola Caracciolo
I “Kapò”...
P.L.
Il capo, sì stranamente è prevalsa la pronuncia francese, ma invece
la parola è italiana e i tedeschi dicevano “capo”, non “capò”.
Il mio campo era un campo particolare: era una dipendenza di Auschwitz, era
un Nebenlager, cioè un campo laterale, che - ho saputo poi dopo - apparteneva
anche finanziariamente a un Trust tedesco, I.G. Farben-industrie, come fosse
la Montedison italiana: in sostanza l'aveva finanziato, e pagava alle SS un
affitto per noi. Mi pare che fosse 4 marchi al giorno pagato alle SS per uno
specialista, io ero specialista, e 3 marchi per un manovale, ed erano manovali
i nove decimi. Questi soldi venivano pagati alle SS le quali spendevano qualcosa
come 60 centesimi al giorno per il mantenimento, gli abiti e così via.
Quindi era un cospicuo affare per le SS quello di affittare diecimila lavoratori
al giorno a questa industria.
E c'era stato un contrasto addirittura fra la I.G. Farben e le SS in questo
senso, che se qualcuno si ammalava doveva venir curato purché la prognosi
fosse inferiore a 14 giorni. Se la prognosi era superiore a 14 giorni doveva
essere ucciso, e la popolazione dell'infermeria non doveva superare il dieci
per cento del campo. Era un contratto.
N.C.
Di modo che, quindi, quando uno andava in infermeria... da una parte c'era la
gioia del riposo ma dall'altra era molto pericoloso.
P.L.
Ho descritto poco fa la cecità irrazionale di questa ondata di distruzione
nei riguardi degli ebrei. Ma gli industriali tedeschi non erano così
ciechi e così irrazionali, non che fossero degli angeli, ma semplicemente
volevano avere una manodopera ragionevolmente efficiente. Ora un'équipe,
una squadra di operai che si rinnova continuamente non è efficiente.
Perciò esisteva una certa diarchia e una certa pressione da parte della
I.G. Farben-industrie perché non fossimo trattati in un modo troppo disastroso.
Per esempio erano ammesse senz'altro le punizioni corporali: schiaffi, pugni
e calci ne ho presi in abbondanza, ma non dovevano menomare, perché è
ovvio, un operaio con una caviglia slogata o col naso rotto rende di meno. Quindi
esisteva una influenza moderatrice da parte della industria tedesca: avevano
bisogno di manodopera, la sfruttavano fino all'estremo, era ammesso che la vita
media fosse tre mesi, che però tre mesi dovevano essere: bisognava che
questo materiale umano conservasse un minimo di efficienza.
N.C.
E questa caratteristica di mania dell'ordine nei campi come la spiega?
P.L.
Rifletteva follemente certe caratteristiche tedesche. Oltre alla sofferenza
nota, già descritta da me stesso e da infiniti altri del Lager, c'era
una miriade di sofferenze ulteriori: il fatto che i bottoni dovevano essere
cinque, i bottoni della giacca: se uno perdeva un bottone era una tragedia,
bisognava trovarne un altro e non si sapeva dove trovarlo e con che filo cucirlo
e con quale ago cucire, e le scarpe dovevano essere lucidate tra virgolette,
perché non c'era nessun lucido, e allora c'era un commercio clandestino
di unto, poteva essere catrame o vasellina o grasso da macchina con cui bisognava
strofinarsi le scarpe che erano a pezzi, erano strumenti di tortura, zoccoli
con la suola di legno, ma dovevano essere ogni mattina lucidate in qualche modo:
era la traduzione o forse la parodia della vita militare tedesca.
N.C.
E lei è stato salvato da un italiano a Auschwitz: ce lo può raccontare?
P.L.
Se sono vivo è per molti motivi, ma il principale è questo, che
lavoravo appunto in una fabbrica di prodotti chimici e ho lavorato quasi per
un anno e dieci mesi come manovale. Ora per mia fortuna mi hanno mandato un
certo giorno d'estate, era nel giugno del '44, a fare il manovale a una squadra
di muratori, a tirare su un muro. Ora non era tanto facile fare il manovale,
perché bisognava portare su il bugliolo con la calce che è molto
pesante, bisognava portarlo su una spalla, e io ho fatto un disastro, cioè
ho sparpagliato tutta la calce il primo viaggio che facevo, è il muro
era già alto e dovevo portarlo su per la scala, e mi sono accorto con
sorpresa e con felicità che i due in cima parlavano italiano fra loro,
e si son detti una frase, anzi uno parlava con l'accento piemontese, ha detto
a l'altro “Ah's capis, cun gent' parei” -eh, si capisce, con gente come questa
cosa vuoi che facciano. E allora gli ho detto “ma tu sei italiano”... e lui
m'ha detto “s'capis” “si capisce” era di Fossano.
Bene, quest'uomo che era un uomo molto strano e parlava pochissimo, sembrava
muto addirittura, mi ha adottato. Non mi ha detto niente o quasi niente, ma
da quel giorno fino a quando ha potuto mi ha portato ogni giorno una gavetta
di zuppa, ed era una zuppa strana dentro la quale ho trovato un po', di tutto:
una volta un'ala di passerotto con tutte le penne, un'altra volta ho trovato
un ritaglio della Stampa cotto, e un'altra
volta ancora dei noccioli di prugne.
Insomma evidentemente, l'ho saputo poi dopo, lui faceva una specie di colletta
nel suo campo tra gli italiani e raccoglieva tutti gli avanzi e me li portava
- si rendeva conto benissimo che era meglio che niente - e questo per me ha
fatto da complemento per le calorie che mancavano, perché il vitto del
campo era insufficiente non è che fosse nullo, erano circa 1500-1600
calorie che notoriamente non bastano.
Per un uomo che fa un lavoro pesante ce ne vogliono almeno 2400-2600. E lui
mi ha portato questa gavetta con suo rischio perché lui sapeva benissimo
che rischiava, che era proibito avere contatti extra-lavoro con noi. Ma lui
se ne infischiava. Alzava le spalle e dice: “cosa me ne frega”. Io glielo dicevo:
“guarda che è pericoloso, ti metto nei guai”. Avevamo combinato che invece
di darmi in mano la gavetta la nascondeva in un certo posto e io l'andavo poi
a prelevare: c'era una certa precauzione da parte sua.
N.C.
Lei l'ha rivisto poi dopo la guerra?
P.L.
Dopo la guerra l'ho rivisto: lui era arrivato in Italia molto prima di me. Io
appena tornato l'ho cercato, l'ho trovato, ho cercato di aiutarlo, gli ho fatto
avere quattrini, abiti, ho cercato di sdebitarmi, ma l'ho trovato ridotto malissimo,
lui era stato talmente traumatizzato dalle cose che aveva visto là ad
Auschwitz, che si era messo a bere. Era un uomo estremamente sensibile anche
se non parlava quasi mai, e le cose che aveva visto ad Auschwitz, a Suiss come
diceva lui, lo avevano colpito, l'avevano, come dire, ferito profondamente e
non voleva più vivere, diceva “in un mondo come questo non val la pena
di vivere”. E lui che era muratore, che era un bravo muratore, aveva smesso
di fare il muratore, faceva il ferrivecchi, comprava e vendeva ferro, e tutti
i quattrini che guadagnava se li beveva: e io che andavo a trovarlo ogni tanto
a Fossano gli ho detto “ma perché vivi in questo modo?”, e lui molto
freddamente mi diceva... “non val la pena di vivere, io bevo perché preferisco
stare ubriaco che sobrio”. Tanto che dormiva, s'ubriacava e dormiva all'aperto
- s'è preso una polmonite - io l'ho fatto ricoverare a Savigliana all'ospedale,
ma non gli davano il vino, e lui è scappato, e l'han poi trovato moribondo
in un canale, dove dormiva ubriaco. Insomma lui che non era un reduce da Auschwitz
è morto della malattia dei reduci.
Primo
Levi
Ad ora incerta
Garzanti, Milano, 1990
Il volume raccoglie tutte le poesie scritte da
Levi. Queste qui trascritte sono tutte del 1946, un anno dopo la liberazione
di Primo Levi da Auschwitz.
25 febbraio 1944
Vorrei credere qualcosa oltre,
Oltre che morte ti ha disfatta.
Vorrei poter dire la forza
Con cui desiderammo allora,
Noi già sommersi,
Di potere ancora una volta insieme
Camminare liberi sotto il sole.
9 gennaio 1946
Shemà è la poesia con cui
inizia Se questo è un uomo. La poesia fa chiaramente riferimento
alla preghiera ebraica dello Shemà Israel, la preghiera tratta
da Deuteronomio 6, con la quale l'ebreo credente ricorda continuamente l'esistenza
di Dio e della sua Legge.
Shemà
Voi che vivete sicuri
Nelle vostre tiepide case,
Voi che trovate tornando a sera
Il cibo caldo e visi amici:
Considerate se questo è un uomo,
Che lavora nel fango
Che non conosce pace
Che lotta per mezzo pane
Che muore per un sì o per un no.
Considerate se questa è una donna,
Senza capelli e senza nome
Senza più forza di ricordare
Vuoti gli occhi e freddo il grembo
Come una rana d'inverno.
Meditate che questo è stato:
Vi comando questa parole.
Scolpitele nel vostro cuore
Stando in casa andando per via,
Coricandovi alzandovi:
Ripetetele ai vostri figli.
O vi si sfaccia la casa,
La malattia vi impedisca,
I vostri nati torcano il viso da voi.
10 gennaio 1946
Anche nella libertà riconquistata, il ricordo del male tormenta chi è
sopravvissuto.
Alzarsi
Sognavamo nelle notti feroci
Sogni densi e violenti
Sognati con anima e corpo:
Tornare; mangiare; raccontare.
Finché suonava breve sommesso
Il comando dell'alba:
“Wstawac”:
E si spezzava il petto in cuore.
Ora abbiamo ritrovato la casa
Il nostro ventre è sazio,
Abbiamo finito di raccontare.
E' tempo. Presto udremo ancora.
Il comando straniero:
“Wstawac”.
11 gennaio 1946
Nel campo di transito di
Carpi-Fossoli, vicino Modena,
Levi era stato. Da lì era stato poi deportato ad Auschwitz.
Il tramonto di Fossoli
Io so cosa vuol dire non tornare.
A traverso il filo spinato
Ho visto il sole scendere e morire;
Ho sentito lacerarmi la carne
Le parole del vecchio poeta:
“Possono i soli cadere e tornare:
A noi, quando la breve luce è spenta,
Una notte infinita è da dormire”.
7 febbraio 1946
Il conservare la propria umanità permette di sopravvivere nel Lager, senza
perdere totalmente la propria dignità.
11 febbraio 1946
Cercavo te nelle stelle
Quando le interrogavo bambino.
Ho chiesto te alle montagne,
Ma non mi diedero che poche volte
Solitudine e breve pace.
Perché mancavi, nelle lunghe sere
Meditai la bestemmia insensata
Che il mondo ero uno sbaglio di Dio,
Io uno sbaglio nel mondo.
E quando, davanti alla morte,
Ho gridato di no da ogni fibra,
Che non avevo ancora finito,
Che troppo ancora dovevo fare,
Era perché mi stavi davanti,
Tu con me accanto, come oggi avviene,
Un uomo una donna sotto il sole.
Sono tornato perché c'eri tu.
11 febbraio 1946
Primo
Levi
Il sistema periodico
Einaudi, Torino, 1994
Anche in alcuni capitoli de Il sistema
periodico, Primo Levi
ritorna su episodi della sua detenzione ad Auschwitz-Monowitz.
Ogni capitolo porta il nome di un elemento chimico del sistema periodico e racconta
una storia reale o immaginaria in che ha per protagonista l'elemento in questione.
Il capitolo sul cerio racconta
l'importanza di questo materiale per la sopravvivenza nel campo:
Li mostrai al mio amico Alberto. Alberto cavò di tasca un
coltellino e provò ad inciderne uno: era duro, resisteva alla lama. Provò
a raschiarlo: si udì un piccolo crepitio e scaturì un fascio di
scintille gialle. A questo punto la diagnosi era facile: si trattava di ferro-cerio,
la lega di cui sono fatte le comuni pietrine per accendisigaro. Perché
erano così grandi? Alberto, che per qualche settimana aveva lavorato da
manovale insieme con una squadra di saldatori, mi spiegò che vengono montati
sulla punta dei cannelli ossiacetilenici, per accendere la fiamma. A questo punto
mi sentivo scettico sulle possibilità commerciali della mia refurtiva:
poteva magari servire ad accendere il fuoco, ma in Lager i fiammiferi (illegali)
non scarseggiavano certo.
Alberto mi redarguì. Per lui la rinuncia, il pessimismo, lo sconforto,
erano abominevoli e colpevoli: non accettava l'universo concentrazionario, lo
rifiutava con l'istinto e con la ragione, non se ne lasciava inquinare. Era un
uomo di volontà buona e forte, ed era miracolosamente rimasto libero, e
libere erano le sue parole ed i suoi atti: non aveva abbassato il capo, non aveva
piegato la schiena. Un suo gesto, una sua parola, un suo riso, avevano virtù
liberatoria, erano un buco nel tessuto rigido del Lager, e tutti quelli che lo
avvicinavano se ne accorgevano, anche coloro che non capivano la sua lingua. Credo
che nessuno, in quel luogo, sia stato amato quanto lui.
Mi redarguì: non bisogna scoraggiarsi mai, perché è dannoso,
e quindi immorale, quasi indecente. Avevo rubato il cerio: bene, ora si trattava
di piazzarlo, di lanciarlo. Ci avrebbe pensato lui, lo avrebbe fatto diventare
una novità, un articolo di alto valore commerciale. Prometeo era stato
sciocco a donare il fuoco agli uomini invece di venderlo: avrebbe fatto quattrini,
placato Giove, ed evitato il guaio dell'avvoltoio.
Dalla volontà di non sottomettersi nacque l'idea:
A sera io portai in campo i cilindretti, ed Alberto un pezzo di lamiera con un
foro rotondo: era il calibro preciso a cui avremmo dovuto assottigliare i cilindri
per trasformarli in pietrine e quindi in pane. Quanto seguì è da
giudicarsi con cautela. Alberto disse che i cilindri si dovevano ridurre raschiandoli
con un coltello, di nascosto, perché nessun concorrente ci rubasse il segreto.
Quando? Di notte. Dove? Nella baracca di legno, sotto le coperte e sopra il saccone
pieno di trucioli, e cioè rischiando di provocare un incendio, e più
realisticamente rischiando l'impiccagione: poiché a questa pena erano condannati,
fra l'altro, tutti coloro che accendevano un fiammifero in baracca.
Si esita sempre nel giudicare le azioni temerarie, proprie od altrui, dopo che
queste sono andate a buon fine: forse non erano dunque abbastanza temerarie? O
forse è vero che esiste un Dio che protegge i bambini, gli stolti e gli
ebbri? O forse ancora, queste hanno più peso e più calore delle
altre innumerevoli andate a fine cattivo, e perciò si raccontano più
volentieri? Ma noi non ci ponemmo allora queste domande: il Lager ci aveva donato
una folle familiarità col pericolo e con la morte, e rischiare il capestro
per mangiare di più ci sembrava una scelta logica, anzi ovvia.
Il capitolo Vanadio racconta un secondo avvenimento reale della
vita di Levi. Tornato, dopo la guerra, al lavoro di chimico inoltrò
un reclamo per un prodotto e, dalla Germania, gli rispose un tal Muller.
Quel nome gli ricordò il Muller di cui era stato dipendente
da detenuto, nella fabbrica I.G.Farben di Buna.
Doveva essere piuttosto autorevole, perché tutti lo salutavano per primi.
Era un uomo alto e corpulento, sui quarant'anni, dall'aspetto piuttosto rozzo
che raffinato; con me aveva parlato soltanto tre volte, e tutte e tre con una
timidezza rara in quel luogo, come se si vergognasse di qualche cosa. La prima
volta solo di questioni di lavoro (del dosamento della “naptilamina”, appunto);
la seconda volta mi aveva chiesto perché avevo la barba così lunga,
al che io avevo risposto che nessuno di noi aveva un rasoio, anzi neppure un fazzoletto,
e che la barba vi veniva rasa d'ufficio tutti i lunedì; la terza volta
mi aveva dato un biglietto, scritto nitidamente a macchina, che mi autorizzava
ad essere raso anche il giovedì ed a prelevare dall'Effektmagazin
un paio di scarpe di cuoio, e mi aveva chiesto, dandomi del lei: “Perché
ha l'aria così inquieta?” Io, che a quel tempo pensavo in tedesco, avevo
concluso fra me: Der Mann hat keine Ahnung, costui non si rende conto.
Lo strano modo con cui Muller
scriveva la parola naptilamina
gli confermò che era la stessa persona che aveva già incontrato
nel Lager, l'uomo che si serviva, da civile,
degli schiavi del campo di Monowitz,
senza voler aprire gli occhi sulla loro situazione.
Gli riscrisse cercando di far venire alla luce se, a distanza di anni, si sentisse
ora colpevole. Muller rispose
in modo evasivo, dicendo di non essere mai stato un eroe e di essere dispiaciuto
di questo. Così Levi
commenta questa risposta:
Ammettevo che non tutti nascono eroi, e che un mondo in cui tutti fossero come
lui, cioè onesti ed inermi, sarebbe tollerabile, ma questo è un
mondo irreale. Nel mondo reale gli armati esistono, costruiscono Auschwitz e gli
onesti ed inermi spianano loro la strada; perciò di Auschwitz deve
rispondere ogni tedesco, anzi ogni uomo, e dopo Auschwitz non è
più lecito essere inermi.
Muller fece
sapere che voleva incontrare Levi.
Questo lo gettò nell'angoscia. Voleva davvero soddisfare questo desiderio
del suo antico ingegnere capo?
Otto giorni dopo ricevetti dalla Signora Muller l'annuncio della morte
inaspettata del Dottor Lothar Muller, nel suo sessantesimo anno di età.
Primo
Levi
Appendice a
Se questo è un uomo
Einaudi, Torino, 1989
Primo Levi
scrisse nel 1976 un appendice all'edizione scolastica di
Se questo è un uomo. Cercava, con essa,
di rispondere per iscritto a tutte le domande che si sentiva ripetere ogni volta
che partecipava a qualche conferenza con gli studenti.
La specificità del sistema concentrazionario nazista non accetta confronti
con altri sistemi dittatoriali pur deprecabili:
In Unione Sovietica pare che nei periodi più duri la mortalità si
aggirasse sul 30 per cento, riferito a tutti gli ingressi, e questo è certamente
un dato intollerabilmente alto; ma nei Lager tedeschi la mortalità era
del 90/98 per cento.
I campi, anche quelli detti di concentramento
e non di sterminio erano insomma
progettati per l'eliminazione fisica di tutti i detenuti, con la variante di un
possibile sfruttamento della forza lavoro fino ad esaurimento dei prigionieri.
Lo stesso modo che fu scelto (dopo minuziosi esperimenti) per lo sterminio era
apertamente simbolico. Si doveva usare, e fu usato, quello stesso gas velenoso
che si impiegava per disinfestare le stive delle navi, ed i locali invasi da cimici
o pidocchi. Sono state escogitate nei secoli morti più tormentose, ma nessuna
era così gravida di dileggio e di disprezzo.
Come è noto, l'opera di sterminio fu condotta molto avanti. I nazisti,
che pure erano impegnati in una durissima guerra, ormai difensiva, vi manifestarono
una fretta inesplicabile: i convogli delle vittime da portare al gas, o da trasferire
dai Lager prossimi al fronte, avevano la precedenza sulle tradotte militari. Non
fu condotta a termine solo perché la Germania fu disfatta, ma il testamento
politico che Hitler dettò poche ore prima di uccidersi, coi russi a pochi
metri, si concludeva così: “Soprattutto ordino al governo e al popolo tedesco
di mantenere in pieno vigore le leggi razziali, e di combattere inesorabilmente
l'avvelenatore di tutte le nazioni, l'ebraismo internazionale”.
L'accanimento contro gli ebrei deve essere studiato, in tutti
i suoi antefatti storici che lo hanno preparato e lo hanno reso possibile, ma
deve anche restare inesplicabile:
Ancora una volta: non mi sembrano spiegazioni adeguate. Non mi sembra lecito spiegare
un fenomeno storico riversandone tutta lo colpa su un individuo (gli esecutori
di ordini orrendi non sono innocenti!), ed inoltre è sempre arduo interpretare
le motivazioni profonde di un individuo. Le ipotesi che vengono proposte giustificano
i fatti solo in misura parziale, ne spiegano la qualità ma non la quantità.
Devo ammettere che preferisco l'umiltà con cui alcuni storici fra i più
seri (Bullock, Schramm, Bracher) confessano di non comprendere
l'antisemitismo furibondo di Hitler e della Germania dietro di lui.
Forse, quanto è avvenuto non si può comprendere, perché comprendere
è quasi giustificare. Mi spiego: “comprendere” un proponimento o un comportamento
umano significa (anche etimologicamente) contenerlo, contenerne l'autore, mettersi
al suo posto, identificarsi con lui. Ora, nessun uomo normale potrà mai
identificarsi con Hitler, Himmler, Goebbels, Eichmann
e infiniti altri. Questo ci sgomenta, ed insieme ci porta sollievo: perché
forse è desiderabile che le loro parole (ed anche, purtroppo, le loro opere)
non ci riescano più comprensibili.
Sono parole ed opere non umane, anzi, contro-umane, senza precedenti storici,
a stento paragonabili alle vicende più crudeli della lotta biologica per
l'esistenza. A questa lotta può essere ricondotta la guerra: ma Auschwitz
non ha nulla a che vedere con la guerra, non è un episodio, non ne è
una forma estrema. La guerra è un terribile fatto di sempre: è deprecabile
ma è in noi, ha una sua razionalità, la “comprendiamo”.
Jean
Améry
Intellettuale a Auschwitz
Bollati Boringhieri, Torino, 1993
Hans Mayer ebreo austriaco,
meglio conosciuto col suo pseudonimo di Jean Améry,
partecipò in Belgio al movimento di resistenza. Arrestato, fu torturato
ed internato ad Auschwitz-Monowitz,
dove fu compagno di baracca di Primo Levi.
Così scrive, a proposito del pensiero e della fede:
Ero agnostico quando finii in prigione e in campo di concentramento, e
da agnostico, liberato il 15 Aprile 1945 a Bergen- Belsen dagli inglesi, lasciai
l'inferno. In nessun momento ho potuto scorgere in me la possibilità della
fede, nemmeno quando mi trovavo legato in cella di isolamento, e, sapendo che
su di me pesava l'accusa di Zersetzung der wehrkraft (disfattismo), mi
aspettavo in ogni istante di essere condotto davanti al plotone di esecuzione.
Ne sono mai stato un seguace impegnato, o vicino a una determinata ideologia politica.
Tuttavia devo ammettere di aver avuto, e di aver ancora, una profonda ammirazione
e per i compagni religiosi e per quelli politicamente impegnati. Potevano essere
più o meno “spirituali” nel senso che abbiamo voluto dare al termine, non
aveva alcuna importanza. La fede politica o religiosa nei momenti decisivi era
per loro un prezioso sostegno, mentre noi intellettuali scettico - umanistici
invano invocavamo i nostri numi letterari, filosofici artistici. Marxisti militanti,
testimoni di Geova settari, cattolici praticanti, eruditissimi economisti e teologi
ma anche operai e contadini meno dotti, a tutti loro la fede o l'ideologia forniva
quel punto d'appoggio nel mondo che consentiva loro di scardinare spiritualmente
lo stato delle SS. In condizioni indicibilmente difficili dicevano messa, e, sebbene
tutto l'anno fossero costretti a sopportare i tormenti della fame, da ebrei ortodossi
digiunavano il giorno dell'Espiazione.
Soprattutto, dinanzi alla onnipresenza della morte crollava la
dignità del pensiero:
Il primo evento era di norma il crollo totale della concezione estetica
della morte. E' noto a cosa mi riferisco. L'uomo dello spirito, ed in particolare
l'intellettuale di cultura tedesca, ha in sè una concezione estetica della
morte che ha origini remote e i cui impulsi più recenti risalgono al Romanticismo
tedesco. Possiamo caratterizzarla approssimativamente citando Novalis, Schopenhauer,
Wagner, Thomas Mann. Ad Auschwitz non vi era spazio per la morte nella sua forma
letteraria, filosofica, musicale. Nessun ponte conduceva dalla morte ad Auschwitz
alla Morte a Venezia.
Una volta crollata la concezione estetica della morte, il prigioniero intellettuale
si trova disarmato al suo cospetto. Se cercava di stabilire comunque
un rapporto spirituale e metafisico con la morte, tornava
a scontrarsi con la realtà del Lager che impediva ogni tentativo in questa
direzione. Cosa avveniva concretamente? Per dirla nel modo più conciso
e banale: al pari del suo compagno non spirituale, anche il prigioniero intellettuale
si occupava non della morte ma del morire; il problema nel suo complesso
veniva così ridotto ad una serie di considerazioni concrete. Nel Lager
si narrava ad esempio di una SS che aveva sbudellato un detenuto riempiendogli
poi la pancia di sabbia. E' evidente che di fronte a simili possibilità
non ci si occupava quasi più del se o del fatto che si dovesse
morire, ma solo del come sarebbe avvenuto. Si discuteva di quanto tempo
impiegasse il gas a fare il suo effetto. Si speculava sulla dolorosità
della morte provocata da iniezioni di acido fenico. Era preferibile un colpo sul
cranio o la lenta morte per sfinimento in infermeria? E' significativo dell'atteggiamento
dei prigionieri nei confronti della morte che solo pochi abbiano deciso di “correre
verso il filo“, ossia di suicidarsi toccando il filo spinato attraversato dall'alta
tensione. Il filo era in fondo una soluzione buona e abbastanza sicura, sebbene
vi fosse la possibilità di essere scorti anzitempo, e di finire quindi
nel bunker, il che significava morire con maggiori difficoltà e sofferenze.
Il morire era onnipresente, la morte si sottraeva.
Il testo riflette in cinque distinti capitoli sul pesante fardello
che rappresentava la cultura nei Lager, sull'esperienza della tortura, sulla scoperta
del bisogno di una patria come realtà essenziale alla sopravvivenza dell'uomo,
sul diritto al risentimento nei sopravvissuti, infine sulla situazione di chi,
essendo ebreo di nascita, ma semplicemente tedesco di tradizioni e convinzioni,
ha vissuto l'obbligo e l'impossibilità di essere ebreo.
Settimia
Spizzichino/Isa di Nepi Older
Gli anni rubati
Cava dei Tirreni, 1996
Settimia Spizzichino fu deportata
con il primo gruppo di ebrei romani il 16 ottobre 1943.
Fu internata, dopo la prima selezione ad Auschwitz-Birkenau,
nel lager femminile.
La madre, la nipote e una sorella furono subito mandate
in gas. Settimia e l'altra
sorella Giuditta riuscirono
ad essere assegnate alla stessa baracca.
Riportiamo il brano che descrive l'ambiente naturale del Lager
e l'impossibilità di calcolare il tempo al suo interno:
I giorni diventavano settimane e mesi mentre l'autunno, freddo più del
nostro inverno, l'inverno polacco che non vede mai il sole, fatto di neve, gelo,
tormente. C'erano sempre più cadaveri congelati al mattino, fuori delle
baracche. Era il freddo a segnare per noi il passaggio delle stagioni: sempre
più freddo ed era arrivato l'inverno; poi il freddo diminuiva a poco a
poco ed ecco arrivata la primavera e poi l'estate. Non c'erano altri segni di
primavera o estate ad Auschwitz, non erba né fiori. Del resto, se
fosse spuntato un filo d'erba qualcuno se lo sarebbe mangiato subito.
I giorni erano legati solo agli avvenimenti, non c'erano calendari o giornali
a ricordarci le date, non potevamo quindi dire “il 10 dicembre”; dicevamo invece:
“il giorno che mi hanno picchiata” o “il giorno in cui è morta Anna”.
Il lavoro e il freddo erano troppo duri.
Giuditta la implorava:
Sto troppo male, mettimi fra i malati!
Settimia non
voleva accettare perché sapeva che i malati
sparivano e non se ne sapeva più niente. Alla fine accettò, ma scelse
di dichiararsi anche lei malata, per stare vicino alla sorella. Quando, però,
vennero a prenderle presero solo lei e lasciarono Giuditta
a morire a Birkenau.
La Spizzichino fu trasportata
ad Auschwitz I, nel Blocco
degli esperimenti. Le furono iniettate il tifo, la scabbia ed una dozzina di altre
malattie, per poi provare i medicinali conseguenti.
Il giorno del compleanno di Cristina,
l'infermiera polacca, amica del dottore che l'aveva scelta per gli esperimenti,
decise di farsi trovare in piedi, per fare una sorpresa alle compagne:
Pian piano mi alzai dal letto e sorreggendomi con la sedia mi trascinai fino al
lavandino. Mi aggrappai al bordo con tutte e due le mani, perché la testa
mi girava.
Alzando gli occhi vidi una sconosciuta, uno scheletro sparuto coperto di piaghe.
Pensai: “Dio, com'è ridotta questa!” E portai le mani al viso. La sconosciuta
fece lo stesso gesto. Allora capii con orrore che stavo guardando la mia immagine
allo specchio. Non mi ero specchiata da quando avevo lasciato la mia casa.
Dio, quanto piansi! Eppure ce la feci. Quando smisero di iniettarmi microbi, riuscii
a rimettermi e a camminare.
Della prima deportazione da Roma è stata l'unica donna
a sopravvivere.
Fania
Fenelon
Ad Auschwitz c'era un orchestra
Firenze, Vallecchi, 1978
Il libro si apre con l'incontro tra la Fenelon, Anny e Irene,
tre componenti dell'orchestra del lager femminile di
Auschwitz-Birkenau.
Di queste tre donne, Fanja Fénelon è la più minuta:
un metro e cinquanta d'altezza, gli occhi di un azzurro intenso, sprigiona
una forza di vita per la quale le sue amiche le sono riconoscenti:
- Tu ci trascinavi tutte; se non ci fossi stata tu...
Non hanno bisogno di finire la frase, tutte sanno bene cosa intendono.
- Tu, ci facevi ridere...
Si voltano verso di me, l'estranea, e mi confessano con aria grave:
- Si rideva, si rideva come pazze...
- Sì - corregge Anny, - nell'orchestra si poteva ancora ridere.
Il riso, che le ha aiutate a sopravvivere, ora le rende pensierose, e tutte sembrano
chiedersi se era davvero legittimo. Irene, i cui occhi di un azzurro
scuro hanno conservato una espressione di candore, mi dice:
- Si rideva, si suonava. Un'orchestra in un campo di concentramento! Incredibile,
vero?
- Sapevo che ce n'erano in molti campi. L'orchestra maschile di Auschwitz
era famosa.
Fanja interviene con risolutezza:
- Nei campi femminili non ce n'erano. L'unica è stata la nostra. Non ne
sono mai esistite altre.
Dice Irene:
- Quell'orchestra ci ha salvato la vita.
Il loro sguardo corre lontano, rincorre uno di quei capricci del destino, di quei
miracoli, che toccano solo coloro che, in qualche modo ne sono stati vittime.
Parlano con ritegno, a frasi brevi. La circospezione che trasmettono nell'avventurarsi
nel loro passato dà al loro ricordi un che di particolare. Lo sguardo
di Anny si intenerisce sull'immagine della Fanja di allora che adesso è
venuta a cercarla.
- Se non ci fossi stata tu, non avremmo superato la follia degli ultimi mesi.
- Come avremo fatto a continuare a vivere? - si meraviglia Irene. - E' un fatto
che non finisce di sorprendermi.
- Tu, Fanja, eri così sicura di uscire di là - riprende Anny
- che nessuna avrebbe potuto pensare di non seguirti.
- Tu ci avevi detto che avresti scritto un libro sulla nostra orchestra e noi
ti abbiamo creduto; eri l'unica che poteva riuscirci.
La Fenelon,
famosa cantante, appena arrivata ad Auschwitz
da Parigi, era stata messa
nella baracca della quarantena, ma era stata riconosciuta da due delle musiciste
dell'orchestra, Florette,
che l'aveva vista cantare al Melody's
a Parigi e la
piccola Irene, che aveva informato la
kapo Alma Rosé, nipote di Gustav Mahler,
figlia del primo violino dell'orchestra dell'Opera di Berlino. Subito la
Rosé l'aveva fatta chiamare.
Mi avvicino alle musiciste.
Nessuna parla, nessuna si muove, tutte quelle adorabili creature mi osservano.
E' un momento straordinario. Poi, la scena si anima: la direttrice dell'orchestra,
una bruna alta e severa, dal portamento nobile e rigido, mi rivolge la parola
in un francese corretto ma con un accento tedesco:
- Sai suonare il piano?
Il mio: « Sì, signora! » lo pronuncio con tanto fervore che
risuona come un alleluia in una cattedrale.
- Allora vai al piano, suona e canta qualcosa della Madama Butterfly.
A piedi nudi, mi avvicino al pianoforte: è un Beckstein, l'ho
sognato tutta la vita. Mi arrampico sullo sgabello, poso le dita dei piedi sui
pedali, le mani sull'avorio dei tasti., e arrossisco di vergogna. Le mani sono
disgustose, ripugnanti, sudicie; da troppi giorni non mi lavo.
Un'ondata di riconoscenza mi prende alla gola: io che non credo a niente, avrei
voglia di pregare, dì ringraziare un dio. Poi, la realtà ha il
sopravvento: sono lì per superare un esame; questione di minuti e
posso essere ricacciata nella baracca della quarantena. Ma non voglio pensarci.
Le mani ritrovano il contatto familiare con i tasti. Attacco Un bel dì
vedremo, nella speranza che Puccini mi salvi la vita.
Dopo, canto una canzone tedesca. Non ci sono più ebree, polacche, ariane,
tutte applaudono, quella canzone sembra aver suscitato un desiderio di ballare.
Non riesco a staccare le mani dal pianoforte, mi pare che finché gli
resto attaccata non mi possa accadere nulla, Quel piano, continuo ad
accarezzarlo, ad abbracciarlo: è il mio salvatore, il mio amore, la mia
vita.
In un silenzio carico di tensione, il verdetto arriva in tedesco: - Ja, gut!
Poi, in francese:
- Ti prendo nell'orchestra.
Mi sento invadere da un calore piacevole: entro nell'orchestra! E Clara?
Non posso abbandonarla, non posso dimenticare il nostro patto. Incosciente per
l'eccitazione, mi azzardo a dire:
- Signora, signora, ho un'amica, Clara, che ha una voce meravigliosa,
mandatela a chiamare.
Davanti allo sguardo freddo e inespressivo dei grandi occhi bruni che mi osservano,
dimentico ogni cautela:
- Senza di lei non posso rimanere qui, ritorno nella baracca.
Non mi rendo evidentemente conto di quel che sto dicendo: un « Nein »
può significare la fine di tutto questo bel sogno. Più pratiche,
le ragazze sono esterrefatte; forse stanno pensando che sono impazzita. Gli
occhi della direttrice rimangono inespressivo, è pur sempre una tedesca.
Poi si decide e chiama la gigantesca polacca:
- Zocha, vai a cercare Clara alla baracca della quarantena e portala
qui.
La Mandel, comandante femminile del lager, faceva suonare l'orchestra
per i pezzi grossi delle SS. L'orchestra suonò anche davanti a
Himmler, nella sua visita al campo.
La direttrice, Alma Rosé,
l'unica musicista di professione oltre alla Fenelon,
sembrava non rendersi conto di essere in un lager, sembrava preoccupata solo
della qualità della musica. La Fenelon
fu spesso incaricata di orchestrare brani famosi perché l'orchestra li
potesse eseguire al meglio, con le strumentiste che aveva.
L'orchestra sta provando il primo movimento della Quinta sinfonia di
Beethoven. Sembra l'inizio delle trasmissioni di radio Londra. Le quattro
note iniziali mi danno una profonda emozione. normalmente, vengono eseguite
dai fagotti, dai clarini, e dagli strumenti a corda. Per la nostra orchestra,
ho cercato di arrangiarmi con i mandolini, le chitarre e i violini.
Alma voleva un po' di Beethoven, così le ho detto che mi
ricordavo a memoria il primo movimento della Quinta e le ho suggerito
di metterlo in programma. Una rara soddisfazione per me. Lei non ci ha visto
nessuna malizia, le SS nemmeno. A nessuno è venuto in mente l'accostamento
con la sigla delle trasmissioni di Francia libera da Londra. Per
i tedeschi si tratta semplicemente di Beethoven, un dio tedesco, un monumento
della loro musicalità, da ascoltare estasiati e rispettosi.
Oggi le ragazze devono essere in stato di grazia: pur eseguita dalla nostra
inconcepibile orchestra di chitarre e mandolini, la sinfonia si distende solenne;
ci trascina meravigliosamente. Le ragazze sedute al tavolo hanno sollevato la
testa; Funia, Marila e la Tchaikowska si sono fermate nel
riquadro della porta. L'orchestra si rende perfettamente conto di quel che sta
suonando.
Il personaggio sinistro della Mandel
emerge anche nei suoi lati più imprevedibili. Così racconta la
sua reazione alla morte misteriosa di Alma Rosé:
Nel pomeriggio, la Mandel viene a darci ufficialmente la notizia.
- La vostra direttrice, Alma Rosé, è morta. Potete andare
all'infermeria a darle l'ultimo saluto.
Ci si veste in silenzio, con estrema cura, e si va tutte quante. Una giornata
bellissima.
Ci immaginiamo di trovare il corpo di Alma disteso su un pagliericcio.
Invece, ci aspetta una messa in scena stupefacente. Le SS hanno fatto erigere
un catafalco e lo hanno circondato di fiori bianchi. Una montagna di fiori,
gigli soprattutto.
Siamo impietrite per lo stupore e per l'emozione. La Mandel, con il suo
senso dello spettacolo, ha fatto dividere le ragazze in due gruppi e li ha fatti
disporre intorno al catafalco. Guardiamo Alma, incapaci di parlare, la
gola secca, le une contro le altre, prive persino di pensieri. Ha il viso disteso,
calmo, riposato; le mani, molto belle, incrociate sul petto, stringono un fiore.
Si è udito un singhiozzo e tutte ci siamo messe a piangere. Arrivano
le SS, si tolgono il berretto, sfilano ai piedi del catafalco. Sono tutti commossi,
molti piangono, la Mandel ha gli occhi pieni di pianto. E intanto continuano
ad arrivare i treni, le camere a gas non smettono di funzionare, i crematori
fumano; ma qui, con le lacrime agli occhi, le SS rendono omaggio a un'ebrea
che hanno coperto di fiori bianchi.
La Fenelon
descrive anche Mala Zimetbaum,
uno dei personaggi più noti di Auschwitz. La
Zimetbaum riuscirà, in seguito, a fuggire dal
campo il 24 giugno 1944, insieme al suo ragazzo polacco, con delle uniformi
delle SS. Arrivarono fino alla frontiera slovacca, ma furono ripresi, riportati
al campo e impiccati pubblicamente.
Le SS se ne vanno. Per ultima esce l'interprete e mi sembra che abbia un attimo
di esitazione. Si chiama Mala. E' un personaggio leggendario. La piccola
Irene mi racconta:
- Mala era nella Resistenza belga. E' stata deportata da Bruxelles con
uno dei primi convogli. L'hanno subito selezionata perla camera a gas, ma i
forni erano intasati. Mala e le sue compagne sono rimaste ad aspettate il loro
turno nella baracca 25. Nessuno è mai uscito di lì. I prigionieri
stanno in quella stanza nudi, distesi sulla paglia imputridita. Ogni tanto,
quando se ne ricordano, le SS buttano loro qualcosa da mangiare. Ci possono
rimanere mesi, settimane, ore. Finché arriva un camion a prelevarli.
Una sera, Mala riesce a scappare con cinque compagne da una finestrella. Attraversano
il campo di corsa e arrivano in un posto che noi chiamiamo Vorne
vicino alle case delle SS che non abitano dentro il campo. Ci sono le SS che
chiacchierano, fumano, ridono, uno sta suonando l'armonica. Il comandante Hoessler
sta parlando con un ufficiale. Improvvisamente si vedono comparire davanti quelle
ragazze nude. Sono così stupefatti che scoppiano a ridere. Hoessler
domanda da dove vengono. Mala, perfettamente a suo agio come se fosse
vestita, gli risponde che sono scappate dalla baracca 25. Si guardano tra loro
ancora più stupefatti. Sono impressionati, interrogano:
- Come ti chiami?
- Mala.
- Di dove sei?
- Belgio.
- Sai fare qualche mestiere?
- No, ma parlo francese, tedesco e polacco.
- Quanti anni hai?
- Diciannove.
Il comandante riflette un po' in silenzio, poi ordina di vestirle:
- Cercate loro un'occupazione.
- Quella - e indica Mala con la punta del frustino - farà l'interprete.
Per Mala non è stato un modo di imboscarsi. Subito ha pensato
che poteva sfruttare il posto per aiutate gli altri. E' diventata una persona
di una certa importanza nel lager, l'hanno nominata capo interprete. Non si
capisce perché le SS si fidino di lei, che non ha mai dato prove di zelo
con denunce e cose del genere. Forse perché è coraggiosa, silenziosa,
efficiente, calma. Le deportate la stimano, le vogliono bene. Di lei ci fidiamo
ciecamente. Si sa che Mala dimentica di mettere qualche nome sull'elenco, tutte
le volte che le circostanze di una selezione glielo permettono. Chi ha qualche
problema si rivolge a lei. Anche se è un'ebrea, le ariane la rispettano;
nessuna la prende in giro. E non è tutto. Mala ha un ragazzo. Si chiama
Edek, faceva parte della Resistenza polacca. Riescono a incontrarsi perché
frequentano gli stessi uffici. Non so altro.
Un altro episodio descritto è l'improvvisa e inaspettata
cura della Mandel per un
bambino. Il campo è affollato di polacche, di ariane e di bambini.
Frau Maria Mandel, impeccabile nella sua uniforme, viene verso di noi,
si fa largo in mezzo ai corpi, é irritata e nauseata. Le si fa incontro
un bambino biondo e riccioluto di due o tre anni, si afferra ai suoi stivali,
la tira per la gonna. Ci aspettiamo di vedere la Mandel liberarsi del bambino
con una pedata; invece si china, lo prende in braccio, lo bacia. La scena è
così strana che per un attimo l'orchestra smette di suonare. La Mandel
si allontana con il bambino in braccio. Le donne la guardano passare; una polacca
la insegue piangendo, ma una folla di corpi le separa. La Mandel sparisce in
distanza.
L'andirivieni dei camion è durato tutta la notte. I colpi di fischietto
non ci hanno lasciato dormire. Al mattino, di fuori, non c'è più
una sola donna, un solo bambino, un solo cartoccio. L'ordine è tornato
perfetto.
Siamo ancora consegnate, il Blocksperre si protrarrà per tutto
il giorno: in un giorno, i crematori possono bruciare ventiquattromila cadaveri.
Le ragazze del Canada sembrano impietrite davanti all'incredibile mucchio
di abiti da bambino che devono smistare, impacchettare e spedire a Berlino.
Durante le prove, arriva la Mandel con il bambino in braccio. Lo ha fatto
vestire come il figlio di un principe, tutto in blu. In mano, il bimbo ha una
tavoletta di cioccolata che protende verso la Mandel. Lei si schermisce, lui
insiste ridendo, lei fa finta di mangiare, tutti e due si divertono.
Seduta con il bambino sulle ginocchia, si compiace del nostro interessamento,
è fiera di quel bimbo e continua a ripetere: «E' bello, vero?»
come una mamma inorgoglita. Il bimbo si mette in piedi sulle gambe della Mandel,
le sgualcisce gli abiti, le sporca la gonna con le scarpe, la bacia con la bocca
sporca di cioccolata. La Mandel ride. Se ne va tenendo il bimbo per mano, non
più con la solita falcata, ma lentamente, adattando il passo al trotterellare
del bambino.
Per una settimana. la si vede girare per il campo con quel bambino attaccato
alle sottane. Il bambino indossa un completino nuovo tutti i giorni. Sembra
che le ragazze del Canada stiano impazzendo: la signora vuole esclusivamente
vestitini blu. Piove rabbiosamente.
La maggior parte delle ragazze è già andata a dormire, quando
ci annunciano l'arrivo della Mandel, che entra avviluppata in un grande mantello
nero. Pallida, gli occhi cerchiati, chiede il duetto della Butterfly.
Alla fine del pezzo, si alza e se ne va senza dire parola.
L'indomani, Ingrid, la sorella di Marta, ci dice che la Mandel
ha accompagnato il bambino alla camera a gas.
Le ragazze piangono. Piangono per il bimbo e, senza saperlo, anche per quella
donna, della quale le ungheresi dicono che ha marciato sul loro cuore.
Francesco
Saverio Pancheri
Massimiliano Kolbe
Edizioni Messaggero, Padova, 1994
I piani di Hitler contemplavano non solo lo sterminio totale degli ebrei, ma anche
quello delle persone con handicap, dei malati di mente (attuato in Germania col
nome di programma Eutanasia),
degli zingari (all'inizio favorevolmente visti da Hitler, in quanto di razza
ariana purissima) e lo sterminio parziale delle razze slave, dei polacchi e dei
russi. Ritenuti inferiori, dovevano essere ridotti ad 1/3, le loro terre occupate
da coloni tedeschi ed il terzo restante usato come forza lavoro.
Auschwitz nacque, per questo,
come luogo di internamento e sterminio per i polacchi. La sopravvivenza media
nel campo era di tre mesi.
Tutta la classe dirigente ed intellettuale polacca fu perseguitata. Fra gli altri,
molti preti furono internati. Massimiliano Kolbe,
prete francescano polacco, ebbe la medesima sorte. Quando dalla sua squadra
di lavoro fuggì un internato, dieci persone dovettero morire per quella
fuga.
L'internato Gajowniczek,
scelto a caso con gli altri, scoppiò in pianto, invocando la moglie ed
i figli. P.Kolbe si fece avanti ed alla domanda dell'ufficiale tedesco
Fritsch:
Che cosa vuole quel porco polacco?
Padre Kolbe risponde:
Sono un sacerdote cattolico polacco; sono anziano, voglio morire al suo posto,
perché egli ha moglie e figli.
Avvenuto il cambio, i dieci furono denudati e fatti morire di fame in una delle
celle del Bunker della morte. Dopo due settimane gli ultimi 4 sopravvissuti, fra
cui Kolbe, furono uccisi con una iniezione di fenolo. Il libro racconta la sua
storia. Gajowniczek sopravvisse
al campo.
In un'appendice a Il nazismo ed i
lager, Vittorio Emanuele
Giuntella affronta il problema
della fede nei lager. In quel contesto descrive anche la vita del clero e delle
suore detenute:
Nei KZ i sacerdoti non erano presenti se non come detenuti senza altra distinzione,
che non fosse quella di un più crudele trattamento quando erano riconosciuti.
Solo a Dachau vi erano alcune baracche ad essi riservate; per interessamento
della Santa Sede, vi furono negli ultimi tempi concentrati quasi tutti i sacerdoti
internati. Ma anche a Dachau i preti internati non potevano svolgere attività
presso i loro compagni di pena, e per di più solo ad alcuni di essi era
consentita una vita religiosa sistematica. Si arrivò al triste spettacolo
di preti internati che difendevano il loro privilegio vigilando agli ingressi
della parte di baracca che fungeva da cappella, perché gli altri non potessero
entrarvi, specie durante la celebrazione della Messa, alle cinque del mattino,
prima dell'appello. “La verité - scrive uno dei preti di Dachau - c'est
que ce double privilège: - rassemblement des pretes et possibilité
d'une chapelle correctement équipée - était encore une forme
diabolique de l'action psycologique des nazis à laquelle il était
difficile d'échapper”. Egli non esita, perciò, a definire la sorveglianza
della baracca-cappella una “sinistre derision du sacerdoce”. Ma non erano pochi
i sacerdoti che, sfidando un rischio mortale, penetravano negli altri blocchi
e soprattutto in quelli dove erano rinchiusi gli ammalati e in quelli di quarantena
per distribuire la Comunione. Poiché tra i preti internati vi era anche
un vescovo, mons. Piquet di Clermont Ferrand, fu possibile anche
un'ordinazione sacerdotale. Un altro caso singolare è quello del campo
di Bojanowo, riservato alle suore polacche dei territori annessi al Reich
(il cosiddetto Wartherland). Nato dal timore che la presenza di suore polacche
costituisse una remora alla germanizzazione della regione, finì per essere
un altro degli strumenti di dominio e di terrore creati dai nazisti per distruggere
dalle fondamenta la nazione polacca. In quest'ordine di idee i governanti nazisti
non sentirono la sproporzione tra il pericolo rappresentato dalle suore in libertà
e il modo di difendersi da esso, e non avvertirono neppure il ridicolo della creazione
di un campo speciale per suore. Per quel che attiene più specificatamente
alla presente ricerca, si deve sottolineare il fatto che inizialmente le suore,
essendo rimaste riunite per congregazioni, riuscirono a mantenere le loro caratteristiche
comunitarie, adattandole alle condizioni della vita nel campo. Successivamente
anche questa naturale aggregazione parve pericolosa ai nazisti, che alla meta
di giugno 1941 spezzarono le comunità, separandole dalle loro superiore
e sparpagliandole in diverse baracche del campo. Sembrò pericolosa, e fu
proibita, la recita del breviario in comune. In altre parole i nazisti cercarono
anche a Bojanowo di umiliare la personalità delle internate, sopprimendo
il più possibile i legami con il proprio passato e la condizione anteriore.
In questa lotta, però, chi prevalse furono le suore, che assoggettate anch'esse
a lavoro che rendesse all'economia di guerra del Reich, riuscirono a organizzare
una loro vita monastica, alla quale la stessa dispersione e frammischiamento diede
un nuovo senso e una più valida dimensione, anche se l'unico legame istituzionale
tollerato fosse la partecipazione domenicale alla Messa, celebrata all'interno
del campo.
Art Spiegelman
Maus. Racconto di un sopravvissuto
Milano Libri, Milano, 1994
e
Note su La scrittura di Maus
La centrale dell'arte, Roma, 1994
Maus
è la storia di Vladek Spiegelman,
un ebreo sopravvissuto allo sterminio e di suo figlio, un disegnatore che,
dopo aver registrato la testimonianza dalla viva voce del padre, la riproduce
in un fumetto, in cui i nazisti sono gatti, gli ebrei topi.
Maus racconta insieme
due storie. La prima consiste nel resoconto del padre, come egli e sua moglie
riuscirono a sopravvivere. La seconda ci mostra il difficile rapporto dell'autore
con l'anziano padre, segnato in modo irrimediabile da ciò che ha vissuto.
Dal campo di Auschwitz I,
dove è stato deportato, Vladek Spiegelman viene a sapere che la moglie,
internata nel Lager femminile ad Auschwitz-Birkenau
è ancora viva.
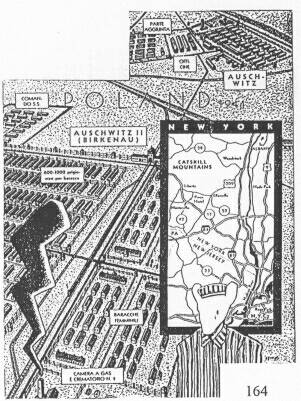


Bruno
Piazza
Perché gli altri dimenticano
Feltrinelli, Milano, 1995
Bruno Piazza, triestino,
di famiglia ebraica, internato ad Auschwitz viene sottoposto alla selezione
il 19 settembre 1944.
Gli assistenti guardavano in giro che nessuno mancasse. Quando si constatò
che c'eravamo tutti, in fila per cinque, il capo blocco ci ordinò di
attendere, così nudi, l'arrivo del Lagerarzt.
Arrivò quasi subito. Era un tedesco alto e robusto, dai tratti regolari
e dall'andatura elegante. Da lui dipendevano centinaia di vite umane, perché
era responsabile delle selezioni. Un suo sguardo, un suo cenno, una sua parola,
erano una condanna a morte... Si chiamava dottor Mengherle.
Nel resoconto, scritto da Piazza
nel 1946, il nome di Menghele
viene da lui scritto con una r
in più. C'è solo la memoria personale, non ancora gli studi storici
sui criminali medici nazisti.
Ad ogni arrivo di ebrei ad Auschwitz era presente nella sala d'ingresso dove
sceglieva le vittime. Non auscultava, non toccava, non scrutava. Guardava solamente.
Una breve occhiata gli bastava per capire se uno poteva continuare a vivere
o se doveva morire subito. La percentuale dei condannati a morte era altissima...
Degli ebrei, in media, soltanto il venti per cento veniva ammesso nelle baracche:
l'ottanta per cento era subito giudicato inservibile e mandato a bruciare
nei forni.
Menghele
si avvicina a Piazza.
Mi si fermò davanti ed incontrai il suo sguardo fermo e freddo. Mi parve
di notare in lui un attimo di indecisione, di perplessità. Ero tutto
nudo, ma avevo i calzoni sui piedi. Con la mano il capitano mi fece cenno di
voltarmi. Mi girai e nel farlo i calzoni mi furono d'inciampo e vacillai. Quando
ritornai nella posizione di prima il dottor Mengherle era passato avanti,
ma lo scrivano mi alzò il braccio sinistro e, avvicinandoselo agli occhi,
segnò sul taccuino il mio numero: 190.712.
Ero condannato a morte.
Fu condotto, con altre ottocento persone, a sera, nella camera
a gas del crematorio. Incredibilmente passarono lì tutta la notte e la
giornata seguente.
In quell'ambiente, angusto per tutta quella gente, l'aria divenne presto irrespirabile.
Non c'era un'apertura, una fessura da cui potesse giungere un filo d'aria. Mi
sentivo soffocare e cercai di spingermi verso la porta, nella speranza che là
sarei stato meglio. Ma era un'illusione. Mi lasciai cadere addosso ai bambini
lituani che avevano cercato di sedersi in gruppo, ed essi, gridando e piangendo,
mi fecero un po' di posto. Accarezzavo i più vicini, ed essi mi guardavano
con i loro occhi spaventati e lacrimosi. Si lasciavano accarezzare, si calmavano
un attimo, poi ricominciavano a piangere silenziosamente.
Anche degli adulti qualcuno piangeva, ma i più se ne stavano silenziosi.
Vedevo una lunga fila di malati in camicia che, con le spalle addossate al muro,
con gli occhi chiusi, cercavano di dormire per far trascorrere quelle ore tremende.
Pochi ci riuscivano. Soltanto qualcuno russava, in quell'incomoda posizione,
lasciando sfuggire dalle labbra un rantolo.
Via via che le ore passavano il tanfo aumentava.
C'erano molti ammalati di enterocolite e di dissenteria che, traballando e inciampando
sui corpi dei compagni, cercavano invano uno spazio libero dove posare la punta
dei piedi e intanto defecavano addosso agli uomini che avevano sotto.
Stordito com'ero dalla mancanza di aria e dall'impossibilità di prendere
sonno, pensavo confusamente alla mia vita trascorsa e mi sovveniva che nemmeno
negli incubi più spaventosi avevo potuto pensare a un simile orrore.
La notte non terminava mai. Dei miei compagni alcuni pregavano fervorosamente,
battendo il petto con un lungo gemito, altri, con espressione disperata, fissavano
il vuoto, come inebetiti.
“Ora bisogna che mi alzi, che arrivi fino in mezzo alla sala,” mi dissi ad un
certo punto. Cento mani si alzarono per aiutarmi a passare. Erano diventati
tutti buoni. Uno dei miei compagni di morte mi chiese una sigaretta. Era un
ebreo polacco di nome Brudginsky, piccolo e svelto. Lo conoscevo perché
aveva dormito fino al giorno prima nella mia baracca. Era un trafficante nato.
Vendeva zuppa e acquistava pane, vendeva pane e acquistava sigarette. Era stato
scelto per il crematorio insieme a me, sullo spiazzo. Aveva lasciato nella baracca
i suoi due figli, deportati assieme a lui, due buoni giovani, sani e robusti.
Mi propose uno scambio, che, senza la morte imminente, sarebbe stato disastroso
per lui: “Se mi dà una sigaretta, le do la mia cintura di vera pelle.”
Non avevo sigarette nemmeno per me. Fece un gesto di dispetto e cercò
altrove.
A cosa poteva servirmi la sua cintura di vera pelle? Involontariamente sorrisi.
Certe persone stentano a perdere le loro abitudini, anche in punto di morte.
Alle sei della sera seguente uno scrivano aprì la porta
e chiamò undici numeri. Erano gli ebrei di sangue misto, prigionieri
politici. Quel giorno furono risparmiati in undici su ottocento.
Bruno Piazza fu l'ultimo degli undici numeri. Le porte
furono poi richiuse e subito tutti gli altri furono gassati.
Piazza riuscì a tornare a Trieste,
alla liberazione del campo, terminò questo libro, ma, fortemente minato
nel fisico, morì subito dopo, nel 1946.
Giuliana
Tedeschi
C'è un punto della terra...Una donna nel
Lager di Birkenau
Giuntina, Firenze, 1988
Giuliana Tedeschi, milanese,
fu denunciata dai fascisti ai nazisti, perché ebrea e deportata ad Auschwitz.
Nel suo libro descrive il giorno in cui cinquanta donne furono prelevate dal lager
di Birkenau, senza spiegazione. Pensavano di essere state scelte per la camera
a gas. Invece dovevano trasportare al Canada
(così si chiamava la parte del campo dove erano ammassati tutti i beni
dei deportati e degli uccisi, luogo dove si trovava ogni cosa), un lugubre carico.
Le donne entrarono per la gran porta e sostarono nell'atrio. Le attendevano colà
cinquanta carrozzine da bimbo. Il tedesco ordinò a ciascuna di prendere
una carrozzina e di spingerla, in fila per cinque, per tre chilometri fino al
magazzino dove veniva raccolto e smistato il bottino dei convogli.
La tensione nervosa si attenuò, ma su ogni volto si stampò una piega
di dolore. Lo strano corteo si mosse: le madri che avevano lasciato dei figli
lontano poggiavano le mani sul manubrio cercando istintivamente la posizione più
naturale, alzando dinanzi agli ostacoli prontamente le ruote anteriori. Vedevano
giardini, viali, bimbi rosei addormentati nelle carrozzine sotto vaporose copertine
rosa e celesti. Le donne che avevano perduto i bambini al crematorio provavano
lo struggimento fisico di aver un piccolo attaccato al seno e non vedevano che
un lungo pennacchio di fumo che si perdeva nell'infinito. Quelle che non erano
state madri, spingendo maldestre le carrozzine, pensavano che mai lo sarebbero
diventate e ringraziavano Dio. E tutte le carrozzine vuote stridevano, sussultavano
e si urtavano con l'aria stanca e desolata degli esuli perseguitati.
Descrive anche la terribile esperienza del parto nel Lager.
Verso mezzogiorno finalmente la notizia: Edith stava bene, era nato un
bel maschio di quattro chili, aveva aperto gli occhi, vagito e tosto li aveva
richiusi per sempre. Lo deposero in una scatola di cartone in cantina.
Le donne andavano a vederlo e commosse dicevano:
- Un bel maschietto. Meglio così... - oppure: - Peccato...
Non volli vederlo. Piansi con la testa nascosta nelle coperte, non so se più
per la tua nascita o più per la tua morte, mio piccolo bimbo.
Lui voleva solo una culla coi fiocchi, i golfini usciti soffici dalle mani della
mamma e della nonna, come hanno tutti i bimbi del mondo. Ma l'epoca dei miracoli
è tramontata da un pezzo. Così pure la stella cometa, il bue e l'asinello.
Liana
Millu
Il fumo di Birkenau
Giuntina, Firenze, 1995
Liana Millu pubblicò
nel 1947, appena tornata da Auschwitz, questo testo.
Primo Levi, nella prefazione, così dice della
condizione femminile a Birkenau.
La loro condizione era assai peggiore di quella degli uomini, e ciò per
vari motivi: la minore resistenza fisica di fronte a lavori più pesanti
e umilianti di quelli inflitti agli uomini; il tormento degli affetti familiari;
la presenza ossessiva dei crematori, le cui ciminiere, situate nel bel mezzo del
campo femminile, non eludibili, non negabili, corrompono col loro fumo empio i
giorni e le notti, i momenti di tregua e di illusione, i sogni e le timide speranze.
Queste storie di donne vengono salvate dall'oblio dal lavoro della
Millu.
Lily, mandata a morte con un cenno indifferente della mano da parte della
sua Capo, che sospetta in lei una rivale in amore. Maria, che entra in
Lager senza denunciare la sua gravidanza, anzi la nasconde fasciandosi il ventre,
perché vuole che il bambino nasca: e nasce, infatti, nella bolgia notturna
della baracca lurida e gremita, senza luce, senz'acqua, senza un panno pulito,
in mezzo alla follia collettiva ed alla ridestata pietà delle prigioniere
più indurite (è questa forse la pagina più memorabile del
libro): ma l'Appello è sacro, nessuna deve mancare, la puerpera e il bambino
si dissanguano, e ad appello finito sono morti.
Bruna ritrova Pinin, il suo figlio adolescente, in un Lager contiguo:
si abbracciano attraverso il reticolato elettrico, rimanendo fulminati. La russa
Zina si gioca la vita per favorire la fuga di Ivan, che non conosce,
ma in cui ravvisa una immaginaria rassomiglianza col marito Grigori ucciso
dai nazisti. Le due sorelle olandesi, di cui l'una sceglie la via del bordello,
e l'altra la rinnega, rifiutando stoicamente i suoi doni. La moglie innamorata,
combattuta fra due possibili destini: mantenere fede al marito, e morire di fame,
oppure cedere, disonorarsi ma conservarsi per lui.
Da ognuno di questi itinerari umani in un modo disumano emerge un'aura di tristezza
lirica, mai inquinata dalla collera o dal lamento scomposto; e di dolorosa sapienza
mondana, a dimostrare che l'autrice non ha sofferto invano.
Edith
Stein
Storia di una famiglia ebrea
Città Nuova, Roma, 1992
Edith Stein era assistente
del professor Edmund Husserl,
nella Facoltà di Filosofia di Friburgo in Breslavia. Così racconta
di lei la sorella Erna Biberstein-Stein:
Edith mi confidò la sua decisione di convertirsi al cattolicesimo,
pregandomi di fare in modo che nostra madre si abituasse all'idea. Mi resi conto
che questa era una delle prove più difficili che avesse mai affrontato.
Pur avendo mostrato sempre la più ampia comprensione nei nostri confronti
e averci lasciato la massima libertà in ogni campo, la decisione di Edith
fu un durissimo colpo per lei, che era un'ebrea credente; il fatto che la propria
figlia si convertisse ad un'altra religione ne faceva una rinnegata dal suo punto
di vista. Anche per noi altri non fu facile. Tuttavia, dopo aver inutilmente cercato
di distoglierla dal suo proposito per amore di nostra madre, accettammo, sia pure
a malincuore, la decisione di Edith, poiché nutrivamo grande fiducia nelle
sue intime convinzioni...
Nel 1933, a causa delle sue origini ebraiche, Edith dovette rinunciare al suo
incarico di docente all'Accademia cattolica di Munster e tornò di
nuovo a casa. Anche in questa occasione confidò a me per prima il suo proposito
di entrare nel convento delle Carmelitane di Colonia. Le settimane che
seguirono furono molto penose per noi tutti. Mia madre era veramente disperata
e non riuscì mai a superare questo dolore. Anche noi sentivamo che stavolta
la separazione sarebbe stata molto più radicale, malgrado Edith non volesse
riconoscerlo e continuasse in seguito a partecipare, dal convento, ad ogni avvenimento
familiare con immutato interesse e affetto.
Quando, nel febbraio 1939, mi misi in viaggio con i miei bambini per raggiungere
mio marito in America, Edith avrebbe voluto che andassimo a trovarla a Echt,
dove nel frattempo si era trasferita. Ma i nostri biglietti erano per Amburgo,
e poiché il confine olandese era particolarmente difficile da superare,
non potemmo farlo. In seguito restammo in contatto epistolare. Mi sentivo relativamente
tranquilla, pensando che il convento offrisse a Edith e a nostra sorella Rosa
- che nel frattempo l'aveva raggiunta a Echt - un rifugio sicuro dall'aggressione
di Hitler.
Purtroppo tale supposizione si rivelò infondata. I nazisti non si fermarono
neppure di fronte al convento, ma deportarono le mie due sorelle il 2 agosto 1942.
Da quel giorno non abbiamo saputo più nulla di loro.
La Stein fu deportata ad Auschwitz,
dove fu selezionata per il gas all'arrivo.
Pinuccia
Scaramuzzetti
Un olocausto dimenticato
da Servizio Migranti 2 (1993)
Pochissimi ricordano lo sterminio nazista degli zingari.
Hitler ed i gerarchi nazisti ebbero, in principio, un fortissimo interesse per
il popolo zingaro. Erano, infatti, coscienti che erano “di purissima razza ariana”,
essendo di origine indoeuropea, senza aver mai avuto commistione con altri popoli
attraverso matrimoni misti.
Vennero successivamente perseguitati perché “asociali”.
Così Giovanni Paolo II
ha commemorato il cinquantesimo anniversario del primo trasporto di zingari nel
campo di Auschwitz-Birkenau
(febbraio 1943):
Insieme con tutti i partecipanti alle celebrazioni,
con profonda commozione e venerazione, mi inginocchio su quella terra che nasconde
in sé le ceneri delle vittime del genocidio nazista, ricordando in maniera
particolare la tragica sorte dei Fratelli e Sorelle Zingari, prigionieri del campo
di concentramento di Auschwitz-Birkenau. L'ho fatto diverse volte quale Metropolita
di Cracovia, oggi lo faccio come Papa.
L'articolo della Scaramozzetti
delinea i dati essenziali di questo olocausto dimenticato:
Il 16 dicembre 1942 un'ordinanza di Himmler impose il trasferimento di
tutti gli zingari tedeschi ad Auschwitz dove si aprì un settore
speciale per i gitani. Nei mesi di febbraio-marzo 1943 si intensificarono i rastrellamenti
in Germania e nei Paesi occupati. Interi vagoni di deportati furono immediatamente
condotti alle camere a gas, soprattutto quelli provenienti dall'Est. Dopo 16 mesi
la sezione venne chiusa con la gassazione in una sola notte (presumibilmente il
3 agosto) degli ultimi 4.000 prigionieri che vi si trovavano.
Dalle registrazioni appare che furono almeno 20.000 gli appartenenti a questo
popolo entrati ad Auschwitz e solo 4.000 ne uscirono per essere dirottati verso
altri campi: 16.000 risultano deceduti.
Questo è il fiore all'occhiello dei nazisti riguardo alle deportazioni
ed esecuzioni operate dal '39 in poi nei confronti degli zingari. Secondo Rudolf
Hoess, comandante del campo di Auschwitz, essi cominciarono ad essere condotti
nei campi già prima della guerra.
Kenrick e Puxon (1972), che hanno stilato una tabella con rigore,
contano 219.700 morti fra i deportati di questo popolo, ma bisogna aggiungere
quanti non si sono fatti riconoscere come zingari, quanti ai campi non sono mai
arrivati perché uccisi durante le incursioni che le varie milizie operavano
nei campi dei nomadi, quanti sono deceduti durante le esecuzioni di massa prima
di ogni registrazione. Gli specialisti governativi incaricati di redigere i libri
bianchi dei crimini di guerra affermano che 500.000 zingari sono scomparsi nei
vari campi di concentramento (Bernadac, 1988).
Giovanna
Boursier/Massimo Converso/Fabio Iacomini
Zigeuner. Lo sterminio dimenticato
Roma, Sinnos Editrice, 1996
Solo per tre categorie di persone, gli ebrei, i disabili
ed i malati di mente e gli zingari il Terzo Reich aveva decretato l'annientamento
totale.
Giovanna Boursier così spiega:
La soluzione finale della questione zingara fu decretata il 16 dicembre1942, quando
Himmler firmò l'ordine di internare, o trasferire, ad Auschwitz
tutti gli zingari. Una sezione del Lager, denominata BIIe di Birkenau,
venne loro destinata. Era lo Zigeunerlager, un settore riservato solo agli
zingari, che vi vivevano in condizioni particolari, diverse da quelle riservate
agli altri prigionieri.
Nella primavera del 1943 il numero degli zingari internati era
di circa 16.000 persone. Langbein
racconta che nel 1944 fu decisa la soppressione degli ultimi 4000 ancora sopravvissuti:
Per ordine della Centrale, il 1° agosto vennero portati alle camere
a gas gli internati nel Lager degli zingari. Ci fu chi poté salvarsi e
su queste eccezioni ecco la testimonianza di Regina Steinberg che, come
scrivana della sezione politica, poteva avere la miglior visione di quello che
accadeva in questa sezione del Lager:
Furono convocati quegli zingari che erano stati combattenti al
fronte e che, a Pasqua del 1944, dal fronte erano stati deportati al Lager.
Broad (che dirigeva la sezione politica di questa sezione
del Lager) disse loro che, se accettavano di farsi sterilizzare, sarebbero stati
liberati. Chi acconsentì fu trasferito al Lager principale, sterilizzato
e quindi rimandato da noi. Il giorno stabilito per l'eccidio o quello precedente,
costoro furono portati ad Auschwitz e messi in quarantena.
Uno fra loro che si assoggettarono a questo intervento testimoniò davanti
al tribunale:
Il giorno prima che il Lager degli zingari venisse completamente
liquidato da noi, che avevamo già fatto parte della Wehrmacht, fummo portati
a Ravensbruck per la sterilizzazione.
Dopo di ciò potevamo rioffrirci come volontari nella Wehrmacht e fummo
riammessi anche nel corso dell'anno 1945. Gli altri furono invece mandati alle
camere a gas. Nel 1945 venni anche ferito in guerra.
Nonostante tutto, esisteva una procedura particolare per gli zingari,
diversa da quella per gli ebrei. Il Reich ricordava che gli zingari sono di provenienza
indoeuropea e, per ciò, nell'immaginario nazista, prossimi alla razza ariana.
Classificati come asociali potevano essere sterilizzati per impedire una discendenza,
ma sopravvivere, per le benemerenze dimostrate verso la Germania, ad esempio come
militari in guerra.
[Indice]
|

