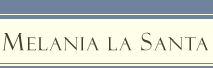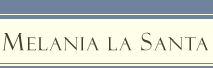|
"Pelagio andava diffondendo con successo una dottrina
di impegno sul piano morale fondata sulla convinzione che l'uomo, in forza del
suo libero arbitrio, aveva capacità di salvarsi con le sue sole forze,
solo esteriormente e accessoriamente soccorso dalla grazia divina, poiché
il peccato di Adamo non aveva integralmente corrotto la natura umana fino al
punto di impedirle di fare il bene: di conseguenza Pelagio, e più apertamente
il suo discepolo Celestio, negavano l'esistenza del peccato originale trasmesso
da Adamo a tutti i suoi discendenti e combattevano la pratica del battesimo
degli infanti, allora già abbastanza diffusa. Agostino era chiamato direttamente
in causa perché Pelagio aveva fatto riferimento ad affermazioni antimanichee
di Agostino contenute nel De libero arbitrio, e poi per la presenza di Celestio
in Africa: ma soprattutto erano i presupposti della dottrina di Pelagio che
egli non poteva condividere perché la sua riflessione e la sua stessa
esperienza lo avevano portato gradualmente ad accentuare l'indegnità
dell'uomo rispetto a Dio, la sua radicale incapacità di bene operare
e di conseguire la totale dipendenza dalla grazia divina nel volere e nell'agire:
"da quod iube et iube quod vis" ("da ciò che prdini ed
ordina ciò che vuoi")" Così M.Simonetti in La letteratura
cristiana antica greca e latina, Sansoni/Accademia, Firenze, 1969, sintetizza
il problema che la Chiesa si trovava dinanzi. Anche Melania, come tutto il monachesimo
del suo tempo, ci appare profondamente attenta a tutte le questioni teologiche
allora dibattute e si rivela protagonista della lotta fra la grande Chiesa e
l'eresia. Nella Vita di Geronzio, ne vediamo l'accesa tensione anti-nestoriana,
attraverso l'opera agostiniana intravediamo, invece, la sua partecipazione alla
polemica pelagiana.
Pelagio, un monaco di origine britannica (solo Girolamo indica
un origine irlandese), giunse a Roma intorno al 390 d.C. e subito si conquistò,
soprattutto presso l'aristocrazia romana, un grande seguito di persone dedite
con lui alla vita ascetica (fra di esse, spicca, appunto, il suo discepolo Celestio).
Giustamente Agostino presenta la posizione pelagiana come la "nuova eresia
della cristianità" (Retract. II, 33).
Pelagio si recò in Palestina nel 412-413 e, quando
Melania, Piniano ed Albina, giunsero lì, lo conobbero personalmente.
Così il grande studioso agostiniano Agostino Trapé ricostruisce
il successivo svolgersi dei fatti, a partire dai testi agostiniani:
"L'occasione di scrivere La grazia dfi Cristo e il peccato
originale gliela offrirono i tre nobili e pii romani Albina, Piniano e Melania,
i quali si erano trasferiti da poco dall'Africa, dove avevano passato alcuni
anni alla scuola di Alipio e dello stesso Agostino, in Palestina. Qui s'incontrarono
con Pelagio. Sembra che l'iniziativa dell'incontro fosse loro. In questo caso
ne fu motivo il desiderio di aiutare lo stimato maestro degli ambienti spirituali
della capitale a chiarire le sue idee e a sottrarsi al sospetto o alla condanna
di eterodossia. Se poi l'iniziativa partì da Pelagio fu certamente suggerita
dal desiderio di riavvicinarsi, tramite amici comuni, al vescovo d'Ippona. In
ogni modo l'intento per i nostri tre era chiaro: indurre Pelagio "a condannare
per iscritto quanto si diceva contro di lui”. Ne ebbero due dichiarazioni riguardanti
i due punti essenziali della controversia, la grazia e il peccato originale.
La prima, a proposito della grazia, suonava cosi: "Anatematizzzo
chi pensa o dice che la grazia di Dio, in virtù della quale il Cristo
è venuto in questo mondo per salvare i peccatori, non è necessaria
non solo nelle singole ore o nei singoli momenti, ma anche per le nostre singole
azioni; e coloro che tentano di eliminare la grazia finiscano nelle pene eterne".
La seconda, riguardante il peccato originale, diceva "che
i bambini si devono battezzare con le medesime parole del rito sacramentale
con le quali si battezzano anche i grandi".
Le risposte sembrarono loro sufficienti, e se ne rallegrarono;
ma intesero il bisogno di consultare 1'amico e il maestro. La lettera raggiunse
Agostino quand'era a Cartagine. Rispose subito, nonostante gli impegni che,
soprattutto in quella città, lo tenevano occupato.
La risposta si rivolge insieme ai due aspetti del problema
posti dall'insegnamento di Pelagio: il primo riguardava il suo vero pensiero
— e su questo Agostino era stato consultato; il secondo riguardava la compatibilità
di questo pensiero con la fede cattolica — e su questo Agostino entra per
suo conto allo scopo di dissipare un pericoloso equivoco. In ambedue i casi
la risposta è netta ed inequivocabile.
Il contenuto della prima si raccoglie in due affermazioni
connesse e inseparabili: le dichiarazioni di Pelagio, per chi non conosca da
altre fonti il suo pensiero, sono accettabili, cioè possono avere un
significato conforme all'insegnamento della verità cattolica; ma per
chi conosce questo pensiero e le confronti con esso appaiono apertamente equivoche.
"Chiunque ascolta queste parole — si riferisce alla prima dichiarazione
— ignorando il senso che Pelagio con sufficiente evidenza ha espresso nei
suoi libri... crede senz'altro che il suo pensiero collimi con il pensiero della
verità. Chi invece sta attento a ciò che Pelagio dice più
esplicitamente in quei libri, deve ritenere sospette anche queste sue parole".
Lo stesso vale per la seconda dichiarazione (sul peccato originale):
"Chi dopo tale dichiarazione penserebbe di dover muovere ad essi una qualche
questione su questo argomento? Oppure, se lo facesse, a chi non sembrerebbe
calunniosissimo, qualora non si leggessero i loro testi espliciti, dove negano
che i bambini contraggono il peccato originale e sostengono che son nati tutti
senza nessun vizio?".
Agostino, che ha letto tutte le opere di Pelagio, tutte o
quasi tutte, e le cita e le invia ai suoi interlocutori perché possano
farsene un'idea, è convinto che in esse, se si parla di grazia, non se
ne parla come ogni cristiano, per essere e restare tale, deve parlarne, cioè
della grazia quale "ispirazione dell'ardentissima e luminosissima carità",
della grazia ,con la quale Dio "con intervento interiore ed occulto, mirabile
ed ineffabile opera negli animi degli uomini non solo rivelazioni vere, ma anche
volontà buone".
Questa grazia è necessaria non soltanto per poter osservare
più facilmente la legge divina, ma semplicemente per poterla osservare,
anzi da questa grazia dipende sia il posse che l'operari in quanto "non
solo rivela la sapienza, ma la fa pure amare, non solo fa opera suasiva verso
quanto è buono, ma anche opera persuasiva". "Questa è
la grazia - esclama Agostino dopo aver citato Gv 6, 44. 66 - che Pelagio deve
riconoscere se vuole non solo chiamarsi, ma essere cristiano".
Con la stessa fermezza e univocità, anzi quasi con
le stesse parole risponde al secondo aspetto del problema. Pelagio col suo insegnamento
non solo propone una dottrina erronea, ma nega una verità cristiana fondamentale,
intacca la regula fidei qua Christiani sumus. Lo dimostra di proposito in quest'opera,
specialmente nella sezione 2, 23, 26-29,34; e spesso altrove.
Ciò non vuol dire che gli altri modi di parlare della
grazia, che Pelagio usa e Agostino ricorda – dono del libero arbitrio,
conoscenza della legge, remissione dei peccati - non entrino nell'insegnamento
cristiano; vi entrano certamente, ma non sono sufficienti per averne quella
nozione piena che permette di chiamarsi e di essere cristiani".
Per comprendere appieno il tentativo di Melania, Piniano ed Albina dobbiamo considerare
un altro aspetto del problema. Alcuni personaggi del tempo rifiutavano chiaramente
la posizione pelagiana, ma insieme esprimevano dei dubbi sul modo in cui la difesa
della grazia veniva talvolta formulata da Agostino stesso (ed, infatti, non ogni
singolo aspetto della posizione agostiniana venne poi canonizzata dal magistero
della Chiesa). Conosciamo la figura di Paolino di Nola che, pur rifiutando la
posizione pelagiana, esitava sull'interruzione totale dei rapporti con lui. Così
M.Simonetti si esprime a suo proposito e le sue riflessioni possono valere, in
parte, anche per il tentativo dei tre nobili romani presso Pelagio: "Mi limito
a due considerazioni:
1) se da una parte Pelagio enfatizzava all'eccesso, rispetto alla tradizione,
la capacità della natura umana di operare la propria salvezza, dall'altra
Agostino deprimeva tale capacità in termini che a quella tradizione erano
largamente estranei;
2) è semplicistico e, in definitiva, non esatto limitarsi a caratterizzare
la posizione di Agostino in modo generico come quella che difendeva, contro Pelagio,
i diritti della grazia divina nell'opera di salvezza dell'uomo: Agostino infatti
non si limitava ad affermare l'indispensabilità di tale grazia, ma si spingeva
molto più in là, arrivando a sostenere che essa veniva accordata
soltanto a pochi predestinati indipendentemente da loro eventuali meriti, per
giudizio imperscrutabile di Dio. Formulata in questi termini, la dottrina della
grazia risultava per gran parte estranea alla tradizione cattolica, quale si era
precisata soprattutto nella lotta contro lo gnosticismo. Se si tengono presenti
questi due punti, risulta chiaro l'atteggiamento di Paolino e dei tanti che condividevano,
più o meno, il suo punto di vista. Non basta affermare apologeticamente
che Paolino, uso a richiamarsi costantemente alla grazia divina, non poteva condividere
le idee di Pelagio; bisogna infatti anche aggiungere che egli non condivideva
neppure quelle di Agostino: giustamente è stata rilevata, in proposito,
la frequenza con cui Paolino ha occasione di citare 1 Tim 2,4: "Dio vuole
che tutti gli uomini si salvino": infatti questo passo, assunto nel suo ovvio
significato letterale, come faceva appunto Paolino, contrastava nel modo più
diretto il rigido predestinazionismo di Agostino, il quale percio' è tornato
su di esso più volte, con diverse e quanto mai forzate interpretazioni,
perché non lo poteva accettare nel suo significato immediato". La
citazione è da M.Simonetti, Cultura e religiosità in Italia attraverso
l'epistolario di Paolino in Anchora Vitae. Atti del II convegno paoliniano nel
XVI centenario del ritiro di Paolino a Nola, a cura di G.Luongo, Napoli-Roma,
1998, LER.
E' possibile datare con precisione lo scritto La grazia di
Cristo e il peccato originale al giugno-luglio 418.
Presentiamo, a seguire, l'inizio di questo scritto agostiniano con gli espliciti
riferimenti a Melania, Piniano ed Albina:
1) Quanto goda della vostra salute corporale e principalmente della vostra salute
spirituale, o fratelli sincerissimi amati da Dio, Albina, Piniano e Melania, essendomi
impossibile dirlo, lo lascio pensare e credere a voi, per poter subito parlare
piuttosto delle questioni sulle quali mi avete consultato. Poiché era prossima
la partenza del messaggero, ho dettato, come ho potuto e come Dio si è
degnato concedermi, queste pagine in mezzo alle nostre occupazioni, molto più
fitte qui a Cartagine che in tutti gli altri luoghi.
2) Mi avete informato d'esservi adoperati con Pelagio perché condannasse
per scritto tutti gli errori di cui è accusato e che ha risposta davanti
a voi: “Anatematizzo chi pensa o dice che la grazia di Dio, in virtù della
quale il Cristo è venuto in questo mondo per salvare i peccatori,
non è necessaria non solo nelle singole ore o nei singoli momenti, ma anche
per le nostre singole azioni; e coloro che tentano di eliminare la grazia finiscano
nelle pene eterne”. Chiunque ascolta queste parole ignorando il senso che Pelagio
con sufficiente evidenza ha espresso nei suoi libri, non in quelli che dice essergli
stati sottratti prima di poterli correggere o in quelli che nega assolutamente
essere suoi, ma in quelli che ricorda nella sua lettera mandata a Roma, crede
senz'altro che il suo pensiero collimi con il pensiero della verità. Chi
invece sta attento a ciò che Pelagio dice più esplicitamente in
quei libri, deve ritenere sospette anche coteste sue parole. Infatti, sebbene
faccia consistere nella sola remissione dei peccati la grazia di Dio, in virtù
della quale il Cristo è venuto nel mondo a salvare i peccatori,
può aggiustare la sua dichiarazione di sopra ai limiti della remissione
dei peccati dicendo: la grazia è necessaria nelle singole ore, nei singoli
momenti e per le nostre singole azioni, perché, tenendo noi sempre in mente
e richiamandoci alla memoria che ci sono stati rimessi i peccati, non dobbiamo
peccare ulteriormente, aiutati non dalla somministrazione di un qualche potere,
ma dalle sole forze della nostra propria volontà memore nelle singole azioni
di quanto le è stato elargito con la remissione dei peccati. Similmente
poiché i pelagiani sono soliti dire che il Cristo ci ha prestato il suo
aiuto a non peccare per il fatto che ci ha lasciato un bell'esempio vivendo egli
stesso con giustizia ed insegnando con giustizia, possono aggiustare la dichiarazione
di sopra anche ai limiti dell'esemplarità di Gesù e dire che nei
singoli momenti e per le singole nostre azioni è necessaria a noi una grazia
siffatta, quella cioè di saper guardare in ogni nostro comportamento al
comportamento esemplare del Signore. Si accorge benissimo la vostra fede quanto
sia da distinguere questo riconoscimento della grazia da parte di Pelagio dal
riconoscimento della grazia sul quale verte la questione. Eppure può esser
coperta la differenza dall'ambiguità di coteste parole.
[Melania la Santa] - [Testimoni diretti]
|