Il significato della parola jihād: guerra santa o lotta interiore e spirituale? (da un’intervista di Giorgio Paolucci e Camille Eid a Samir Khalil Samir)
Riprendiamo da Cento domande sull’islam. Intervista a Samir Khalil Samir, a cura di Giorgio Paolucci e Camille Eid, Marietti 1820, Genova, 2002, pp. 34-39, alcuni brani dell’intervista stessa. Restiamo a disposizione per l’immediata rimozione se la presenza sul nostro sito non fosse gradita a qualcuno degli aventi diritto. I neretti sono nostri ed hanno l’unico scopo di facilitare la lettura on-line. Per approfondimenti sull’islam, vedi la sezione Cristianesimo, ecumenismo e religioni.
Il Centro culturale Gli scritti (12/5/2013)
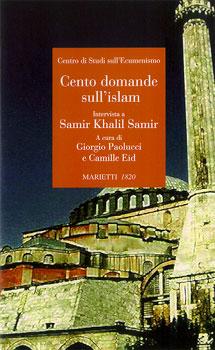
Qual è il significato di un termine molto usato e spesso equivocato come jihād?
La parola jihād deriva dalla radice j-h-d che in arabo evoca uno sforzo, in genere quello bellico. Nel Corano la parola jihād è sempre utilizzata nel senso di lotta per Dio secondo l'espressione integrale jihād fī sabīl Allāh, lotta sul cammino di Dio, e perciò viene tradotta nelle lingue europee, dagli stessi musulmani, come "guerra santa".
Questa traduzione è stata di recente messa in discussione da alcuni studiosi, soprattutto occidentali, secondo i quali il jihād non è la guerra, bensì la lotta spirituale, lo sforzo interiore. Si opera anche la distinzione tra il jihād akbar e il jihād asghar, il grande jihād e il piccolo jihād. Il primo sarebbe la lotta contro l'egoismo e i mali della società - insomma, uno sforzo etico e spirituale -, mentre il secondo sarebbe la guerra santa da combattere contro gli infedeli in nome di Dio.
Tutto ciò è un'elaborazione che non corrisponde né alla tradizione islamica né al linguaggio moderno. Tutti i gruppi islamisti che adottano la parola jihād nel loro nome non la intendono certamente nel suo significato mistico, bensì nell'accezione violenta, e le decine di libri pubblicati negli ultimi anni sul jihād si riferiscono tutti alla guerra santa. Dunque sia a livello storico, dal Corano in poi, sia a livello sociologico, il significato odierno di jihād è univoco e indica la guerra musulmana in nome di Dio per difendere l'islam.
Mi spiego: il jihād è un obbligo di tutti i musulmani adulti, in particolare dei maschi. L'islam conosce, infatti, due tipi di obblighi: l'obbligo individuale e l'obbligo collettivo e il jihād è un obbligo collettivo nel senso che tutta la comunità è tenuta a partecipare se si sente in pericolo. Solo l’imam ha il diritto-dovere di proclamarlo, ma una volta che lo ha fatto tutti i musulmani maschi adulti devono aderire.
Questo è un obbligo stabilito per il musulmano nel Corano, il quale rimprovera spesso ai "tiepidi" di non fare la guerra e di rimanere a casa tranquilli, e li chiama "ipocriti". Quest' obbligo è stato praticato sin dall'inizio da Maometto e riguarda sia la guerra difensiva, quando cioè l'islam viene attaccato, sia quella preventiva, quando il rischio di essere attaccati è imminente. E la guerra deve essere combattuta finché l'ultimo nemico non se ne sia andato oppure sia stato ucciso.
Esistono regole precise per proclamare il jihād? E come si spiega che a volte - pensiamo alla guerra Iran-Iraq, a quella del Golfo oppure alle lotte storiche tra le varie dinastie arabo-musulmane - i Paesi islamici combattono contro altri Paesi islamici?
Una guerra tra fratelli di fede è illecita e inconcepibile in termini giuridici islamici. Per questo motivo, se un leader musulmano ha intenzione di muovere guerra a un Paese musulmano, deve prima dichiarare questo Paese miscredente, ateo, in arabo kāfir. Dichiarando l'altro kāfir, la dichiarazione di guerra diventa legittima e inevitabile, perché viene condotta contro i miscredenti.
Prima di dichiarare guerra ai suoi nemici, Maometto li invitava ad abbracciare l'islam, ripetendo l'invito tre volte. Se rifiutavano li informava dell'imminenza dell'attacco e se si ostinavano ancora li attaccava. Può sembrare qualcosa che appartiene al passato, ma in realtà è quello che abbiamo visto nelle ultime guerre, per esempio nel conflitto Iran-Iraq che ha causato un milione di morti oppure nella guerra del Golfo.
Ciascuna fazione ha dichiarato l'altra kāfir, proclamandosi paladina dell'islam e mettendo sulla propria bandiera, laddove non c'erano prima, i simboli islamici. L'Iraq, un Paese che si definisce laico, ha così inserito nel suo vessillo nazionale le parole Allāh-u Akbar, Dio è il più grande, evidenziando una motivazione religiosa per attaccare l'avversario in nome di Dio.
Lo stesso vale per il Kosovo, la Cecenia, l'Afghanistan, le Filippine, le Molucche e ovunque i musulmani siano in guerra, dove vediamo gruppi armati arrivare da diversi Paesi musulmani per combattere il jihād contro i nemici dell'islam (che sovente sono dei cristiani): si fanno chiamare mujābidīn (che etimologicamente significa coloro che fanno il jihād) e operano in vari Paesi per fomentare rivoluzioni o sostenere ribelli e movimenti di liberazione nazionale[1].
È qui che emerge con chiarezza che l'obiettivo di combattere per l'islam a livello internazionale prevale sulla motivazione politico-nazionale. Per questi gruppi il concetto di comunità islamica (umma) prevale su quello di cittadinanza (watan). Una conferma di questo atteggiamento è venuta anche in occasione del recente conflitto in Afghanistan, con i numerosi casi di arruolamento volontario di musulmani che vivevano in Paesi arabi ma anche occidentali e sceglievano di combattere a fianco dei taleban con l'obiettivo dichiarato di difendere l'islam minacciato dagli "infedeli".
È interessante notare come anche riguardo alla Palestina, dove la guerra è una lotta per l'indipendenza nazionale dei palestinesi dall'occupazione israeliana, anziché mantenere il dibattito sul terreno politico delle rivendicazioni nazionali, i Paesi musulmani lo trasformano in una guerra di religione, in un jihād per la liberazione di quella terra. Il problema di fondo, tuttavia, non è religioso ma politico, anche se molti fanatici palestinesi e israeliani insistono sulla dimensione religiosa. Gli ebrei ortodossi, così come i musulmani ortodossi, hanno infatti la stessa concezione della religione e dello Stato. Una concezione dove tutto è mescolato e le diverse sfere hanno perso la loro autonomia.
Spesso si sente dire in Occidente e in certi ambienti musulmani moderati che questi mujāhidīn non sono veri musulmani, che la loro azione è contraria allo spirito dell'islam, che l'islam significa etimologicamente pace e tolleranza, e così via. È corretta questa precisazione?
Gli occidentali che ripetono queste affermazioni, di solito, dell'islam conoscono ben poco. Accettano volentieri queste tesi provenienti da ambienti musulmani, che in realtà non sono esatte.
Le parole islām e salām derivano effettivamente dalla stessa radice, ma non hanno un contatto diretto. Mi spiego: la radice s-l-m in arabo, come sh-l-m in ebraico e in tutte le lingue semitiche, significa "essere sano", "essere in pace" e c'è un legame semantico tra pace, salvezza, salute, eccetera. Salām, in arabo, significa pace, salāma significa salute, islām significa sottomissione. La parola islām deriva dal verbo aslama, che vuol dire "sottomettersi" o "abbandonarsi a"; l'islām è quindi l'atto di abbandonarsi o di sottomettersi, si sottintende a Dio, ma non significa "mettersi in stato di pace", anche se qualcuno può, con motivazioni spirituali, aggiungere questo significato non etimologico.
La violenza è d'altronde chiaramente presente nella vita stessa di Maometto, come [si nota] nella sua biografia. È qui interessante anche osservare che le prime biografie del fondatore non portano il nome di sīra, come saranno chiamate nel terzo secolo dell'egira (IX secolo dell'era cristiana), bensì quello di kitāb al-maghāzī, ossia "il Libro delle razzie". È stato lo stesso Maometto a condurre sistematicamente, come capo politico, queste razzie, ad organizzarle e conquistare, una dopo l'altra, le varie tribù arabe. E queste si sono sottomesse a lui e al suo Dio, pagando un tributo che permetteva a Maometto di lanciarsi in nuove conquiste.
Subito dopo la sua morte (632) molte tribù si sono ribellate al suo successore, il califfo Abū Bakr al-Siddīq (632-634), rifiutando di continuare a pagare il tributo cosicché il califfo ha dovuto dichiarare loro guerra. Gli storiografi musulmani chiamano queste guerre burūb al-ridda, le guerre degli apostati. Da qui è derivato l'obbligo di uccidere chiunque si tiri indietro, l'apostata che rinnega la sua fede. Bisogna tuttavia aggiungere che i compagni del califfo gli hanno fatto notare che quelle tribù rifiutavano di pagare il tributo senza per questo rigettare l'islam. In realtà le tribù consideravano Maometto più come leader politico che come profeta religioso e non erano disposte, alla sua morte, a riconoscere un altro capo.
La violenza, in definitiva, ha fatto parte dell'islam nascente. In quell'epoca, nessuno trovava nulla di riprovevole nelle azioni belliche di Maometto dato che le guerre erano una componente della cultura beduina dell' Arabia. Ma il problema è che, oggi, i gruppi musulmani più agguerriti continuano ad adottare quel modello. Dicono: «Anche noi dobbiamo portare all'islam i non musulmani come ha fatto il Profeta, con la guerra e la violenza», e fondano queste affermazioni su alcuni versetti del Corano.
Note al testo
[1] Per ulteriori approfondimenti sui diversi movimenti radicali islamici nel mondo vedere Camille Eid, Osama e i suoi fratelli, Pimedit, Milano 2001.



