Il califfato ed i primi 4 califfi successori di Maometto (l’Islamic State si richiama alle istituzioni dell’Islam nascente, ai primi 4 califfi ed al generale Khalid ibn al-Walid, fedelissimo combattente di Maometto: propugna, infatti, un ritorno letterale alle origini dell’Islam. È importante per questo tornare a studiare le origini dell’Islam)
Riprendiamo da l’Enciclopedia italiana della Treccani (edizione degli anni ’20-’30 on-line) alcune voci sul califfato alle origini dell’Islam: non è difficile rendersi conto come i teorici dell’Islamic State intendano riportare la fede musulmana alle sue origini ispirandosi agli eventi che hanno dato origine all’Islam: intendono così cancellare le evoluzioni successive e gli adattamenti che esso ha conosciuto con l’origine dei diversi stati nazionali islamici e l’incontro con la modernità che ha valorizzato la libertà e la ragione. Restiamo a disposizione per l’immediata rimozione se la presenza sul nostro sito non fosse gradita a qualcuno degli aventi diritto. I neretti sono nostri ed hanno l’unico scopo di facilitare la lettura on-line.
Il Centro culturale Gli scritti (1/12/2014)
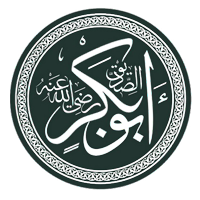
Calligrafia di Abu Bakr,
primo califfo
1/ Califfo, di Carlo Alfonso Nallino (Enciclopedia Italiana, 1930)
CALIFFO (fr. calife, khalife; sp. califa; ted. Chalif, Chalife, Kalif; ingl. caliph, khalīfa). - Nome arabo (khalīfah) del sommo monarca dell'islamismo, in quanto l'insieme di tutti i paesi abitati da musulmani sia concepito come unità politica sottomessa a unico sovrano musulmano. L'ancor diffusissima credenza che il califfo sia per i musulmani una somma autorità religiosa corrispondente a quello ch'è il papa per il cattolicesimo è del tutto errata; il concetto di califfo, invece, è assai vicino a quello dell'imperatore medievale, riguardato come sommo monarca di tutti i paesi cristiani. L'istituzione del califfato è immediatamente consecutiva alla morte di Maometto (8 giugno 632), il quale non aveva provveduto in alcun modo a indicare in qual modo e da chi avrebbe dovuto esser retto dopo di lui lo stato da lui fondato, che allora non usciva dai confini dell'Arabia e che aveva come base la comunanza di fede religiosa, in quanto che i pagani o politeisti non vi erano tollerati, e gli ebrei e cristiani (piccolissima minoranza) erano posti in condizione giuridica assai inferiore a quella dei musulmani ed esclusi da tutti i pubblici uffici. Siccome per parecchi secoli, almeno per i primi quattro dopo Maometto, la diffusione della religione musulmana fuori d'Arabia s'identificò con l'espansione territoriale dello stato musulmano, e siccome quelli che noi diremmo diritti civili appartennero sempre nella loro pienezza ai soli musulmani, si comprende che il diritto pubblico dell'islamismo abbia concepito le terre d'islām come formanti un'unica monarchia, un blocco unico contro tutti i paesi d'altra religione, e non abbia neppure preveduto il caso di musulmani soggetti a potentati non islamici; cosa che in quei secoli sembrava assurda.
Il vocabolo khalīfah in arabo ha due significati principali: "successore" oppure anche "vicario, luogotenente"; è assai verosimile che esso sia stato scelto per il monarca dell'islamismo nel senso di successore di Maometto nella qualità di capo dello stato. Anche altri elementi forse contribuirono a far sorgere o a rafforzare la scelta; ma non è qui il luogo di trattarne. L'espressione "califfo di Dio" che s'incontra non di rado, va intesa nel senso di califfo legittimo, voluto da Dio. A ogni modo nell'uso della cancelleria e nel rivolgere la parola al califfo il vocabolo khalīfah era sostituito dall'espressione amīr al-mu'minīn "il principe dei credenti" che è titolo di pertinenza esclusiva del califfo e che fu assunto forse dallo stesso primo successore di Maometto, Abū Bekr (v.).
Secondo la dottrina sunnita o ortodossa, cioè quella dell'enorme maggioranza dei musulmani, le condizioni indispensabili per essere califfo sono il sesso maschile, la maggiore età, l'essere di religione musulmana sunnita e di condizione libera, la sanità di mente, l'integrità del corpo e la discendenza dai Quraish o Coreisciti, cioè da coloro che formavano la maggioranza della popolazione della Mecca al tempo di Maometto e ai quali Maometto stesso apparteneva. In teoria il califfo è elettivo e i suoi elettori sono le persone aventi autorità ufficiale o morale e residenti non troppo lontano dalla capitale; è ammesso che il califfo in carica designi il successore, previo gradimento di coloro che sarebbero gli elettori. Il principio elettivo fu sempre salvo anche quando, in pratica, il potere califfale si trasmise nel seno della dinastia omayyade o della dinastia ‛abbāside per parecchie generazioni; infatti non esistette mai un determinato ordine di successione o un qualsiasi diritto successorio di membri della dinastia. In ciò abbiamo la diretta continuazione delle norme che valevano in Arabia ancor prima dell'islamismo per la scelta del capo della tribù; come pure all'uso arabo preislamico si collega la solenne cerimonia della bai‛ah, cioè del riconoscimento pubblico del nuovo califfo da parte dei personaggi più ragguardevoli mediante la palmata o stretta di mano. Per i giuristi l'elezione stabilisce un patto bilaterale; sicché se venisse a mancare uno dei requisiti fondamentali per la dignità califfale (p. es. sorgesse miscredenza, alienazione mentale, cecità, prigionia in mano degl'infedeli), il patto verrebbe sciolto e si dovrebbe procedere a nuova elezione; invece la condotta licenziosa o tirannica non furono di solito considerate nella pratica come causa di decadenza.
I poteri del califfo sono quelli d'un monarca assoluto, salvo per ciò che riguarda la legislazione. Infatti, concepito dai musulmani il diritto come espressione della volontà divina, conoscibile attraverso i testi sacri e la loro interpretazione affidata ai dottori in scienze religiose (gli ‛ulamā'), ne consegue che, fuori del campo della semplice amministrazione, il sovrano non può legiferare se non in materie molto ristrette, non contemplate dal diritto determinato dagli ‛ulamā'; persino in fatto di tributi i suoi poteri sono circoscritti assai, almeno teoricamente. Il califfo, come qualsiasi sovrano islamico, è un defensor fidei, non in quanto egli abbia autorità religiosa, ma in quanto ha il dovere di difendere la religione e l'ortodossia secondo l'opinione concorde o prevalente degli ‛ulamā'.
L'enorme estensione assunta ben presto dall'Impero musulmano e la lentezza dei mezzi di comunicazione portarono a una larga autonomia dei governatori di provincie lontane, i quali anzi miravano alla formazione di vere dinastie locali. Casi siffatti finirono col ricevere un aspetto legale mediante un atto d'investitura regolare, accordato dal califfo per un determinato territorio e rinnovato volta per volta ai successori del primo investito; la sovranità nominale del califfo era quindi sempre affermata e riconosciuta in maniera che ricorda le investiture feudali accordate dall'imperatore della cristianità a re, principi, marchesi, ecc. Il caso più grave è quello della dinastia dei Buwayhidi (v.) o Būidi, di nazionalità persiana e seguace dell'eresia sciita, per cui i califfi abbāsidi erano sovrani illegittimi; nel 334 èg., 945 d. C., essa occupò la capitale califfale Baghdād e obbligò il califfo ad accontentarsi d'una semplice alta sovranità non solo per le regioni persiane tenute dai Buwayhidi, ma per la stessa capitale; sicché il califfo aveva il pieno dominio e l'amministrazione diretta soltanto di territorî fuori di Baghdād: situazione strana, durata circa un secolo.
I titoli dati di solito a questa specie di sovrani vassalli erano amīr "principe, emiro" o anche malik "re"; soltanto dopo il 1000 circa appare il titolo di sulṭān "sultano". È indispensabile rilevare, di fronte a errati concetti largamente diffusi, che i poteri riconosciuti dal diritto musulmano a questi principi o re o sultani sono assolutamente gli stessi che si attribuiscono ai califfi; il divario riguarda solo l'estensione territoriale, limitata nel caso dei principi vassalli, estesa a tutto il mondo musulmano nel caso dei califfi.
I primi quattro califfi, tutti compagni di Maometto e non legati fra loro da alcun vincolo di parentela, furono Abū Bekr (11-13 èg., 632-634 d. C.), ‛Omar I (13-23 èg., 634-644), ‛Othmān (23-35 èg., 644-656) e ‛Alī (35-40 èg., 656-661); rappresentati come i sovrani ideali procedenti sulle orme segnate da Maometto, essi sono chiamati i califfi rāshidūn ossia "retti, sulla retta via". Secondo i teologi, gli altri, Omayyadi (40-132 èg., 661-750) e ‛Abbāsidi (132-656 èg., 750-1258), non meritano il titolo di califfo per essersi scostati dall'ideale di governo islamico quale risultava dall'esempio di Maometto e dei rāshidūn; essi dovrebbero essere considerati soltanto re oppure imām, vocabolo che nell'uso giuridico designa il principe, il sovrano musulmano, sia esso califfo o no.
Con la conquista di Baghdād fatta nel 1258 dalle orde tartare o mongole di Hūlāgū, la famiglia ‛abbāside fu distrutta e il califfato ebbe termine; si ebbero poi aspiranti al califfato qua e là (p. es. i sultani Ḥafṣidi di Tunisi, i sultani ottomani del sec. XIX e del principio del XX, e nel 1924 l'allora re del Ḥigiāz, Ḥusain ibn ‛Alī), ma nessuno riuscì a ottenere l'adesione del mondo musulmano e a far risorgere un'istituzione morta da quasi sette secoli e incompatibile con la sovranità europea su molti paesi musulmani.
Intorno al grave errore della diplomazia europea (e anche di molti studiosi), dallo scorcio del sec. XVIII sino al 1916, di credere ai poteri spirituali del califfato e che il monarca ottomano (fra l'altro non discendente dai Quraish e neppure di razza araba) fosse sultano in quanto capo dell'impero turco e califfo in quanto capo della religione musulmana, si vedano gli scritti indicati nella bibliografia. Del resto la Grande Assemblea Nazionale di Angora, che il 1° novembre 1922 aboliva il sultanato e il 18 eleggeva un califfo (‛Abd ul-Megīd) con immaginarî poteri religiosi e senza alcun potere politico, il 3 marzo 1924 abrogò anche questo suo fantastico califfato.
Per le vicende storiche esteriori del califfato, ossia dell'impero musulmano, v. arabi: Storia (III, pp. 826-833); gli elenchi dei califfi ‛abbāsidi e omayyadi si trovano alle rispettive voci. Per la dottrina sciita del califfato, radicalmente diversa dalla sunnita, v. imām. La dottrina ibāḍita differisce dalla sunnita essenzialmente perché ammette la legittimità anche di non Quraishiti e la contemporaneità di due califfi o imām; ciò si spiega col fatto storico del frazionamento della piccola comunità ibāḍita in paesi senza agevole comunicazione fra loro e dell'impossibilità di supporre un monarca ibāḍita universale per il mondo musulmano.
Bibl.: Th. W. Arnold, The Caliphate, Oxford 1924; W. Barthold, Chalif i sultan (in russo), in Mir Islama, I, Pietroburgo 1912, pp. 203-226, 345-400 (ampiamente riassunto da C. Becker, in Der Islam, VI, Strasburgo 1915-16, pp. 350-412); D. Santillana, Istituzioni di diritto musulmano malichita, I, Roma 1926, pp. 12-24 (ottima esposizione); C. A. Nallino, Appunti sulla natura del califfato in genere e sul presunto califfato ottomano, Roma 1917, 2ª ed., 1919, anche in trad. francese e inglese; id., La fine del così detto califfato ottomano, in Oriente Moderno, IV, Roma 1924, pp. 137-153. Per gli avvenimenti di Turchia riguardo al califfato, per l'effimero tentativo di Husain ibn Ali succitato e per il Congresso musulmano mondiale tenuto al Cairo nel 13-19 maggio 1926 si vedano le annate IV-VI (1924-26) dell'Oriente Moderno e i voll. LIX (1925) e LXIV (1926; in questo è la traduzione completa degli atti del congresso del Cairo) della Revue du Monde Musulman di Parigi. Per proposte di musulmani modernisti miranti a far risorgere il califfato sotto una veste molto diversa da quella che l'istituto ha sempre avuto e in modo da renderlo compatibile, con il mondo moderno europeo, si veda Mohammed Berektullah, Le Khalifat, Parigi 1924 (anche in ed. inglese; l'autore è un indiano del Bhōpāl, modernista molto avanzato; cfr. Oriente Moderno, VI, 1926, pp. 125-128), e il grosso libro, di modernismo assai più temperato, di A. Sanhoury, Le Califat, son évolution vers une Société des nations orientale, Parigi 1926.

La designazione di Abu Bakr
in una miniatura persiana
1.1/ Abu Bekr, di Galvano Della Volpe (Enciclopedia Italiana, 1929)
ABŪ BEKR (Abū Bakr, \arabo\). - Primo califfo degli Arabi, suocero di Maometto. Membro di una frazione non molto importante della tribù dei Quraish (Coreish [v.]), non apparteneva all'aristocrazia dominatrice della Mecca, ostile alla predicazione dell'islamismo. Prestò anzi ascolto alla parola di Maometto, e fu uno dei primi (secondo alcune tradizioni, peraltro poco attendibili, il primo addirittura: v. Th. Nöldeke in Zeitscrift der deutschen morgenländischen Gesellschaft, LII, (1898) pp. 16-33) a convertirsi alla nuova fede, e fu fedele seguace di Maometto, il quale lo prese come compagno nella sua emigrazione a Medina (v. ègira). Per tale circostanza, e per essere sua figlia ‛Ā'ishah (v.) la sposa prediletta di Maometto, egli venne a trovarsi in una condizione singolarmente elevata tra i primi musulmani; tuttavia, durante la vita di Maometto, non godette di privilegi particolari, anche perché, a quanto sembra, la sua indole era modesta e scevra di ambizione. Soltanto alla morte di Maometto nello sbigottimento prodotto dall'inaspettata scomparsa del profeta, Abū Bekr ebbe il sommo merito di non disperare dell'avvenire, e fu riconosciuto, più per generale consenso che per un atto formale di elezione, quale capo della giovane comunità (10 ègira = 632 d. C.). In tale qualità egli, spiegando un'azione energica per mantener salda la compagine dei musulmani, combatté gagliardamente le tribù arabe scioltesi dal vincolo di fedeltà a Maometto.
La morte avvenuta poco dopo (13 ègira = 634 d. C.) gli impedì di condurre a termine l'opera, che fu proseguita e inaspettatamente ampliata dal suo successore ‛Omar, di mente più vasta e di carattere più forte, all'influenza del quale Abū Bekr si era volontariamente sottomesso, e che aveva avuto una parte decisiva nella proclamazione del primo califfo. La pia tradizione islamica ha circondato la figura di Abū Bekr di un nimbo di santità leggendaria. Egli è il modello della sapienza, dell'onestà, della moderazione, della carità, dell'ascesi. Centinaia di sentenze, relative a ogni sorta di questioni religiose e giuridiche, vengono fatte risalire a lui, con assai scarsa verosimiglianza storica. Anche il ṣūfismo (v.) ravvisa in lui una delle fonti principali della dottrina e della pratica mistiche, e fino ai nostri giorni i suoi presunti discendenti (presunzione assai poco fondata) esercitano in quasi tutto il mondo musulmano una specie di supremazia sulle confraternite religiose. A questa venerazione non partecipano gli Sciiti (v.); essi, o almeno quelli tra loro che seguono tendenze estremiste, maledicono in Abū Bekr l'usurpatore del califfato, che, secondo loro, sarebbe toccato di diritto ad ‛Alī, genero e cugino di Maometto, e alla sua discendenza. Ad Abū Bekr è attribuita, tra l'altro, la prima raccolta del Corano, attribuzione che la critica storica moderna tende a ritenere apocrifa.
Bibl.: Enciclopedia dell'Islam, Leida 1908 segg. (in edizione francese, tedesca, inglese), I, pp. 85-87; L. Caetani, Annali dell'Islām, Milano 1905 segg., I-II, passim, e specialmente III, pp. 81-131; H. Lammens, Le triumvirat Aboū Bakr, ‛Omar et Aboū ‛Obaida in Mélanges de la Faculté Orientale, Beirut 1910, IV. V. inoltrecaliffato e arabi: Storia.
1.2/ Omar, di Giorgio Levi Della Vida (Enciclopedia Italiana, 1935)
‛OMAR (arabo ‛Umar). – […] ‛Omar ibn al-Khaṭṭāb, una delle più potenti personalità dell'Islām primitivo, passò all'improvviso da una vivace opposizione alla fede predicata da Maometto a un entusiastico ardore per essa. Emigrato a Medina con Maometto e legato intimamente con Abū Bekr (v.), esercitò una grandissima influenza come consigliere sia del profeta sia del primo califfo, il quale lo designò a succedergli. Durante il suo califfato (13-23 eg., 634-644 d. C.) si compirono le prodigiose conquiste arabe (v. arabi: Storia), cui ‛Omar non partecipò direttamente, dirigendone l'andamento da Medina. A lui è dovuta la prima organizzazione dell'impero arabo, della quale la tradizione gli attribuisce particolari legislativi che in parte furono fissati soltanto più tardi, ma le cui norme fondamentali risalgono certo a lui. Parte cospicua ebbe altresì nell'elaborazione della legge religiosa; anche qui la tradizione gli ha assegnato più di quanto gli spetti in realtà, ma non in misura così estesa come si vuole dalla critica più radicale. Di indomabile energia, rigoroso fino all'estremo, facile alla collera, ‛O. è tuttavia rappresentato dalla storiografia musulmana (anche qui con sostanziale esattezza) quale profondamente pio, modesto nel tenore di vita, modello di giustizia imparziale. […]
Bibl.: Per ‛O. I, v. L. Caetani, Annali dell'Islām, III-IV, Milano 1910-1912; per ‛O. II, v. arabi: Storia.
1.3/ Othman, di Giorgio Levi Della Vida (Enciclopedia Italiana, 1935)
‛OTHMĀN (arabo ‛Uthmān). - Terzo califfo dell'Islām, dal 23 al 35 ègira (644-656 d. C.). Benché membro della famiglia degli Omayyadi ostile a Maometto, fu uno dei primi convertiti e prese parte all'ègira; sposò due figlie del profeta. Scelto califfo dal consiglio elettivo nominato da Omar in punto di morte continuò in sostanza la politica del suo predecessore, appoggiandosi tuttavia troppo esclusivamente ai membri della propria famiglia, il che gli procurò acerbe ostilità, anche da parte degli antichi compagni di Maometto. Debole d'indole, non seppe né schiacciare gli avversari né mutare il sistema seguito; va tuttavia osservato che molte misure delle quali gli fu imputata la responsabilità (tra l'altro la costituzione di estesi territorî demaniali) non erano se non la conseguenza della politica di Omar. Assediato nella propria abitazione a Medina da un gruppo di rivoltosi provenienti dall'Egitto, ma non senza la partecipazione, o almeno la tacita condiscendenza, di ‛Alī e di altri tra i primi musulmani, fu massacrato. La sua morte segnò il principio delle lotte civili e religiose in seno all'Islām. Il nome ‛Othmān, portato dall'eponimo degli Ottomani e da altri sovrani e personaggi storici di quella stirpe, assume in turco la pronuncia di ‛Osmān (v.).
Bibl.: L. Caetani, Ann. dell'Islām, VII-VIII, Milano 1914-18.
1.4/ Ali, di Giorgio Levi Della Vida (Enciclopedia Italiana, 1929)
ALI (‛Alī; l'accentuazione Alì è dovuta all'influsso della pronuncia turca). - Quarto califfo degli Arabi, l'ultimo dei cosiddetti Rāshidūn "i ben diretti" (v. califfato). Stretto parente di Maometto, essendo suo padre, Abū Ṭālib, fratello del padre di Maometto (erano figli di ‛Abd al-Muṭṭalib, figlio di Hāshim, dal quale antenato prendeva il nome l'intera famiglia), era però di parecchi anni, forse una trentina, più giovane di lui. Benché non sia da prestar fede alla tradizione che fa di lui il secondo o il terzo seguace dell'Islām, certo è che egli fu tra i primi ad abbracciare le idee religiose del cugino e lo seguì nell'ègira, (l'emigrazione a Medina), non però lo accompagnò all'atto della partenza (la pia tradizione si è ingegnata di giustificare questo ritardo). Il suo matrimonio con la figlia primogenita di Maometto, Fāṭimah (v.), rese più stretti i suoi vincoli di parentela col Profeta: tuttavia, benché partecipasse valorosamente a tutte le battaglie dell'Islām nascente e fosse mandato da Maometto in missione politica nel Yemen, non sembra aver goduto di alcuna posizione di privilegio presso il suocero, sul quale invece esercitavano un influsso incontestato la giovane moglie ‛Ā'ishah (v.), il padre di lei Abū Bekr (v.) e ‛Omar (v.). Sicché, alla morte di Maometto, Alì rimase escluso non solo dalla successione, ma anche da qualsiasi partecipazione alla vita politica, il che non soltanto fu sentito da lui come un grave affronto fatto alla sua condizione di stretto parente del Profeta (questa, secondo le norme consuetudinarie dell'Arabia preislamica, non gli conferiva un diritto specifico alla successione, ma costituiva pur sempre un titolo di preferenza che poteva esser fatto valere accanto ad altri), ma fece di lui il centro dell'opposizione manifestatasi in seno alla comunità musulmana contro il favore sempre crescente che i membri della classe dirigente meccana, convertiti dell'undecima ora, godevano presso i califfi a danno dei più antichi e più fedeli compagni del Profeta, e specialmente dei Medinesi, che lo avevano accolto profugo e assistito nei difficili inizî della sua azione politico-religiosa (i cosiddetti Anṣār "gli aiutatori"). Tale opposizione raggiunse il colmo negli ultimi anni del califfato di ‛Othmān (v.), e quando questi fu ucciso a Medina (35 ègira = 656 d. C.), Alì, nello scompiglio suscitato dall'eccidio e tra lo sbigottimento dei partigiani dell'assassinato, fu proclamato califfo dai notabili Anṣār e da altri autorevoli compagni. È dubbio se egli sia stato responsabile dell'uccisione di ‛Othmān: forse non vi ebbe parte diretta, ma il suo prolungato atteggiamento di oppositore irreducibile e il vantaggio che egli ne trasse dovevano facilmente dare appiglio ai peggiori sospetti, tanto più che proprio tra i suoi più fanatici partigiani si trovavano i promotori della rivolta finita nell'assassinio. Nonostante il trionfo di Medina, Alì si trovò, fin dall'inizio del suo regno, impigliato nelle più aspre difficoltà; alla Mecca scoppiò una rivolta facente capo ad ‛Ā'ishah e ai due autorevoli compagni Ṭalḥah e az-Zubair: delle provincie, mentre l'‛Irāq e l'Egitto erano divisi tra partigiani e oppositori, la Siria, il cui governatore Mu‛āwiyah (v.), stretto congiunto di ‛Othmān, disponeva di un esercito agguerrito e disciplinato, era tutta intera contro di lui. Alì, per non lasciarsi prevenire dai ribelli della Mecca che si erano diretti verso l'‛Irāq, mosse a quella volta e costituì la sua sede ad al-Kūfah, mentre quelli s'impadronivano di al-Baṣrah l'altro grande centro della regione. La disfatta dei ribelli nella battaglia del Cammello (36 èg. = novembre 656) e il prevalere dei suoi partigiani in Egitto parvero assicurare il successo ad Alì: gli restava da sconfiggere Mu‛āwiyah, pericoloso non solo per la sua forza militare, ma altresì per il grande prestigio che la sua situazione di vendicatore del parente ucciso gli conferiva secondo la mentalità araba, che seguitava a considerare i conflitti politici alla stregua delle tradizionali lotte di tribù sorgenti da questioni relative alla vendetta del sangue. Tale situazione fu abilmente sfruttata da Mu‛āwiyah, mentre Alì non si mostrò politico avveduto. Scontratisi i due contendenti a Ṣiffīn (località sulla riva destra del medio Eufrate), Mu‛āwiyah, che si era accordato con l'astuto ex-governatore dell'Egitto ‛Amr ibn al-‛Āṣ (v.), riuscì a far sospendere le ostilità e a indurre Alì, che era riluttante e consentì solo sotto la pressione di una parte dei suoi seguaci, ad accedere a un giudizio arbitrale. Questo non ebbe invero alcun risultato, ma da una parte fece guadagnar tempo a Mu‛āwiyah e gli valse la conquista dell'Egitto, dall'altra provocò la scissione dei seguaci di Alì, molti dei quali lo abbandonarono, costituendo quella che divenne poi una delle principali sètte politico-religiose dell'Islām, i Khārigiti (v.). Essi, benché Alì ne facesse strage (38 èg. = luglio 657), non furono interamente distrutti, e andarono anzi aumentando continuamente di numero, provocando movimenti insurrezionali nel territorio già sottomesso ad Alì. Questi fu poi a poco a poco abbandonato da alcuni dei più ragguardevoli dei suoi partigiani, i quali, vedendo che la sorte gli si faceva contraria, si lasciarono sedurre dalle lusinghe di Mu‛āwiyah; e questi, sicuro ormai di un vicino trionfo rinunziando ad ulteriori azioni guerresche in grande stile, esaurì gradatamente le forze di Alì e ne scalzò il prestigio con una serie di scorrerie, che giunsero talvolta al centro stesso del suo territorio. Alì era senza dubbio prossimo alla rovina definitiva quando cadde assassinato, ad al-Kūfah, dal khārigita ‛Abd ar-Raḥmān ibn Mulgiam (40 èg. = gennaio 661), dopo poco più di quattro anni di regno, durante i quali la sua sovranità non era stata effettiva che sopra una parte soltanto dell'impero arabo.
Il giudizio storico sul carattere di Alì è reso difficile dalla circostanza che il prevalere delle tendenze favorevoli a lui, nel campo della politica e della religione, ha invaso anche la storiografia araba, sì che riesce arduo il distinguere il nucleo primitivo della tradizione dalle alterazioni tendenziose. Tuttavia i frammenti avanzati della storiografia omayyade e le allusioni e gli spunti polemici della stessa tradizione alida permettono alla critica di ricostruire le linee maestre del processo storico e di farsi un concetto adeguato della personalità di Alì. Egli fu senza dubbio uomo valoroso, ma gli mancarono le doti essenziali dell'uomo politico, prime fra tutte l'intuizione del momento favorevole e la conoscenza degli uomini, doti che il suo avversario possedeva invece in sommo grado. La sua morte tragica e, più ancora, l'antagonismo tra Siria e ‛Irāq, che, dovuto a cause complesse, s'impersonò nel contrasto tra gli Omayyadi e gli Alidi conferirono ad Alì un prestigio religioso superiore a quello di qualunque altro compagno di Maometto. La sua leggenda, che dovette costituirsi, nelle sue linee essenziali, a pochi anni dalla sua morte, è entrata a far parte del corpo ufficiale delle credenze musulmane in seguito al trionfo degli Abbasidi (v.); pertanto l'ortodossia musulmana è unanime nell'attribuire ad Alì meriti eccezionali (che gli sono invece negati dagli eretici khārigiti) e a ravvisare in lui il maestro e il modello di ogni virtù e dottrina religiosa, della sapienza giuridica e perfino delle scienze profane (p. es. della grammatica). Migliaia di tradizioni religiose e giuridiche (v. ḥadīth, sunnah) sono fatte risalire a lui, e anche nello sviluppo delle dottrine mistiche egli compare come uno dei sommi maestri (v. ṣūfismo).
Ma molto più innanzi procedono nell'ammirazione e nella venerazione per Alì le dottrine degli Sciiti (v.), per i quali Alì non solo è il più grande tra i discepoli di Maometto, ma è addirittura collocato in una categoria a parte, a un'altezza incommensurabilmente superiore; gli estremisti sciiti, come sarà detto a suo luogo, giungono perfino a porre Alì al disopra di Maometto (che ne avrebbe usurpato il posto) e a deificarlo (v. anche ahl-i ḥaqq).
Il nome ‛Alī, appunto in grazia della venerazione di cui il califfo è fatto segno, è frequentissimo nell'onomastica musulmana così antica come moderna. In quest'ultima esso si ritrova spesso accoppiato a quello di Maometto (Moḥammed ‛Alī). Diffuso è anche, ma solo nelle regioni orientali dell'Islām (Persia, Ihhdia), il soprannome Ḥaidar che fu dato ad Alì e che, benché la tradizione lo interpreti in significato onorifico ("il leone"), è certamente un nomignolo ingiurioso affibbiatogli dai nemici (forse "il panciuto": v. Levi Della Vida, in Riv. d. studi or., IV, p. 1075), così come significato originariamente dispregiativo ha la kunyah (v.), sotto la quale Alì è spesso designato, Abū Turāb "il polveroso" (v. Nöldeke, in Zeitschr. d.deutschen Morgenl. Ges., LII, pp. 29-30), che poi fu anch'essa interpretata in senso onorifico. La kunyah che Alì stesso portava era, del resto, Abū'l-Ḥasan, dal nome del suo figlio primogenito (v. alidi).
La fama di Alì, in quanto oggetto della particolare venerazione degli Sciiti, ha fatto sì che egli sia uno dei pochissimi eroi dell'Islām primitivo di cui sia giunta notizia al Medioevo cristiano: Dante, come è noto, lo menziona (Inf., XXVIII, 32).
Bibl.: Le fonti sono raccolte in traduzione e criticamente ordinate in L. Caetani, Ann. dell'Islām, IX-X, Milano 1926; ricchissimo materiale anche in varî scritti del p. H. Lammens, specialmente in Études sur le règne de Mo‛āwia 1er (Mél. de la Faculté orient., I-III), Beirut 1906-1908, e in Fatima et les filles de Mahomet, Roma 1913; G. Levi Della Vida, Il califfato di Ali secondo il kitāb ansāb al-ashrāf, in Riv. d. studi or., VI, Roma 1913.
1.5/ Khalid ibn al-Walid, di Giorgio Levi Della Vida (Enciclopedia Italiana, 1933)
KHĀLID ibn al-Walīd. - Celebre capitano arabo, il principale autore delle conquiste avvenute nei primi tempi dell'Islām. Della stirpe nobile dei Makhzūm, la più cospicua, accanto agli Omayyadi, nell'aristocrazia della Mecca, fu dapprima ostile a Maometto, ma si unì poi a lui e comandò alcune delle spedizioni guerresche organizzate da Maometto. Dopo la morte di costui, ebbe parte principale nel domare la ribellione scoppiata nell'Arabia meridionale e orientale contro l'egemonia islamica. Iniziatesi nel 12 èg. (633 d. C.) le grandi campagne di conquista, aprì la via all'occupazione della Persia espugnando la città di al-Ḥīrah, poi, con una marcia attraverso il deserto che è rimasta celebre nella storia delle spedizioni militari, comparve improvvisamente in Siria, e il suo intervento decise in favore degli Arabi la lotta già iniziata da questi contro i Bizantini (v. arabi: Storia). Per motivi non bene precisati, forse dovuti alla troppo grande popolarità datagli dalle sue vittorie, il califfo ‛Omar gli tolse il comando supremo, ma egli continuò in sott'ordine a partecipare alla guerra, dando ancora prova del suo singolare talento strategico e del suo coraggio personale. Morì nel 21 èg. (641-642 d. C.), e la sua memoria è rimasta viva nella sua tradizione, che ne ha sviluppato in maniera leggendaria le gesta in elaborazioni di carattere epico composte probabilmente all'epoca delle crociate (la Conquista di Siria del cosiddetto Pseudo-Wāqidī). Il soprannome "Spada di Dio" gli sarebbe stato dato da Maometto dopo le sue prime vittorie.
N.B. de Gli scritti. A Khalid ibn al-Walid è attribuita la frase che riecheggia negli scritti di Osama Bin laden e nei proclami di alcuni mujaheddin odierni: «Porto uomini che desiderano la morte come voi desiderate la vita».
2/Arabi, di G. L. D. V., M. G., M. G., J. R. (Enciclopedia Italiana, 1929)
Storia
L'Islām e l'impero arabo. - Lo stato teocratico di Medina e l'unificazione politica dell'Arabia. - Con lo stabilirsi della comunità musulmana (per la storia religiosa v.islamismo, maometto) a Yathrib (che d'ora innanzi assume il nome di al-Madīnah, Medina) si costituisce l'embrione di un organismo politico fino allora ignoto all'Arabia: lo stato teocratico. Maometto, giunto a Medina con un esiguo numero di seguaci verso la fine del 622, vi esercita opera di pacificazione fra le due tribù rivali al-Aws e al-Khazraǵ, le amalgama coi suoi fedeli, distrugge e sottomette, dopo un breve periodo di convivenza pacifica, la popolazione ebraica, e crea una comunità nella quale il vincolo di associazione è dato non già dalla comunanza del sangue, ma da quella della fede e del culto (ummah "nazione", o giamā‛ah "comunità"). A capo di essa sta Allāh, il quale le manifesta i suoi voleri attraverso le rivelazioni coraniche fatte al Profeta, e dal decreto divino originano le prime rudimentali istituzioni di diritto pubblico (elemosina legale, spartizione del bottino) e di diritto privato (matrimonio, eredità).
La comunità medinese, mentre si organizzava sotto il suo capo, si cimentava nella guerra coi Meccani. La battaglia di Badr (2 ègira, 623 d. C.), in cui i seguaci di Maometto sorpresero e misero in rotta una carovana di Coreisciti riportando bottino e prigionieri, non differì nel suo aspetto esterno dalle solite razzie; ma il successo cementò l'unità dei musulmani e diede loro la piena coscienza dell'irremissibile rottura col passato. L'anno seguente i Meccani sconfissero i musulmani a Uḥud presso Medina, e nel 5 èg., 627 vennero, con l'aiuto di tribù alleate, a porre assedio alla città stessa, furono respinti, e il loro insuccesso valse ad accrescere il prestigio di Maometto, il quale, continuando la sua sistematica campagna contro gli Ebrei, dopo averli massacrati o espulsi da Medina soggiogò la loro fiorente colonia di Khaibar, e in seguito le altre, arricchendo sé e i suoi col bottino e con l'esigere metà dei proventi delle terre. Lo stato medinese andava così acquistando una maggiore estensione territoriale; si costituivano, con la quota di terre e di bottino spettante "ad Allāh e al suo profeta", un demanio e un erario pubblico. Richiamate dalla prospera fortuna di Maometto, molte tribù dell'Arabia centrale gl'inviarono ambascerie e strinsero patti d'amicizia con lui (la tradizione li considera come vere e proprie conversioni all'islamismo), accettando di pagargli tributo e di accogliere suoi rappresentanti. Gli stessi Meccani, convinti ormai di non poter debellare il fuoruscito, si rassegnarono a trattare con lui: fu dapprima concluso un armistizio (tregua di al-Hudaibiyah, 6 èg., 628), due anni dopo Maometto entrava come trionfatore alla Mecca (ch'egli, con accorta politica, aveva proclamata città santa dell'Islām) e la riuniva allo stato di Medina; mediante un tacito compromesso con l'aristocrazia coreiscita, questa, in cambio della sua adesione alla nuova fede e al nuovo ordine di cose, conservava nella direzione politica dello stato musulmano quell'influenza di cui aveva goduto al tempo del paganesimo: da essa usciranno, negli anni seguenti, i generali, i governatori, i califfi che conquisteranno e reggeranno lo sterminato impero arabo. Il trionfo di Maometto si risolveva pertanto, con un paradosso non infrequente nella storia, in un aumento di prestigio per coloro che lo avevano prima combattuto, ma esso conferiva all'egemonia dei Coreisciti sull'Arabia centrale un carattere e un'energia nuovi, costituiti dal segnacolo della religione e dalla fede nell'assistenza divina sempre presente ed agente attraverso il Profeta vittorioso.
Questi tuttavia mantenne la propria sede a Medina, dove il nucleo dei suoi primi compagni gli formava una sorta di consiglio autorevole e devoto e dove le due tribù che gli avevano prestato aiuto nei giorni delle prove più dure, ormai unificate sotto la denominazione generale di Anṣār ("gli aiutatori"), costituivano per lui il più valido e fedele presidio. E a Medina appunto, in seno ai Compagni e agli Ansār, si formò quella salda compagine la quale, all'inaspettata morte di Maometto (13 rabī‛ I 11, 8 giugno 632), non disperò dell'avvenire dell'Islām, e ne affidò la direzione politica e religiosa ad Abū Bekr (v.), il fedele e saggio compagno, padre di ‛Ā'ishah (v.), la sposa prediletta del Profeta. Il titolo di khalīfah ("successore"), che Abū Bekr assunse o che gli fu dato, mancava, come di ogni precedente storico nella tradizione araba, così di ogni precisazione teorica: con esso si volle indicare, non già che il carattere profetico fosse trasmissibile ad altri dopo Maometto, ma che il nuovo reggitore della comunità l'avrebbe guidata secondo lo spirito del Profeta scomparso; l'idea che nuovi problemi si sarebbero presentati, che decisioni d'indole generale e fondamentale avrebbero dovuto essere prese indipendentemente da quanto aveva fatto e detto Maometto, non poteva affacciarsi alle menti di coloro che ne raccolsero l'eredità senza preparazione preventiva. Come in quasi tutti i grandi rivolgimenti storici, risoluzioni d'importanza capitale per l'avvenire furono prese sotto lo stimolo della necessità urgente, e le conseguenze remote non furono né prevedute né valutate (v. califfato, califfo).
Abū Bekr ebbe, fin da principio, l'assistenza continua di ‛Omar (v.), la cui personalità potente si era già manifestata essendo ancor vivo Maometto e che fu, dopo il breve periodo del califfato di Abū Bekr (morto nel 13 èg., 634), il suo naturale successore. I primi tempi del califfato furono straordinariamente difficili: la maggior parte delle tribù alleate, ritenendosi legate soltanto personalmente con Maometto, rifiutarono il tributo e rimandarono i rappresentanti musulmani. Dalla pretesa del califfo, che i patti continuassero a esser validi, risultò una violenta guerra (conosciuta col nome di riddah "apostasia"), in cui i musulmani, con l'aiuto delle tribù rimaste fedeli, sgominarono i ribelli, dopo una lotta più aspra e più sanguinosa di quante da gran tempo avesse conosciute l'Arabia (battaglia della al-Yamāmah 12 èg., 633). Conseguenza della vittoria fu l'unificazione della maggior parte dell'Arabia sotto il dominio dell'Islām, il quale peraltro rispettò (né avrebbe potuto essere altrimenti) l'assetto sociale del paese, ma in un certo senso amalgamò le tribù, costringendole, di buona o di cattiva voglia, entro un organismo superiore, nella cornice del quale esse vivranno e agiranno d'ora in avanti, per forte che sia e continui a essere il loro innato particolarismo. Per tal modo l'Arabia, per la prima volta nel corso della sua storia, conobbe l'unità nazionale; sennonché (circostanza, questa, grave di conseguenze) tale unità è formulata in termini religiosi: arabismo e islamismo sono sinonimi, e tali rimarranno per lungo tempo avvenire; l'Islām, anche dopo esser divenuto religione e civiltà universalistica, non riuscirà mai a spogliarsi interamente della veste araba nella quale dapprima è comparso nella storia mondiale.
Le conquiste e la formazione dell'Impero arabo. - Il fenomeno della formazione dell'impero arabo è uno dei più meravigliosi che la storia delle conquiste militari ricordi: in dieci anni (13-23 èg., 634-644) poche decine di migliaia di Beduini sbaragliano gli eserciti di due potenti imperi e fondano uno stato unitario che si estende dall'altipiano iranico fino alla Cirenaica, e che pochi decennî dopo si estenderà dall'India all'Atlantico. L'indagine storica, cercando di darsi ragione delle cause e degli elementi di questo fenomeno, riesce a sceverare questi e quelle con chiarezza sufficiente; l'essenza specifica e intima del fenomeno stesso, la causa ultima del suo essere concreto rivestono tuttavia quel carattere di unicità, non privo di mistero, al quale è improntato ogni grande avvenimento storico. All'affermarsi del nuovo principio unificatore dell'Arabia faceva riscontro, nei due imperi confinanti, una profonda crisi, attraverso la quale si andava compiendo la decadenza delle monarchie bizantina e sāsānide, stremate dalla diuturna rivalità (che era culminata tra la fine del sec. VI e l'inizio del VII con la temporanea conquista persiana della Siria e dell'Egitto e con la loro riconquista per opera di Eraclio), profondamente scisse dalle contese religiose (nell'Impero bizantino tra l'ortodossia imperiale e il monofisismo prevalente nelle provincie orientali, in quello sāsānide tra lo zoroastrismo ufficiale e il cristianesimo nestoriano delle provincie di lingua aramaica), esaurite per l'intollerabile fiscalismo, causa ed effetto a un tempo di quell'esaurimento; si aggiunga, per Bisanzio la minaccia delle invasioni slave nei Balcani, la guerra coi Longobardi in Italia; per la Persia, l'azione dissolvente del feudalesimo e della casta sacerdotale dei magi. Attraverso le frontiere del deserto ormai sguarnite di presidî indigeni (v. sopra) incursioni di nomadi erano avvenute con particolare intensità negli anni immediatamente anteriori all'Islām, e specialmente lungo il confine del basso Eufrate avevano avuto luogo scontri vittoriosi degli Arabi coi Persiani (battaglia di Dhū Qār, 610?). La grande invasione araba non fu, in sostanza, se non la prosecuzione intensificata di quelle incursioni.
La tesi storica prevalente in passato, secondo la quale le conquiste arabe sarebbero state dovute a un prorompere di fanatismo religioso e avrebbero avuto per fine immediato la conversione degli infedeli ("l'Islām o la morte!" è la frase leggendaria in cui si compendia questa tesi), è stata refutata definitivamente dagli argomenti del Caetani (v. bibl.), il quale ha richiamato l'attenzione su un duplice aspetto delle conquiste stesse: esse furono iniziate proprio da quelle tribù abitanti l'estremo Nord dell'Arabia che erano le meno tocche dall'influsso musulmano, e inoltre, durante l'intero primo secolo dell'impero arabo, le conversioni tra i popoli conquistati furono relativamente poche e non sempre desiderate dai conquistatori, dei quali la religione musulmana rimase appannaggio esclusivo. Le conquiste, secondo le deduzioni estreme del Caetani, non avrebbero avuto né carattere né fine religiosi: il loro primo e intimo movente sarebbe anzi da attribuirsi a cause fisiche, ossia al progressivo inaridimento del clima arabo, per cui le tribù nomadi, prive di pascoli abbondanti, sarebbero state mosse alla ricerca di terre più fertili. Secondo questa costruzione storica, le conquiste arabe rappresenterebbero l'ultima fase della plurimillenaria espansione dei Semiti (v. il principio della presente voce) e l'islamismo non sarebbe se non l'occasione che favorì e accelerò un processo autonomo e fatale. In realtà il fattore religioso ebbe un'importanza decisiva nell'imprimere al movimento di conquista degli Arabi un carattere di unità, nel sostenere l'entusiasmo degl'invasori, nel dar loro la possibilità di costituirsi in stato organico nei vastissimi territori occupati, nell'esprimere dalla massa barbarica quelle energie individuali che seppero dirigere e governare il movimento anarchico dei Beduini. Occorre tuttavia non equivocare sul termine religione": esso va inteso nell'accezione molteplice e ricca di gradazioni e di sfumature che l'indole del fenomeno religioso comporta, e non significò probabilmente, per la maggior parte di coloro che presero parte alle conquiste arabe, se non la fede elementare nell'aiuto soprannaturale di Allāh, che aveva mandato il Profeta per procurare agli Arabi trionfi e ricchezze. Un tal genere di fede, che il successo dovette rinsaldare a dismisura, non implica né un capovolgimento della psiche beduina né la comprensione di astruse dottrine teologiche.
Iniziatesi sotto Abū Bekr, le conquiste presero un andamento più organico e regolare mercé l'energico intervento del califfo ‛Omar, il quale, pur senza muoversi da Medina, ne assunse la direzione e nominò al comando delle milizie arabe (più accozzaglia di tribù che esercito regolare) generali di sua fiducia, tolti dai Compagni più anziani o dall'aristocrazia coreiscita. Costoro, benché impreparati al nuovo compito tanto più vasto e complesso di quanto essi avessero mai operato e veduto nella cerchia ristretta della politica meccana, rivelarono capacità insospettate: Abū ‛Ubaidah ibn al-Giarrāḥ, Sa‛d ibn Abī Waqqāṣ, ‛Amr ibn al-‛Ās, Yazīd ibn Abī Sufyān e suo fratello Mu‛āwiyah condussero gli Arabi alla vittoria sopra le truppe bizantine e persiane, nonostante la secolare tradizione militare e la superiorità di armamento di queste. Ma sopra tutti rifulse il genio guerresco di Khālid ibn al-Walīd (v.), già vincitore della riddah, il quale, dopo aver contribuito alle vittorie sui Persiani compiute da al-Muthannà ibn al-Ḥārith, un capo della tribù cristiana di confine degli Shaibān, raggiunse l'esercito di Siria con arditissima marcia attraverso il deserto, prese di fianco l'esercito bizantino e lo sconfisse ripetutamente (battaglie di Aǵnādain, di Fiḥl, del fiume al-Yarmūk, 13-15 èg., 634-636), costringendolo a sgombrare la Palestina e gran parte della Siria. Anche più fulminea e più definitiva fu la lotta contro i Persiani: in una serie di battaglie (al-Buwaib, al-Qādisiyyah, Gialūlā, 14-16 èg., 635-637) il loro esercito fu disfatto e i suoi avanzi si salvarono a stento sull'altipiano iranico, dove l'inseguimento per parte degli Arabi procedette più lentamente; ma l'alta e la bassa valle dell'Eufrate e del Tigri, comprendenti la Babilonide (al-‛Irāq) e la Mesopotamia (al-Giazīrah), e la stessa capitale dell'Impero, Ctesifonte-Seleucia (in arabo al-Madā'in), rimasero in mano degl'invasori. I Bizantini resistettero più a lungo: sconfitti in campo aperto, si ritirarono nelle città costiere della Siria, al riparo delle fortificazioni e sorretti dalla flotta, né gli Arabi, ignari dell'arte dell'assedio, furono per allora in grado di sloggiarli; anche molte delle città dell'interno si sottrassero da principio all'occupazione e rimasero come isole sperdute in mezzo alle campagne di cui gli Arabi erano padroni incontrastati: situazione che ricorda quella in cui si erano trovate, duemila anni prima, molte di quelle medesime città, allora in potere dei Cananei o degli Hittiti, di fronte all'invasione degli Ebrei in Palestina. Ritiratesi le guarnigioni bizantine, la sola autorità rimasta in piedi era quella dei vescovi, e furono essi appunto a trattare la resa delle singole città, che capitolarono a condizioni non troppo onerose (v. oltre): poche soltanto furono prese d'assalto. Dalla Palestina, via naturale di transito all'Egitto, la marea araba si riversò anche in questa direzione: l'impresa fu preparata e condotta, per iniziativa spontanea, da ‛Amr ibn al-‛Ās, il quale, con geniale concezione strategica, puntò direttamente sulla fortezza di Babilonia (a sud dell'attuale Cairo), chiave delle comunicazioni tra l'alto e il basso Egitto, e, battuti colà i Bizantini (19 èg., 640), isolò l'alto Egitto dal mare, tagliando fuori Alessandria e il suo retroterra: la resa di Alessandria era inevitabile, e avvenne poco dopo; il resto dell'Egitto cadde da sé in mano al conquistatore, che più tardi (21 èg., 642) si spinse fino alla Pentapoli (attuale Cirenaica) e a Tripoli, scacciando anche di lì le guarnigioni bizantine. Nel frattempo luogotenenti del califfo estendevano la conquista alla parte settentrionale della Siria, giungendo in breve alla catena del Tauro, le cui aspre gole, facili a difendersi, chiusero all'invasione la via dell'Asia minore, e segnarono, per quattro secoli ancora, il confine tra l'impero bizantino e il nuovo impero arabo. La facilità con la quale gli eserciti bizantino e persiano furono sbaragliati ha un che di prodigioso: occorre tuttavia tener presenti, oltre alle già menzionate condizioni di decadenza dei due imperi, la circostanza che parte delle loro milizie era formata di mercenarî arabi, elemento infido che passò agevolmente al vincitore consanguineo, e l'irruenza degli Arabi, i quali per la prima volta nella loro storia mossero all'assalto con grandi masse di cavalleria che presero il posto degli esili squadroni con i quali fino allora avevano condotto le loro incursioni.
La tradizione che attribuisce a ‛Omar il definitivo assetto amministrativo dello stato musulmano ha, secondo il solito, accentrato intorno a una grande figura il risultato di un processo graduale e complesso; ma nell'insieme ha veduto giusto: le vastissime, fulminee conquiste compiute durante il califfato di ‛Omar suscitarono problemi impensati, così rispetto ai rapporti tra gli abitanti delle terre conquistate e i nuovi signori, come rispetto all'organizzazione di questi, i quali. esigevano soluzioni immediate; gli elementi essenziali della costituzione e l'amministrazione dell'impero dovettero esser fissati senza indugio. Gli Arabi si trovarono di fronte alle popolazioni della Mesopotamia, dell'‛Irāq, della Siria, dell'Egitto in condizioni analoghe a quelle dei Germani nell'impero romano al tempo delle invasioni barbariche. Il carattere militare dell'occupazione, la distinzione giuridica tra vincitori e vinti vennero mantenuti: gli Arabi evitarono perfino, sul principio, di stabilirsi nelle città, dove le condizioni di vita erano troppo diverse dalle loro, e preferirono concentrarsi in località adatte, generalmente non lontane dai centri urbani, in grandi accampamenti nei quali ogni tribù aveva il proprio quartiere e le abitudini della vita del deserto si perpetuavano senza troppi mutamenti, mentre l'organizzazione militare non si spezzava e consentiva il rapido allestimento di nuove spedizioni. Sorsero così i campi militari stabili (miṣr, plur. amṣār) di al-Kūfah e di al-Baṣrah nella Babilonide, quello di al-Urdunn (Giordano) in Palestina, quello di al-Fusṭāṭ in Egitto, come più tardi sorgerà quello di al-Qairawān in Tunisia, e molti di essi si trasformeranno poi in città, le future metropoli provinciali, di popolazione e carattere schiettamente arabi. Altrove questo processo di urbanizzamento degli Arabi si era già compiuto, come p. es. a Damasco. I conquistatori vivevano sul paese: ogni combattente (muqātil), in quanto tale e indipendentemente dalla quota parte di bottino che poteva spettargli in seguito a una spedizione vittoriosa, riceveva uno stipendio regolare (‛atā'), in corrispettivo del quale doveva provvedersi a proprie spese di armi e di cavallo. La necessità di tenere un elenco degli aventi diritto allo stipendio dà origine al "registro" (dīwān), in cui i combattenti sono suddivisi per tribù, che darà più tardi il nome all'intero organismo amministrativo. Ma non tutte le rendite, ordinarie e straordinarie, sono divise tra i combattenti: la quinta parte di esse (la proporzione è fissata dal Corano, e la prescrizione continua una pratica dell'età preislamica) costituisce il "tesoro di Dio" (māl Allāh: Iddio è qui, come sempre nella concezione teocratica, sinonimo di "stato"), che si alimenta anche dell'elemosina legale (zakāh), già imposta ai fedeli dal Corano. Le rendite normali più cospicue provengono tuttavia dall'imposta cui sono soggetti gl'infedeli. A questi non sono stati tolti né la proprietà né l'uso delle loro terre ma le comunità, cristiane la più parte, ma anche giudaiche e, nel territorio già persiano, zoroastriche, sono tenute a corrispondere un tributo in danaro o in natura, del puntuale ed esatto pagamento del quale sono responsabili le autorità poste a capo delle circoscrizioni territoriali, generalmente le stesse dell'amministrazione bizantina e sāsānide; nelle città, poi, per lo più i vescovi. L'ammontare complessivo del tributo (chiamato gizyah o kharāǵ: i due termini sono in origine equivalenti e si riferiscono il primo alla Siria e all'Egitto, il secondo all'‛Irāq, ripetendo il nome da istituti preesistenti all'occupazione araba) è fissato anno per anno (esistono papiri del sec. I dell'ègira in cui tale sistema è documentato) dal governatore arabo, e il capo della comunità infedele è libero di ripartirne il carico a suo talento tra i proprî amministrati. In cambio di questo tributo gl'infedeli vengono presi sotto la protezione" dei musulmani (dhimmah, donde il nome didhimmī (v.) col quale è designato il suddito non musulmano): i loro averi, l'esercizio del culto e l'applicazione della loro legge nei rapporti personali sono garantiti dall'autorità musulmana, che assume anche la loro difesa contro attacchi stranieri (donde l'esenzione dei non musulmani dal servizio militare, che durerà fino ai nostri giorni). Nell'insieme, come si vede, condizioni non dure, e senza dubbio molto migliori di quelle che erano fatte alle popolazioni indigene dai governi precedenti. La dominazione araba, passato lo sbigottimento dell'improvvisa invasione, fu dunque accolta e tollerata di buon grado. S'intende che dei tributi degl'infedeli era tenuta esatta registrazione: rimasero pertanto in piedi, nei loro elementi essenziali, le amministrazioni precedenti, e, data l'incapacità degli Arabi di provvedervi direttamente, gli antichi funzionari rimasero ai loro posti; perfino le lingue greca e persiana continuarono a essere usate nei registri per quasi tre quarti di secolo, e la prevalenza dell'elemento cristiano ed ebraico nel personale amministrativo durò lunghissimo tempo. Tuttavia, accanto a quello antico andava formandosi tutto un nuovo organismo amministrativo, emanante dal califfo e destinato alle particolari necessità militari e politico-religiose degli Arabi. Ogni provincia ha un governatore (wā‛mil o ‛āmil), cui il califfo delega le funzioni di capo militare e di direttore della preghiera pubblica, assistito da un corpo di guardia (shurtah). Indipendente da lui, e nominato direttamente dal califfo, è il giudice (qāḍī), le cui attribuzioni, da principio alquanto vaghe, andarono meglio determinandosi in progresso di tempo.
Gli enormi acquisti materiali dei primi invasori, estinguendo il loro desiderio di preda, avrebbero dovuto far sostare l'espansione araba: se così non fu, il motivo ne va cercato nell'afflusso di forze fresche richiamate dall'interno dell'Arabia dagli straordinarî successi di coloro che avevano iniziato le conquiste. Si apre così una seconda fase di spedizioni militari, le quali si dipartono dai grandi accampamenti fondati dai primi conquistatori (v. sopra) e s'irradiano in zone più estese: tale è il carattere dell'espansione araba sotto il terzo califfo, ‛Othmān (v., 23-35 èg., 644-656), e in questo periodo si compie la conquista dell'intera Persia (l'ultimo re sāsānide Yezdegerd III è ucciso mentre tenta di salvare gli avanzi del suo regno rifugiandosi nei monti dell'Irān) e gli Arabi si affacciano alle distese steppose dell'Asia centrale, venendo a contatto coi Turchi nomadi, mentre, protendendosi lungo la costa orientale del Golfo Persico, giungono ai confini dell'India. Dalla Siria spedizioni annuali infestano l'Asia minore e minacciano l'Armenia, ma senza giungere a occupazioni permanenti. In Africa, il dominio arabo oltrepassa i limiti dell'Egitto, della Pentapoli e della Tripolitania e s'insinua verso la Tunisia, risale il Nilo e si stabilisce in Nubia. Contemporaneamente, per togliere ai Bizantini il dominio del mare, si forma una marina da guerra araba (le ciurme dovettero tuttavia continuare a essere reclutate tra gl'indigeni); le isole di Cipro, Rodi e Creta sono corse e saccheggiate e la prima grande vittoria navale araba è riportata dal successore di ‛Amr ibn al-‛Āṣ nel governo dell'Egitto, ‛Abd Allāh ibn ‛Abī Sarh, a Phoinix sulla costa della Licia (34 èg., 654).
Le lotte civili e l'avvento degli Omayyadi. - Come Roma vide estendersi il suo impero pur attraverso il divampare delle guerre civili, così il giovane impero arabo, mentre proseguiva nelle conquiste, era profondamente turbato da rivolgimenti interni, che erano a un tempo crisi di sviluppo e lontani prodromi di dissoluzione. Un intimo dissidio era già contenuto, come si è visto, nell'origine stessa dello stato islamico: l'elemento più intelligente, più energico, più civile era dato in esso da quell'aristocrazia meccana che aveva osteggiato Maometto all'inizio della sua predicazione, e nella quale i musulmani di vecchia data, e specialmente gli Anṣār medinesi vedevano con risentimento la lunga infedeltà e la dubbia conversione preferite alla propria antica e sicura fede. Poiché appunto dell'aristocrazia meccana ‛Omar aveva fatto la base della propria politica interna, a essa aveva affidato comandi di eserciti, governi di provincie. Finché l'energico califfo rimase in vita, il suo senno seppe mantenere in equilibrio i due partiti, la sua autorità seppe imporre silenzio ai malcontenti; ma dopo la sua morte (egli cadde pugnalato da uno schiavo cristiano, per vendetta privata, a quanto pare, ma non senza qualche sospetto di movente politico) la bilancia piegò decisamente dalla parte dei Meccani: il suo successore, designato tra i proprî membri da un consiglio (shūrà) composto dei Compagni più anziani, i quali erano peraltro tutti meccani, risultò appunto il solo di essi che fosse a un tempo musulmano della prima ora e membro dell'aristocrazia meccana aggiungendo a questi titoli quello di essere genero di Maometto: ‛Othmān, appartenente a un ramo della famiglia dei Banū Umayyah (Omayyadi, ‛Ommiadi, [v.]), la più insigne delle grandi famiglie della Mecca. Uomo di sincera pietà religiosa, ma vecchio e poco energico, Othmān subì in misura larghissima l'influsso dei suoi parenti, i quali finirono col ridurre nelle loro mani tutti i posti di governo, dai quali a mano a mano vennero allontanati gli antichi Compagni e coloro stessi che erano stati i conquistatori del vasto Impero; questo si trasformava a poco a poco in un appannaggio esclusivo degli Omayyadi. Gl'interessi lesi si accomunarono in un'opposizione, nella quale alle rivalità gentilizie si univa la reazione del sentimento pietistico (che già andava accentuandosi in alcuni ambienti musulmani), e si accusavano gli Omayyadi di disprezzare e violare le prescrizioni del Corano, di voler riportare gli Arabi all'antico paganesimo. Le tribù che costituivano la massa dei combattenti, sostanzialmente indifferenti alla contesa tra Coreisciti e Anṣār, appoggiavano or questi or quelli; e ad accentuare la scissione dei partiti si aggiungevano, fenomeno consueto, interessi e passioni personali, differenze locali, circostanze fortuite. L'opposizione a ‛Othmān divenne sempre più intensa, specialmente nelle provincie, dove l'autorità del centro meno si faceva sentire: l'‛Irāq e l'Egitto furono i focolari della ribellione. Una spedizione di facinorosi, venuta dall'Egitto a Medina per chiedere giustizia al califfo, lo assediò nella sua stessa casa e, dopo un tumultuoso periodo di trattative, penetratavi a forza, lo uccise (35 èg., 656).
L'opposizione a ‛Othmān aveva fatto capo, da un lato ai due Compagni Ṭalḥah e az-Zubair, già entrambi candidati al califfato ai quali si era unita ‛Ā'ishah, l'astuta e ambiziosa vedova del Profeta, dall'altro ad ‛Alī (v.), primo cugino e genero di Maometto, il quale fin dalla morte di questo era stato oppositore sistematico dei tre primi califfi. Presente a Medina al momento dell'uccisione di ‛Othmān, ‛Alī fu acclamato califfo dagli Anṣār, appoggiati dagli Egiziani, sola forza armata che si trovasse nella capitale; i suoi rivali furono costretti a riconoscerlo, ma subito dopo fuggirono alla Mecca e, unitisi ad ‛Ā'ishah, decisero di cercare un appoggio nelle provincie, dove ormai si trovava il nerbo delle forze arabe, e mossero su al-Baṣrah; ‛Alī li seguì, e riuscì a trovare aderenti e alleati ad al-Kūfah: della quale fece il suo centro. Così il califfato lasciava l'Arabia, e questa cessava, da allora in poi, di aver parte significativa nello svolgimento della storia dell'Islām. Ormai, del resto, la porzione più numerosa e più attiva del popolo arabo si era riversata fuori della penisola, la quale anche dalla sua posizione eccentrica era tenuta estranea ai grandi avvenimenti che si svolgevano nelle provincie e, vuota di uomini e priva di risorse economiche, riprendeva il ritmo monotono della vita beduina, restando soltanto Mecca e Medina città sante dell'Islām e (con apparente contrasto, in realtà col carattere tipico di metropoli gloriose che gli eventi hanno escluse dall'attività politica attuale) a un tempo ritrovi d'arte e di vita mondana e centri di studî religiosi.
Schiacciati i ribelli nella battaglia del Cammello presso al-Baṣrah (36 èg., 656), ‛Alī si trovò di fronte Mu‛āwiyah (v.), il più potente dei membri della famiglia omayyade, da quasi vent'anni governatore della Siria, che durante l'ininterrotta guerra contro i Bizantinì aveva rinsaldato la disciplina delle sue milizie e se le era rese devote; uomo d'insuperata sapienza politica, altrettanto saldo nei propositi quanto versatile nei mezzi per attuarli. Egli, chiamato dalla legge dell'onore beduino a chieder vendetta del parente ucciso, non si atteggiò ad anticaliffo, ma pretese da ‛Alī che scindesse la propria responsabilità da quella degli uccisori di ‛Othmān e glieli consegnasse: proprio quello che ‛Alī, il quale aveva in essi i suoi maggiori sostenitori, non avrebbe mai potuto fare. Riuscito vano ogni tentativo di accordo, si venne a battaglia a Siffīn sull'Eufrate (37 èg., 657), e dopo un lungo succedersi di combattimenti incerti Mu‛āwiyah indusse l'avversario a rimettere a due arbitri il giudizio intorno all'uccisione di ‛Othmān, giudizio da pronunziarsi secondo i dettami del Corano. L'arbitrato riuscì nel fatto una commedia, e gli arbitri si separarono senza aver concluso nulla, e questo forse aveva appunto sperato e voluto Mu‛āwiyah; poiché la sola convocazione degli arbitri bastò a staccare da ‛Alī parte dei suoi seguaci, tanto quegli spiriti di esaltata fede religiosa, che ritenevano profanazione la nomina d'interpreti umani della parola divina, quanto coloro che, direttamente implicati nel delitto di Medina, temevano le conseguenze di un'inchiesta. I secessionisti, che assunsero il nome di Khārigiti (v.), furono disfatti da ‛Alī in un sanguinoso combattimento presso il Tigri (an-Nahrawān, non lungi dal sito di Baghdād, 38 èg., 658), ma il movimento da essi suscitato, nonché cessare, s'intensificò e, assumendo aspetti di guerriglia, seminò il terrore e l'anarchia in tutto l'‛Irāq. Quasi contemporanea fu la perdita dell'Egitto, dove ‛Alī era riuscito a spedire suoi emissarî; esso fu riconquistato a Mu‛āwiyah da ‛Amr ibn al-‛Ās, il suo primo conquistatore e governatore che ‛Othmān aveva deposto, ma che aveva avuto la prudenza di non compromettersi nella ribellione contro il califfo. Mecca e Medina stesse furono sottratte da emissarî di Mu‛āwiyah all'autorità di ‛Alī, sicché questi, rimasto padrone effettivo della sola al-Kūfah, era virtualmente debellato quando fu assassinato da un khārigita (40 èg., 661). I suoi più intimi partigiani proclamarono successore suo figlio al-Ḥasan (v. ‛alidi), ma il potere di lui rimase nominale: a Mu‛āwiyah fu facile guadagnarsi, col miraggio del trionfo ormai assicuratogli, gli ultimi fedeli del partito ‛alida; e i più influenti capi delle tribù, sanzionando ciò che era ormai stato di fatto, lo proclamarono califfo a Gerusalemme (41 èg., 661). Il potere supremo tornava agli Omayyadi, ma in mani ben altrimenti salde che quelle di ‛Othmān, e doveva rimanere nella stessa famiglia per quasi un secolo, durante il quale l'impero arabo allargò ancora di più i suoi confini e trasformò profondamente il suo assetto interno.



