1/ Dov’è il buon Dio? Vita spirituale al tempo del coronavirus. Terza lettera, di Gabriele Vecchione. 2/ La verità, vi prego, sull’Apocalisse. Vita spirituale al tempo del coronavirus. Quarta lettera, di Gabriele Vecchione
Dov’è il buon Dio? Vita spirituale al tempo del coronavirus. Terza lettera, di Gabriele Vecchione
Riprendiamo sul nostro sito un testo di Gabriele Vecchione. Restiamo a disposizione per l’immediata rimozione se la sua presenza sul nostro sito non fosse gradita a qualcuno degli aventi diritto. I neretti sono nostri ed hanno l’unico scopo di facilitare la lettura on-line. Per approfondimenti, cfr. le sezioni Per la pace contro la guerra e Immigrazione e integrazione.
Il Centro culturale Gli scritti (17/3/2020)
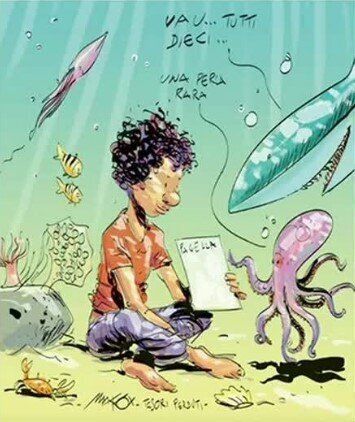
Perché durante ogni catastrofe naturale, pandemia influenzale o malattia grave non manca mai, nevvero, chi suggerisce interpretazioni spiritualoidi del tipo: “Dobbiamo capire perché il Signore ha permesso questa prova”, “Dio ti manda questa cosa perché sa che tu puoi sopportarla” (com’è umano lei), “il Signore aveva bisogno di lui/lei/loro nel suo giardino”, “Dio si è stancato/arrabbiato, occorre pregare pregare pregare (il lettore qui immagini l’emoticon delle mani giunte e della chiesa con il rosone a forma di cuore; Robespierre, torna, scusa, non ti abbiamo capito!)”?
Non si tratta qui di biasimare o confutare queste teologie antropomorfe da pochi spiccioli, quanto piuttosto di capire perché questo avvenga e come si possa evitare che la presenza di un cristiano accanto a chi soffre sia come quella di un condor felice di fare la sua predica, ma, appunto, di un cristiano.
La teologa svizzera Lytta Basset, nel libro Il senso di colpa, spiega che ognuno di noi, quando il male lo colpisce, si sente meno impotente se lo spiega con la sua colpevolezza. Immaginiamo che avremmo potuto impedirlo e questo ci ridà l’impressione di un certo potere nei confronti del male. Quello che ci è insopportabile è l’assurdità, la totale casualità del male.
La causalità, invece, sembra tranquillizzarci. Il bambino, per esempio, incapace di ovviare a ciò che avvelena la vita dei genitori, si sente egli stesso colpevole di non riuscire a renderli felici. Probabilmente da bambini non potevamo permettere, pena il biasimo dei genitori, una circolazione o un’espressione ai sentimenti di rabbia e di odio. Così li abbiamo riversati su noi stessi. Il senso di colpa generalmente affonda le sue radici nel primo periodo della vita, così nella nostra vita adulta lo troviamo cresciuto e annidato nel nostro sistema psichico. Ovviamente è un’intensità nociva e spesso iniziamo a volerci scagionare con tutte le forze. Compiere un atto realmente colpevole, accusare gli altri o auto-giustificarsi in continuazione sono dinamiche con cui cerchiamo di scagionarci, ma che paradossalmente garantiscono al senso di colpa una mostruosa proliferazione.
Tale senso di colpa lo proiettiamo direttamente su Dio o sul malcapitato cui si è abbattuta la sciagura di un virus, di un tumore o di qualunque nefandezza. Qualcuno deve essere colpevole: dunque o direttamente Dio o il peccatore. Qualcuno è così invischiato nella dinamica del senso di colpa che pensa di meritare il bastone che lo percuote: della serie “grazie, questo virus è un dono”.
Non esiste alcun senso nella diffusione di un virus. Non c’è alcuna spiegazione razionale per l’esistenza del male. Alcune vicende sono, purtroppo, semplicemente assurde e ingiuste. Chi s’avventura nella teodicea rischia di smarrirsi in boschi senza sentieri e parlare di un Dio che, come le divinità del pantheon greco, prova un gusto sadico a sgambettare gli uomini. Rischia di parlare di Dio come gli amici di Giobbe.
Elie Wiesel, nel romanzo autobiografico La notte, racconta di un bambino prigioniero ad Auschwitz. Lo chiamavano pipel, aveva il volto fine e bello. Wiesel dice che sembrava un angelo infelice. Un giorno, al ritorno dal lavoro, i prigionieri videro tre forche e tre condannati incatenati. Uno era il pipel. Migliaia di uomini costretti a guardare questo spettacolo ignominioso. Il capo del campo di sterminio lesse la condanna: impiccagione. Si trattava di una rappresaglia per un tentativo di sabotaggio. Fecero salire i tre condannati sulle seggiole. Infilarono le loro teste nei nodi scorsoi. Il capo fece un cenno. Le seggiole vennero istantaneamente tolte. Un prigioniero, dietro Elie Wiesel, domandò ad alta voce: “Dov’è il Buon Dio? Dov’è?”. I due adulti morirono subito. Il pipel agonizzò più di mezz’ora. Il solito prigioniero domandò: “Dov’è dunque Dio?”. Elie Wiesel racconta: “E io sentivo in me una voce che gli rispondeva: Dov’è? Eccolo: è appeso lì, a quella forca…”.
Gesù non ha esplicato l’esistenza del male. Ci si è sottoposto. È stato ignominiosamente torturato e crocifisso. Ha preso le parti delle vittime. Come se avesse voluto dire a tutti noi: qualunque cosa tu avrai a vivere, io la vivrò con te; e se la vita ti crocifiggerà, io sarò crocifisso con te. Possiamo considerare la risposta giunta nell’anima di Elie Wiesel come l’esito di un necessario nichilismo o come una profondissima intuizione mistica. Gesù dice: “Io ho avuto fame e mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e mi avete dato da bere; ero forestiero e mi avete ospitato, nudo e mi avete vestito, malato e mi avete visitato, carcerato e siete venuti a trovarmi” (Mt 25, 35-36). Dio si nasconde lì. In ogni pipel. Nelle vittime. E in ogni nostro gesto d’amore.
La verità, vi prego, sull’Apocalisse. Vita spirituale al tempo del coronavirus. Quarta lettera, di Gabriele Vecchione
Riprendiamo sul nostro sito un testo di Gabriele Vecchione. Restiamo a disposizione per l’immediata rimozione se la sua presenza sul nostro sito non fosse gradita a qualcuno degli aventi diritto. I neretti sono nostri ed hanno l’unico scopo di facilitare la lettura on-line. Per approfondimenti, cfr. le sezioni Per la pace contro la guerra e Immigrazione e integrazione.
Il Centro culturale Gli scritti (17/3/2020)
Si solleverà nazione contro nazione e regno contro regno, e vi saranno in diversi luoghi terremoti, carestie e pestilenze.
(Lc 21, 10-11)

Come non manca mai chi in tempi di crisi proietti su Dio la responsabilità di ogni sciagura, parimenti non manca mai chi in simili frangenti sventoli scenari apocalittici, spiegando di essere giunti alla fine del mondo e contribuendo a diffondere il panico. Terremoto? È l’attacco finale, il reflusso delle forze del Male. Riscaldamento globale? Colpa di Satana: o ci convertiamo o finiremo all’inferno. Coronavirus? Un avvertimento della Madonna di Medjugorie. E l’apocalittica, citata come se l’Illuminismo non ci fosse mai stato, viene brandita come un’arma per ottenere istupidimento, una spaventata sottomissione religiosa e forse anche qualche bonifico bancario.
Ma di cosa parliamo quando parliamo di apocalisse? Questo termine viene da άποκάλυψις, che significa rivelazione. L’apocalittica è un genere letterario che parla della fine di tutte le cose. È una rivelazione non perché preconizzi eventi futuri, ma perché quando le storie e le persone vanno verso la loro fine si rivelano per quello che realmente sono. E la scoperta di ciò che si è può mandare effettivamente in crisi.
L’apocalittica non parla di catastrofi inevitabili, ma rivela il presente alla luce del futuro. E il ricordo del futuro serve a dire al presente: la crisi non sarà perpetua. L’apocalittica è l’esatto contrario del panico. È il genere letterario cui diversi autori del Nuovo Testamento ricorsero per consolare i fedeli nel tempo della persecuzione.
Faccio un esempio per spiegarmi. Qualche anno fa, in ausilio alla cappellania, andavo due volte a settimana nel carcere di Rebibbia femminile, il venerdì pomeriggio e la domenica mattina. Avevo una stanza al piano terra dove potevo ascoltare le donne detenute. Un venerdì una ragazza mi raccontò cosa avesse significato sentire per la prima volta il rumore delle sbarre che si chiudevano dietro di lei. Mi raccontò alcuni incubi notturni. Mi disse che le sembrava di non riuscire a camminare, come se le sue scarpe si fossero attaccate al suolo. A un certo punto del colloquio qualcosa nel suo volto cambiò decisamente. Si spense. Ho pensato che avesse intimamente contattato un’angoscia profondissima. Chinò la testa sulla scrivania. Si mise a singhiozzare. Alzò il capo e, guardandomi, mi disse: “Io mi voglio suicidare”. E poi chinò nuovamente la testa sulla scrivania. La lasciai piangere un poco. Non sapevo che cosa dirle. Sentivo che la mia parola avrebbe potuto essere incisiva, non potevo restare nel silenzio, ma non potevo neanche cavarmela con un paternalismo bieco o con delle frasi fatte. Nel frattempo un assistente aveva fatto capolino dalla finestrella della porta di ferro per avvertirmi che era tardi e che dovevo lasciare il carcere. Mi venne da dire solo questo: “Ci vediamo domenica e ne parliamo ancora”. La prospettiva di un futuro aprì il muro dell’angoscia. Non si tolse la vita. La rincontrai la domenica successiva e tante altre volte ancora. L’apocalittica – la prospettiva di un futuro oltre l’angoscia – le diede una speranza.
Gesù ha fatto diversi discorsi apocalittici. Per esempio in Lc 21. Al versetto 5 troviamo scritto così: “Mentre alcuni parlavano del tempio, che era ornato di belle pietre e di doni votivi, Gesù disse: «Verranno giorni nei quali, di quello che vedete, non sarà lasciata pietra su pietra che non sarà distrutta»”. Il Tempio di Gerusalemme era stato ricostruito con una magnificenza tale che il nostro barocco seicentesco al confronto era minimalista. Sul portone che introduceva alla Shekinah Erode aveva fatto mettere una vite completamente d’oro con i rami d’uva a grandezza umana. Il perimetro del Tempio era stato fatto con pietre bianche di marmo di 13 metri. Gesù prospetta la distruzione del Tempio. Non riguarda anche noi questo discorso, che per evitare il diffondersi della pandemia abbiamo dovuto sospendere la liturgia?
Più avanti Gesù parla di falsi messia che si attribuiscono connotati divini e dividono la storia secondo la loro presenza (“Molti verranno e diranno: «Sono Io», e: «Il tempo è vicino»). Questo discorso non riguarda anche noi, che spesso siamo alle prese con personalità religiose carismatiche che di tanto in tanto si fanno il loro impero e si impadroniscono della coscienza di gente debole, che non ha risorse interiori per difendersi dalle sopraffazioni psicologiche?
Più avanti Gesù parla di guerre, terremoti, carestie; di persecuzioni subite a causa del suo nome; di crisi familiari e di tradimenti. Parla di noi o di eventi futuri?
Dopo aver descritto la crisi, Gesù dice anche come si possa farne un buon uso.
Anzitutto “non vi terrorizzate”, niente panico, perché “nemmeno un capello del vostro capo andrà perduto”. La prima cosa è aprire la crisi, accoglierla, senza far finta che non esista, senza divincolarsi violentemente, senza eleggere santoni. Il Signore sarà al nostro fianco. “Se Dio è per noi, chi sarà contro di noi?” – si chiede Paolo nella lettera ai Romani. Lui governerà sulle nostre paure e ci darà il coraggio di avere paura.
Poi Gesù dice: “Io vi darò parola”. Dalla crisi si riemerge prendendo la parola su di sé. Non attribuendo colpe agli altri, ma parlando con calma di quello che succede dentro di sé. Parlare non è semplicemente sfogarsi o alleggerirsi, ma realizzare la propria somiglianza con Dio. Il salmo 33 dice che “dalla parola del Signore furono fatti i cieli”. La parola è creatrice, la parola è un’azione perché crea delle cose che prima non c’erano. Dalla crisi - quale che sia: familiare, spirituale, psicologica - si esce parlando e dando nome al proprio vissuto interiore.
Infine Gesù dice: “io vi darò sapienza”. Nelle crisi e negli eventi apocalittici che ci svelano la realtà al di là delle illusioni, c’è sempre una sapienza, un significato, un’opportunità. I libri sapienziali dell’Antico Testamento sono costituiti da una serie di testi in cui gli ebrei hanno voluto leggere la creazione, la storia di Abramo e di Mosè, l’arrivo nella terra promessa con le categorie ellenistiche. Si pensava che l’ebraismo – incontrando la filosofia greca – sarebbe morto. Invece si rinnovò, si ravvivò, assunse nuove categorie per dire sé stesso. E così in ogni nostra crisi c’è una sapienza che non si vede subito, ma che poi emerge e che ci rende più realistici e ci fa venire a contatto con noi stessi. Nella canzone “La verità” Brunori Sas dice: “Il dolore serve proprio come serve la felicità”.
L’apocalittica ci dice che possiamo attraversare la crisi, perché il Signore, che spesso lavora con i materiali di scarto, saprà creare attraverso il nostro dolore.



