Islam: conoscere per convivere, di Samir Khalil Samir
Riprendiamo sul nostro sito dal volume Centro culturale Paolo VI, Una cultura per l’uomo 1980-2010, Como, 2010, pp. 82-91, la trascrizione di una relazione tenuta da Samir Khalil Samir sj - docente di teologia arabo-cristiana e di islamologia presso l’Università San Joseph del Libano - il 15/12/2001 presso il Centro socio-pastorale Cardinal Ferrari di Como. I neretti sono nostri ed hanno l’unico scopo di facilitare la lettura on-line. Restiamo a disposizione per l’immediata rimozione se la presenza sul nostro sito non fosse gradita a qualcuno degli aventi diritto. Per ulteriori testi, cfr. la sezione Islam.
Il Centro culturale Gli scritti (23/11/2025)
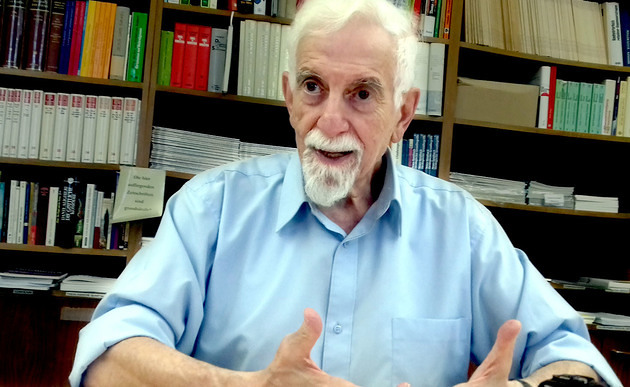
Ciò che è successo I'11 settembre ha sorpreso un po’ tutti, il mondo musulmano come l'Occidente. L'impressione che ho avuto è che in Occidente non solo abbia sorpreso, ma abbia creato anche delle domande: come mai questo fatto in nome dell'Islam? Bin Laden, come personaggio tipico, è veramente un musulmano?
Oppure, come sentiamo spesso dire, questo non ha niente a che vedere con l'Islam, perché "islam" significa "salam", cioè pace, tolleranza? Penso che voi abbiate visto in certi programmi televisivi le reazioni dell'imam della moschea di viale Jenner a Milano, oppure dell'imam di Torino, o altri che mantengono un discorso piuttosto violento.
Allora che cosa è l'Islam? Esistono più Islam? Qual è in tal caso quello vero? Questa sarà la prima questione che affronteremo.
La seconda sarà tentare di capire, andare un po' oltre, paragonando Islam e Cristianesimo, per comprendere meglio ciò che li accomuna e ciò che li differenzia. Perché in realtà, che lo vogliamo o no, partiamo dai nostri schemi, pensiamo di solito: «L'Islam tutto sommato sarà una religione un po’ diversa, ma comunque assai simile al Cristianesimo».
Soprattutto chi ha letto alcuni brani del Corano, che parlano della Vergine o che parlano di Gesù, pensa che siano molto simili. Perciò la seconda parte del nostro incontro cercherà di far comprendere meglio l'Islam e la specificità cristiana.
Nella terza rifletteremo, avendo visto l'Islam in sé e l'Islam in paragone con il Cristianesimo, sulla questione della convivenza, visto che i musulmani sono ormai numerosi in Europa.
Vivere l'uno accanto all'altro è una possibilità, vivere insieme è un'altra, oppure rifiutare la convivenza è una terza e dire: «Ognuno a casa sua». Si può vivere insieme? E se sì, a quali condizioni sia per il musulmano come per il Paese ospitante?
In conclusione farò qualche riflessione, piuttosto da cristiano, sul significato di questa presenza islamica, dal punto di vista teologico, qui in Italia e in Europa.
I.
La prima domanda parte dal fenomeno della violenza che abbiamo vissuto. È compatibile con l'Islam? Sì o no?
Per rispondere, ritornerò un attimo alle origini dell'Islam. Come è nato l'Islam, per quale scopo e che cosa è in realtà la religione islamica? L'Islam è la religione fondata da Mohammed, che è nato circa nel 570 d.C. È nato a La Mecca, città principale dell'Arabia; è una città centrale, commerciale, ricca. Nasce in una famiglia che non è molto agiata, anche se è una famiglia relativamente nobile. Da ragazzo ha lavorato come negoziante, carovaniere per una ricca donna più anziana di lui di quindici anni, Khadija, che sarà la sua prima moglie.
Durante tutta vita di Khadija lui non ha altre mogli, è l'unico periodo della sua vita monogamo.
Una piccola parentesi: sembra che Khadija avesse un cugino cristiano che li ha sposati, perciò ci potrebbe chiedere se non ci sia un legame tra il fatto che lui ha vissuto con ella monogamo, mentre dopo avrà sino a nove mogli nello stesso tempo.
All'età di quarant'anni (nel 610-612) ha delle rivelazioni, sente delle voci, trema, ha freddo, ha degli stati fisici strani. Tornato a casa, racconta alla moglie, che lo invita a rivolgersi al cugino cristiano; questi gli dice: «È l'angelo Gabriele, ascolta bene».
Io racconto questo fatto secondo quanto riferiscono le fonti musulmane, che non sempre sono controllabili.
Egli comincia a ripetere ciò che sente, lo recita; questa recitazione in lingua araba, che dura 22 anni, è ciò che dopo la morte di Maometto diventerà il Corano.
Alla Mecca ha vissuto fino all'età di cinquantadue anni, fino all'anno 622.
Egli comincia a predicare alla Mecca, affermando essenzialmente il primo punto fondamentale della fede musulmana: «Non c'è altro Dio che Dio, voi arabi pagani adorate varie divinità, invece ne esiste una sola: Allah».
Questo messaggio non è nuovo in Arabia, perché alla Mecca erano presenti anche cristiani ed ebrei. C'erano inoltre dei credenti in Dio che non erano né cristiani né ebrei.
Ora io concentro molto questi dodici anni di vita, che di solito gli orientalisti dividono in tre tappe. Il suo messaggio è rifiutato, e lui risponde invitando chi lo rigetta a chiedere a ebrei e cristiani, che possiedono la Scrittura: essi confermano che esiste un solo Dio.
Secondo aspetto del messaggio di Maometto è l'affermazione che ci siano alla fine della vita una ricompensa e una punizione, il cielo e l'inferno: «Se non vi comportate bene, se non obbedite a quest'unico Dio, andrete all'inferno», e ci sono delle descrizioni dell'inferno; «Se invece vi sottomettete a Dio, c'è il paradiso», e vi è la descrizione del paradiso.
Sottomettersi in arabo si dice "islem": islam significa dunque "sottomissione", sottinteso, a Dio. Gli ebrei e i cristiani sono concordi anche su questo punto.
Il discorso assume poi anche un aspetto sociale: essendo in una città di negozianti e ricchi, Maometto parla di solidarietà sociale con i poveri.
Egli suscita nei Meccani un rifiuto tale che i suoi seguaci, un piccolo gruppuscolo, deve fuggire nel 615 in Etiopia, che è un regno cristiano.
Passano alcuni anni (tre-quattro), e quando tornano recano con sé anche alcune nozioni cristiane: alcuni vocaboli che si trovano nel Corano che riguardano la Sacra Scrittura sono etiopici, per esempio la parola per indicare gli apostoli, il libro del Corano, ecc.
Ma l'opposizione con i Meccani diviene sempre più forte. Maometto decide di cercare un'altra soluzione, poiché non riesce più a convincerli con i discorsi; si mette allora d'accordo con la città opposta, la città che diventerà Medina ma che allora si chiamava Yathrib (Medina significa "la città" ", sottinteso la città di Maometto, perciò così sarà ovviamente chiamata dopo).
Fa dunque un patto militare con gli antagonisti della Mecca di reciproca assistenza nella guerra contro La Mecca. Difatti manda uno per uno i suoi seguaci a Medina e nella notte tra il 15 e il 16 giugno 622 astutamente fugge: va in direzione opposta, compiendo un giro, e finalmente raggiunge Medina (questa fuga in arabo si chiama hijra, come nella Bibbia la serva di Abramo, "la fuggitiva"; c'è quindi la stessa parola in ebraico e in arabo).
Il 622 è l'inizio dell'era musulmana, perché Maometto arriva a Medina. Con lui arrivano solo poveri che non hanno terra, senza mezzi di sussistenza; saranno aiutati dagli abitanti di Medina, però è un peso finanziario.
A Medina c'erano tre grandi tribù ebraiche, le più ricche della città, allora Maometto cerca di guadagnare gli ebrei di Medina. L'orientamento della preghiera per i cristiani è sempre stato l'oriente, l'est, l'orientamento della preghiera per gli ebrei era Gerusalemme; Maometto, o meglio il Corano visto come rivelazione divina fatta a Maometto, dà l'ordine di orientarsi nella preghiera verso Gerusalemme. Questa scelta durerà circa un anno e mezzo, poi quando l'intesa con gli ebrei non reggerà più, l'orientamento verrà cambiato e diventerà La Mecca.
In quel periodo anche il digiuno era un solo giorno, corrispondente per gli ebrei allo Yom Kippur, il giorno dell'espiazione. Però l'amicizia con gli ebrei non dura: alla fine del secondo anno dell'Egira, Maometto caccia una delle tribù ebraiche dalla città di Medina e prende i loro soldi.
Il motivo fornito dalle fonti musulmane sarebbe la rottura del patto da parte degli ebrei, avendo sostenuto i Meccani; sarà stato invece qualche fatto individuale che è servito da pretesto per spogliarli. Infatti egli ha bisogno di soldi per far sopravvivere sé ed il suo gruppo, allora, secondo l'uso abituale delle tribù arabe in quel periodo, compie delle razzie per guadagnare bottino.
Arrivano anche delle "rivelazioni" su come condividere il bottino: la quinta parte va al profeta e alla sua famiglia, il resto va ai guerriglieri che hanno fatto la guerra, la razzia.
Uso il termine "rivelazione" non in senso teologico, ma per usare la stessa parola dei musulmani, mentre per il cristiano non si tratta certo di rivelazioni.
Le rivelazioni arrivano sempre più concrete per rispondere ai bisogni della comunità: sono problemi sociali, politici, militari, problemi di famiglia, di organizzazione della città, di vendita e acquisto di schiavi e liberi, problemi matrimoniali, problemi di terreni, qualunque problema. E spesso, dopo qualche tempo che è stato sottoposto a Maometto un problema, arriva la risposta da parte di Dio; questa costituisce un brano del Corano, di ciò che diventerà il Corano.
Dunque le rivelazioni risolvono i problemi pratici, socio-politici o culturali. C’è un problema, ad esempio, con le mogli: la più simpatica, la più giovane, che aveva sposato quando lei aveva a otto o nove anni, sembra un po' capricciosa; allora arriva la rivelazione: «Donne del profeta dovete comportarvi in modo più riservato, non mostrate le vostre parti belle a tutti quelli che vengono a trovare il profeta».
Ho citato questo fatto, perché dimostra bene come una circostanza particolare diventa una regola generica; questo infatti è l'origine di un versetto molto discusso oggi tra i musulmani, che chiede di coprire certe parti del corpo femminile.
Questi primi nove anni di Maometto a Medina sono un periodo di guerre: per alcuni storici musulmani, organizza diciannove guerre, per altri, contando anche le piccole razzie e gli attacchi a carovane, più di ottanta.
Il periodo di Medina è un periodo più socio-politico, quello della Mecca è invece maggiormente dedito a questioni religiose, dogmatiche e di giustizia sociale.
Ci sono però contraddizioni tra alcune rivelazioni fatte a Medina e altre alla Mecca e gli arabi pagani lo notano. Giunge allora una risposta da Dio, che sarà molto importante per la storia musulmana: «Quando Dio rivela una verità che ne contraddice una precedente, Dio sa meglio ciò che fa, ed è la nuova che cancella la precedente».
Da qui deriverà infatti il principio ermeneutico fondamentale, il principio di interpretazione del Corano, chiamato il principio dell'abrogante e dell'abrogato, per cui il versetto rivelato dopo cancella quello rivelato prima.
Ne discende pero poi il grosso problema di sapere quale sia stato rivelato dopo.
Maometto all'inizio politicamente non ha avuto la meglio, è stato spesso sconfitto e in un caso è mancato poco che venisse ucciso; ma il fatto che sia scampato alla morte è stato considerato dai musulmani come un miracolo, che mostra la protezione divina su Maometto.
Nonostante tali difficoltà, Maometto con grande abilità strategica riesce a conquistare man mano tutte le tribù: quando una tribù era più debole l'attaccava, costringendola a sottomettersi e a pagare un tributo; quando invece era di pari entità, stipulava un patto di solidarietà contro altre.
In tal modo egli diventa sempre più forte e riesce a conquistare altre piccole tribù, finché nel 630 entra alla Mecca, la sua città natale, come conquistatore, seppur pacificamente: i Meccani riconoscono la sua supremazia, lo lasciano entrare e alcuni mesi dopo ottiene il permesso di fare il primo pellegrinaggio alla Mecca, suo grande desiderio.
Nel 632 muore tenendo il suo discorso finale, il discorso d'addio, che è abbastanza bello.
In questo periodo di tempo ha conquistato tutta la Penisola arabica, anche i principati del Sud, lo Yemen, che era cristiano.
La tradizione musulmana racconta come i principi cristiani con i vescovi arrivino a Medina e accettino di sottomettersi all'autorità di Maometto piuttosto che combattere, pagando ogni anno un fortissimo tributo per rimanere cristiani.
Il rapporto tra i musulmani e i credenti di altre religioni, infatti, è stato stabilito nel Corano in un modo non del tutto univoco: c'è la città musulmana, dove hanno pieno diritto i musulmani, chiamati nel Corano "i credenti".
Dentro la città musulmana i credenti imperfetti (questa è una mia espressione), cioè ebrei e cristiani, hanno diritto di vivere; saranno chiamati "i protetti", " "gente del libro", poiché possiedono una scrittura rivelata, purché accettino di vivere sottomessi ai musulmani e "umiliati" (la parola è nel Corano), devono cioè pagare un tributo a testa pro capite.
Accettando questo, hanno la vita salva e possono praticare la loro religione, ad alcune condizioni. Essenzialmente hanno diritto ad una pratica esclusivamente privata: la loro religione non deve apparire, nessuna croce, nessun campanello, non hanno diritto di proclamare pubblicamente la loro fede, possono pregare nelle loro chiese, non possono però costruirne di nuove o riparare quelle che stanno cadendo.
Dunque in realtà significa per ebrei e cristiani il diritto di vivere, però con una scomparsa organizzata, pianificata: man mano devono finire per essere assimilati o morire.
Invece chi non è né musulmano né protetto non ha diritto di vivere nella città musulmana: per ordine divino deve essere ucciso o convertirsi.
Nella parte delle rivelazioni avvenuta a Medina il musulmano ha l'obbligo di combattere sul sentiero di Dio per difendere Dio e il suo profeta, chi mette in pericolo la religione musulmana deve essere combattuto con tutti i mezzi; nel Corano viene raccontato nei particolari anche come combatterli e ucciderli.
Chi, per qualche motivo, non combatte e rimane a casa, è considerato ipocrita: uno che dice di essere musulmano, ma in realtà non lo è. Chi invece combatte e muore, raggiunge subito il paradiso ed è un martire; i versetti coranici sono molto chiari.
Da tutto questo emerge - cerco di riassumere questa prima parte - che l'Islam è un progetto socio-politico fondato su una verità considerata come rivelata da Dio e dunque inamovibile, l'unica verità assoluta che ci sia nel mondo, visto che viene da Dio.
Per questo i musulmani affermano che l'Islam è religione, società e politica, chi vuol precisare di più dirà che l'Islam è spada e preghiera.
Ci sono vari detti attribuiti a Maometto, che combinano elementi che per un cristiano non vanno di solito insieme, come ad esempio: «Ho amato nel mondo le donne, la preghiera, i profumi».
Questo per far capire che l'Islam è una totalità. Anzi i musulmani contestano ai cristiani il fatto che il Vangelo sia bellissimo, però astratto, irrealistico, irraggiungibile; la prova è l'incoerenza dei cristiani in Occidente dove tutti di nome sono cristiani, ma nessuno vive il Vangelo.
La grandezza dell'Islam invece sta nel suo equilibrio tra l'appetito sessuale e la tendenza alla preghiera, tra il godersi la vita e il digiunare; esso contempera la forza militare, il potere della conquista, la volontà di dominazione e la sottomissione totale a Dio. Così i musulmani vedono la loro fede ed in realtà è una descrizione abbastanza esatta.
È ovvio che è molto diverso dal cristianesimo, che non ha una legge come elemento costitutivo e fondante così forte.
Avrete probabilmente sentito la parola shari'a, addirittura adesso i musulmani italiani hanno creato l'aggettivo shariatico; in tutti i libri che parlano di Islam c'è questa parola: questa è una legge shariatica o non shariatica. Ebbene la shari'a è la legge rivelata da Dio, mentre il kanunh, dal greco kanon, è la legge umana.
La legge umana - dicono i musulmani - per sua natura è fatta da persone che hanno i loro desideri, le loro passioni, dunque è umana nel senso negativo della parola, non ha valore; solo la legge divina, il Corano, è eterna, immutabile e valida per tutti gli uomini.
Il progetto coranico dunque è pensato per l'umanità, tutti devono convertirsi all'Islam e il musulmano deve utilizzare tutti i mezzi disponibili per raggiungere questo scopo; però deve essere anche realistico: se non lo può raggiungere adesso, deve aspettare quando sarà possibile attuarlo.
II.
Analizzerò ora più rapidamente i punti di maggiore convergenza e divergenza tra Islam e cristianesimo. Convergenza c'è nell'assoluto monoteismo: il fatto che veramente Dio è l'assoluto, non c'è altro Dio che Dio, niente può venire prima di Dio.
Questa visione comune però è vissuta, è sentito più fortemente dal musulmano.
La mia conoscenza dell'Islam tuttavia mi fa dire che il monoteismo musulmano è più fanatico, perché non conosce il pluralismo della Trinità. Il tatto cioè che dogmaticamente in Dio stesso ci sia il dialogo, l'alterità; come diceva un filosofo arabo cristiano del X secolo: «In Dio, nel Dio cristiano, l'alterità fa parte dell'identità».
Dunque è negata nell'Islam la Trinità, la divinità di Cristo: Cristo è un profeta, però un profeta tra tanti altri; forse il più grande, che ha fatto più miracoli, ma è solo un profeta.
Maometto invece non è solo un profeta, nel Corano viene chiamato "il sigillo dei profeti". Ciò vuol dire che Maometto porta a compimento la religione rivelata da Dio all'umanità attraverso varie figure da Mosè fino a Gesù; poi arriva Maometto, corregge ciò che è stato deformato, completa ciò che è incompleto, infine chiude e sigilla, come la busta ormai chiusa, che non si può più aprire.
Il Corano riconosce le Scritture a lui precedenti: la Torah, cioè l'Antico Testamento, e il Vangelo, cioè il Nuovo Testamento. Il cristiano potrebbe fraintendere questo e credere che esista un terreno d'intesa nel Vangelo; ma così non è, perché essi considerano il nostro Vangelo falsificato, mentre quello vero, distrutto dai cristiani, si trova ormai integrato nel Corano.
Per esempio il Corano dice: «Cristo è il Verbo di Dio». Il cristiano pensa che venga riconosciuta la divinità di Cristo, perché per la nostra fede il Verbo è ovviamente coeterno a Dio, non potendo essere Dio senza Verbo, senza Parola, poiché, come dice san Giovanni, «Cristo è il Verbo ed è apud Deum». Invece per i musulmani il Verbo è stato creato con la parola, con l'ordine di Dio come tutti gli altri esseri; «Cristo è lo spirito di Dio», così dice il Corano, però questo significa solo che è una emanazione di Dio.
Cristo nel Corano crea l'uomo con dell'argilla; crea, soffia dentro esattamente come la creazione divina viene descritta nella Bibbia. "Crea" (usa questa parola tipica di Dio), soffia ed è una creatura vivente, però non si capisce il senso del termine "creazione"; il Corano inoltre aggiunge «con il permesso di Dio».
Cristo resuscita i morti, apre gli occhi dei ciechi nati, guarisce i lebbrosi, tutti i più grandi miracoli del Vangelo sono citati nel Corano, ma sempre accompagnati dal ritornello «col permesso di Dio». Questo significa che Cristo è una bella figura, un grande profeta al quale Dio ha concesso dei doni particolari, ma tutto finisce qui.
La vera figura invece è Maometto, che chiude la rivelazione, perché, secondo il Corano, quando Dio ha creato Adamo, l'ha creato musulmano, l'ha creato "Muslen".
C'è ambiguità nel termine "Muslen" ", che si può tradurre nel senso etimologico, "sottomesso a Dio", o nel senso storico di "musulmano".
Similmente accade con Abramo: il Corano contesta il litigio tra cristiani ed ebrei sull'appartenenza di Abramo all'uno o all'altro popolo, mentre egli in realtà era musulmano, così come gli apostoli, Gesù e Maria, la quale compiva tutte le pratiche religiose previste (pregava, dava l'elemosina, faceva il digiuno, ecc.).
Perciò per il musulmano l'Islam è la religione conclusiva dell'umanità: Dio si è rivelato attraverso Adamo, Noè, Abramo, Mosè, Gesù; essi sono le grandi tappe come nella Bibbia, ma nel Corano il culmine è rappresentato da Maometto, che costituisce il sigillo definitivo.
Non avrò tempo di sviluppare come si è composto il Corano. Le differenze a livello sociologico sono ancor più importanti, perché in realtà è la civiltà beduina del VII secolo che viene consacrata dalla legge rivelata da Dio.
Da qui deriva la struttura della famiglia, dove tutto è previsto: l'uomo è responsabile del mantenimento della famiglia, mentre la donna deve rimanere a casa; visto che è responsabile, è dunque superiore alla donna ed ha autorità, il testo è molto chiaro!
Questa è una rivelazione divina da non paragonare, per esempio, con i testi di san Paolo, che non hanno per niente questo significato, ma non è la sede qui per mostrarlo.
Oppure il testo coranico dice che tra l'uomo e la donna c'è differenza: l'uomo è superiore alla donna - è detto letteralmente -, per questo la donna, ad esempio, non potrà ereditare come l'uomo (la femmina riceve la metà del maschio); oppure in tribunale la sua testimonianza ha minor valore perché, secondo il detto attribuito a Maometto, la donna ha delle lacune quanto alla fede e quanto all'intelligenza.
Similmente circa la poligamia: l'uomo può avere quattro mogli più le concubine (il testo coranico le definisce «ciò che la sua sinistra può acquistare»), ma la moglie non può avere quattro mariti né concubini.
Oppure il ripudio, che è un privilegio dell'uomo, lecito persino senza andare in tribunale: basta dire tre volte «sei ripudiata» in presenza di due testimoni musulmani maschi adulti. È stata inoltre trovata una soluzione giuridica nel caso l'uomo ci ripensi: la moglie in questo caso deve sposarsi con un altro uomo, il quale l'indomani la ripudia, cosicché, essendo libera, il primo marito la possa riprendere.
Queste sono usanze beduine, alcune si ritrovano anche nell'Antico Testamento, ma il problema nasce dal fatto che nel Corano sono considerate rivelazione divina e pertanto sono immodificabili, valide per tutti i tempi e per tutte le culture.
Qui sorge la grande difficoltà di integrazione per l'Islam oggi, e da qui deriva anche l'incompatibilità tra la sharỉ'a islamica e le costituzioni occidentali rispetto a tutto quanto concerne ciò che noi chiamiamo "diritti umani".
Ad esempio, i Paesi musulmani non hanno firmato la "Carta dei diritti dell'uomo" anche perché essa prevede il diritto di libertà religiosa e di cambiare religione. Questo però è vietato nell'Islam: l'apostata, chi abbandona, deve essere ucciso, perché «la ribellione è peggio della guerra», dice il Corano.
Vi è inoltre un'altra grossa somiglianza che accomuna musulmani e cristiani: i principi di etica sessuale e di vita familiare. Tralasciando i concetti che ho menzionato, l'adulterio, ad esempio, è condannato a morte con la lapidazione nell'Islam come nell'Antico Testamento.
Non so se nell'Antico Testamento sia stato molto praticato, gli studiosi dell'ebraismo lo possono dire, ma è invece praticato ancora oggi nel mondo islamico là dove vogliono applicare la shari'a.
Oppure l'omosessualità, in linea di principio, viene condannata a morte, sebbene in pratica ciò non avvenga, se non negli ultimi tempi nei Paesi che hanno cercato di ripristinare la shari'a islamica (in Iran, ad esempio, sono stati uccisi alcuni omosessuali, in Egitto quest'anno sono stati messi in prigione 62 omosessuali ed è molto vivace la polemica su questo tema).
Intendo comunque dire che l'Islam sull'aborto e su tutti questi temi è più vicino all'atteggiamento cristiano che non a quello laico.
III.
Vengo, per mancanza di tempo, alla terza parte: «È possibile vivere insieme?».
Prima alcune osservazioni: l'immigrazione musulmana in Europa è ormai un fatto assodato. Essa ha radici di natura economica, perché l'Europa offre più lavoro rispetto al mondo musulmano, avendo bisogno di mano d'opera in quanto demograficamente ferma.
L'Italia, se non sbaglio, è l'ultimo Paese, seguito a breve dalla Spagna, dove la natalità è così bassa che non permette di rimpiazzare i morti, mentre nel mondo islamico è molto alta.
Dunque l'Europa chiede, importa degli emigrati e tra questi vi sono dei musulmani, che non sono la maggioranza, contrariamente a ciò che si pensa. In Italia, solo per fare un esempio, le ultime statistiche degli extracomunitari presenti contavano i musulmani al 36%.
Essi risultavano quindi essere un po' più del terzo, almeno quelli registrati; 64% invece sono non musulmani (58% cristiani e 6% di altre confessioni). È un fatto importante, perché in realtà sui media si parla molto più spesso dell'immigrazione musulmana che dell'altra.
Questo ci pone una domanda: perché gli altri non suscitano un così acceso dibattito?
La ragione non sta in una maggiore cattiveria dei musulmani, ma nella natura stessa dell'Islam che è un progetto politico, un progetto di civiltà.
Il musulmano, infatti, non considera la religione nel senso cristiano cattolico della parola, cioè come il rapporto tra l'individuo e Dio, tramite la preghiera, l'adorazione. Questa è una minima parte dell'Islam. Essere musulmano invece significa avere delle leggi, avere un concetto di potere, avere un modo di sposarsi, di ereditare, di vestirsi, di mangiare.
Questo fa sì che essi abbiano allora delle rivendicazioni e pretendano di poter applicare la loro legge, la shari'a appunto, con tutti i problemi che questo comporta.
Come si fa ad avere nello stesso Paese una legge che dice che la poligamia è un reato e contemporaneamente permetterla per i musulmani? A chi volesse avere più mogli basterebbe, allora, convertirsi. Non si può avere un doppio sistema.
Problemi simili nascono per l'eredità, per il matrimonio, per la libertà religiosa. Nell'Islam, ad esempio per legge, non per motivi sociologici, i figli appartengono all'uomo, dunque in caso di divorzio il padre li prende automaticamente con sé. Sebbene di solito fino a sette anni siano affidati alla mamma, appartengono però al marito, che decide come educarli ed ogni altra cosa; raggiunta infatti quell'età, tornano da lui.
Pertanto la religione del padre è vincolante per i figli: anche se la mamma cristiana volesse dare loro il battesimo, sono automaticamente musulmani. Teoricamente la moglie potrebbe rimanere cristiana, ma perde tutti i suoi diritti: non può, ad esempio, ereditare dal marito.
Dunque il sistema musulmano è pensato in funzione del potere, per questo se ne parla di più. Perché i musulmani di conseguenza chiedono, rivendicano, tanto che nelle scuole, negli ospedali, sugli aerei ormai viene dato cibo musulmano accanto al cibo cristiano, come loro desiderano.
Io sono cristiano copto; nella nostra tradizione ci sono duecento giorni di digiuno. Ciò vuol dire che per duecento giorni siamo anche vegetariani, ma, se mi offrono della carne o non c'è sufficiente quantità di verdura, non pretendo, ma dico: «Pazienza! Non sto a casa mia».
Il musulmano invece protesterà, dicendo che questo è un diritto, perché è stato richiesto da Dio. Qui è il punto sorgivo del problema, che poi si concretizza in molteplici questioni, come l'abbigliamento (avrete visto in televisione quelli convertiti all'Islam, i quali, chissà perché, si mettono subito sulla testa una grande stoffa lunga, perché questo è il vestito musulmano; ma non è mai stato indicato, è solo un imitare il profeta, che era vestito così perché allora non si conoscevano i pantaloni). Visto che il dettame islamico entra in tutti i più piccoli particolari, diviene un conflitto di civiltà.
La convivenza con i musulmani è possibile, ma difficile: difficile per i motivi che ho detto, possibile perché il musulmano, preso come individuo, è una persona brava, buona. Io non ho mai veramente avuto un problema sia in Egitto, sia in Libano, o altrove con un musulmano; quando ne ho, è con il sistema musulmano, e ciò accade perché il sistema musulmano è fatto per dominare.
Come nasce il sistema? Basta che arrivi uno che solleciti la necessità di mostrare l'identità musulmana e compatti la presenza di quei cento musulmani che vivono nello stesso territorio.
Ora l'Islam si presenta con una identità forte, ma è solo apparenza, in realtà sta passando il periodo più forte di crisi della sua storia. Probabilmente si sentono loro i più deboli, lo scrivono tutti i giorni sui giornali come nei libri: «Siamo il popolo più disprezzato della terra e per questo dobbiamo affermare di più la nostra identità».
Allora arrivano in Europa, in Italia o altrove e hanno la necessità di affermarsi fortemente. Oppure vengono solo per sopravvivere e non hanno questo desiderio, ma sono manipolati da alcuni capi, che ordinano loro di mettersi il velo e farsi fotografare così: «Bisogna andare in Piazza del Duomo a Milano e lì, in diecimila, venerdì a mezzogiorno, pregare e in tal modo mostrare la nostra forza».
La gente comune è spaventata, perché in Piazza del Duomo vedono tutti questi musulmani inginocchiati e pensa: «Mamma mia, questi sì che pregano!».
Ma in realtà è un atto politico, non è un atto religioso, è l'atto d'affermazione di una identità.
Nello stesso tempo arrivano in una Europa, che per motivi storici sta perdendo identità o sta lottando contro la propria identità. C'è tutta un'ideologia, che usa una terminologia di tipo illuministico: si parla di pluralismo, di multiculturalità.
In realtà mi sembra che sia abbastanza chiaro si tratti di una reazione anticristiana, che afferma il desiderio di una società aperta a tutte le culture e a tutte le identità, dove così l'identità cristiana diventa una tra tante altre.
E, visto che ormai anche in Italia non ci sono solo cristiani, ma ci sono indù, buddisti, ecc., si propone, per esempio, di togliere i crocefissi dalle scuole, perché siamo in una società multiculturale. Ma pochi in Italia, o almeno non abbastanza persone, riflettono sulla questione dell'identità, ponendosi la domanda se esista ancora un'identità italiana.
Come vivere insieme dunque? Dicevo: è possibile, ma difficile.
Ci sono però delle condizioni: il musulmano, o qualunque altro immigrato desideri venire in Europa, deve prima prepararsi. Facciamo un esempio tratto dalle nostre abitudini: quando un ragazzo vuole sposare una ragazza, si informa sulla ragazza, si informa sulla famiglia, perché si rende conto che deve vivere in mezzo a questo ambiente ormai; magari con la ragazza si intende benissimo, ma non con i genitori.
Allora si interroga: posso, sono disposto a vivere in lotta continua con i miei suoceri? Se la risposta è negativa, il buonsenso lo induce a rinunciare, pur con dispiacere, al matrimonio. Quando invece un immigrato viene, non si chiede nulla, né gli chiedono se lui sappia qualcosa della civiltà dove va, dell'Italia, della lingua, della cultura, della storia, delle usanze italiane.
Non è colpa sua! Se lui sbaglia, è per ignoranza, ma è anche colpa di chi gli permette di venire senza porre alcuna condizione. A me sembra il bene di tutti quanti fermarsi e organizzare un pochino le cose; le ambasciate sono fatte per questo.
In Marocco, per dire, si possono aprire dei corsi per chi vuole emigrare e organizzare le cose con un po' di esperienza; si può arrivare dopo pochi anni ad un programma che trasmetta la lingua, le usanze, le regole del vivere insieme, le leggi principali, le informazioni basilari insomma.
E chi supera questo ha priorità nell'emigrazione, perché sarà più felice, potrà integrarsi meglio, avere più facilmente amici, trovare più facilmente un lavoro e anche farsi accettare.
Ma l'immigrazione, che ora è così selvaggia, fa torto a tutti, perché ad un certo punto anche il Paese ospitante reagisce in modo irrazionale, respingendo chiunque; ma questo non è possibile, allora c'è lotta.
Inoltre, se accetto l'immigrato, devo aver previsto la struttura di accoglienza e le necessarie infrastrutture: se arrivano centomila persone all'anno, è necessario ci siano strade, case, uffici postali, ospedali, scuole per centomila; ma se non ci sono, allora è disonesto.
Per riassumere, direi che le condizioni necessarie per una buona convivenza sono due: da parte dell'immigrato ci deve essere il desiderio di volersi integrare; se non vuole o non può, è meglio che non venga! Meglio per lui e per gli altri.
Da parte del Paese ospitante ci deve però ovviamente essere l'apertura di cuore per aiutare chi viene ad integrarsi, sostenendolo a tutti i livelli: nel creare amicizie, nel permettere che i bambini giochino insieme, ecc.
La seconda condizione è che il Paese ospitante abbia un'identità chiara, ed è ciò che manca! Bisogna definire l'identità italiana, ma questo richiede un dialogo tra italiani che non è ovvio.
Non c'è dubbio che il cristianesimo è una componente essenziale, a livello sociologico intendo, non a livello di fede. Ciò che ognuno pensa o pratica è una scelta personale, ma culturalmente il cristianesimo è la componente maggiore della storia e della cultura italiana; ci sono poi altre componenti minori, ma comunque importanti: il Rinascimento, l'Illuminismo, la laicità, la separazione tra Chiesa e Stato, tra i vari poteri (quello che vediamo adesso, ad esempio, emergere nel dibattito circa il rapporto tra magistratura e politica).
Si tratta di definire il più chiaramente possibile quale sia la nostra tradizione, in cui all'immigrato chiedo di entrare a far parte. Perché altrimenti egli, in una zuppa, non si integra, se non c'è un nucleo chiaro...
Per chiarire questo concetto utilizzo un aneddoto risalente al mio periodo di noviziato in Francia: dovevo fare la maionese per duecento persone e non avevamo l'elettricità. Si prendeva allora il tuorlo dell'uovo con un poco di pepe e di senape, poi con la forchetta nella mano destra si batteva continuamente, mentre con la sinistra si faceva scendere un filo d'olio lentamente. Ci volevano i muscoli a montare la maionese per duecento persone, e lì la si mangiava tutti i giorni con 'insalata. Però, se all'inizio avevo fatto troppo presto a versare l'olio, non si amalgamava, impazziva; eppure questo piccolo nucleo del tuorlo, se permettevo all'olio di assimilarsi lentamente, poteva diventare venti volte più grosso, un'unica massa più grande.
Così anche la nostra società impazzisce, se non c'è il nucleo di partenza intorno al quale si integrano altri elementi. Non c'è una società solidale, ci sono elementi separati. L'immigrazione, la convivenza è possibile, ma è difficile ed è un lavoro che richiede generazioni. Richiede però anche volontà, chiarezza, autoconsapevolezza di entrambi gli attori, richiede un progetto. Questo è un progetto di solidarietà, non a qualunque condizione, però di solidarietà.
IV.
Vorrei concludere con una riflessione teologica.
Mi ricordo che i nostri padri missionari notavano come per secoli la Chiesa avesse mandato missionari nel mondo islamico senza alcun risultato: nessun musulmano, dopo tanti secoli e migliaia di missionari e di sforzi umani e spirituali, si è mai convertito.
Essi riscontravano la causa di ciò nell'ambiente musulmano, che non permette la libertà di scelta, tante ragazze, ad esempio che studiavano dalle suore, erano molto attirate dal cristianesimo, però non c'era la possibilità di fare il passo e convertirsi, ci volevano degli eroi.
Ebbene adesso non c'è più bisogno di attraversare il mare per incontrare i musulmani, vengono loro da noi: sono dodici milioni in Europa, in Italia un po’ più di settecentomila.
Questo è uno sforzo in meno, non c'è bisogno di partire. Per di più si trovano in un ambiente, dove possono entrare tutti i giorni in chiesa senza che nessuno li disturbi. Si trovano in un ambiente non musulmano, dove non ci sono leggi musulmane che li opprimono o che li condizionano.
Ci sono insomma tutte le premesse per permettere l'apertura a Cristo, fuorché una: ci vogliono missionari, ci vogliono cristiani!
È questa, a mio avviso, la questione centrale. Anziché vedere l'immigrazione come un pericolo - lo è anche -, anziché vederlo come un pericolo per i cristiani e per la cristianità, perché non vederlo come un atto della Provvidenza divina, che ci manda a casa persone, che forse sono desiderose di conoscere il cristianesimo!?
Posso dire che davvero il musulmano, essendo profondamente credente, quando arriva in Italia, resta molto deluso, perché pensa di incontrare dei credenti ed invece qui il discorso religioso non si fa mai.
Lo dico non per teoria, perché mi capita spesso a Roma di parlare con dei ragazzi che vendono per strada (non su bancarelle). Spesso sono egiziani e nell'approfondirsi del dialogo emerge il loro stupore per l'assenza dei cristiani, di persone cui interessi il discorso religioso.
Ed è veramente così! Io credo che non si tratti di fare una crociata, ma di riconoscere che queste persone hanno diritto al lavoro, ad una vita decorosa, hanno il dovere di servire le norme del Paese dove si trovano, piaccia o non piaccia, ma hanno anche il diritto di conoscere Cristo.
Però come lo conosceranno, se non c'è un missionario, come dice san Paolo? Questo fatto mi fa ricordare le parole del Vangelo: «Quando verrà Cristo, troverà ancora la fede sulla terra?». Troverà ancora gente convinta anche in Europa? E veramente la sfida più grande che i musulmani ci pongono.



