L’uomo che fu Giovedì, di Annalisa Teggi
- Tag usati: annalisa_teggi, chesterton
- Segnala questo articolo:
Riprendiamo dal blog di Annalisa Teggi Capriole cosmiche un suo articolo pubblicato in tre parti il 17, il 19 e il 24 settembre. Restiamo a disposizione per l’immediata rimozione se la sua presenza sul nostro sito non fosse gradita a qualcuno degli aventi diritto. I neretti sono nostri ed hanno l’unico scopo di facilitare la lettura on-line.
Il Centro culturale Gli scritti (2/11/2014)
1/ L’uomo che fu Giovedì, parte 1: la discesa agl’inferi
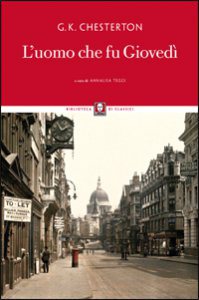
«Perché non c’è niente di così piacevole come un incubo,
quando sai che è un incubo. …
Io risponderò alla chiamata del Caos e dell’Antica Notte.
Io cavalcherò l’incubo, ma lui non cavalcherà me».
GKC
Quando ho concluso la traduzione de L’uomo che fu Giovedì di G. K. Chesterton avrei voluto scrivere un’introduzione o postfazione alla nuova edizione che sarebbe uscita; la cosa avrebbe gratificato il mio orgoglio (cose tipo: ho capito questo, e ho capito quest’altro… ) e avrebbe anche soddisfatto la logorrea che sgorga spontaneamente quando si finisce un libro di Chesterton (l’incontenibile voglia di dire un sacco di cose, tipo: e c’è quella battuta che mi ricorda quella volta in cui… ecc ecc, e c’è quella descrizione che è proprio identica a…). Giusto o sbagliato che sia, non ho corredato la mia nuova traduzione con nessuno scritto.
Innanzitutto perché Chesterton, nella sua Autobiografia, si lamentò della sovrabbondanza di interpretazioni date a questa sua storia e sottolineò che, contemporaneamente, si era prestata poca attenzione al sottotitolo, che di per sé doveva essere usato come eloquente chiave di lettura: un incubo.
In secondo luogo, oltre al sottotitolo, un’introduzione vera e propria fu già scritta dall’autore stesso. Mi riferisco alla poesia iniziale, composta da GKC come dedica all’amico E. C. Bentley:
«Questa è la storia di quelle vecchie paure, di inferni trovati vuoti,
E solo tu capirai il vero di cui quest’ incubi sono intessuti:
Incubi di dèi infami, che distruggono la vita e scompaiono in un’ora,
Di diavoli che oscurano le stelle, poi cadono con un colpo di pistola».
Il diavolo non è così nero come lo si dipinge, è questa la scommessa/battaglia del romanzo. E, sempre nell’Autobiografia, GKC riprende questo filo conduttore, dichiarando a proposito de L’uomo che fu Giovedì:
«Se mai la storia possiede un senso, intendeva esordire con un ritratto del mondo nella sua peggiore rappresentazione e dimostrare che, invece, il quadro non era poi così nero come sembrava».
Se uno ha in canna il colpo giusto, può disintegrare il velo scuro dell’incubo. Questa è la speranza di questo libro: è una strada ripida nella discesa, e repentina nella risalita, di chi va nel buio a smascherare la menzogna di chi oscura il cielo, e poi esce a riveder le stelle.
Proprio per questo, chiunque legga L’uomo che fu Giovedì, è molto grato all’autore di averlo scritto e può cadere nella tentazione di volerlo ringraziare per iscritto, come faccio io ora. Niente erudizione. È solo una mia riflessione grata e, ahimé, molto prolissa, perché molti «fili elettrici» che mi scorrevano sottopelle si sono scoperti durante la lettura, e il modo in cui Chesterton li ha accesi mi ha scosso.
Crisi
L’adolescenza è una delle tappe più complesse della nostra vita, e per Chesterton fu il periodo in cui fu colpito da una drammatica crisi esistenziale, durante la quale mise sottosopra cielo e terra, tutto e niente, senso e assenza di senso. Ne parlò lui stesso nel capitolo Come diventare pazzo della sua Autobiografia:
«il fatto è che i miei occhi erano rivolti verso l’interno piuttosto che verso l’esterno, conferendo alla mia personalità morale, io credo, uno sgradevole strabismo. Ero ancora gravato dall’incubo di negazioni dell’anima e della materia, dalle morbose rappresentazioni del male, dal fardello del mio corpo e del mio cervello, stranamente misteriosi».
Vale la pena vedere come Chesterton rielabora questa sua condizione biografica in forma di immagine simbolica nel romanzo Uomovivo, di cui è protagonista Innocent Smith. Al tempo in cui frequenta l’università, Innocent segue le lezioni di filosofia del Prof. Eams, fervente divulgatore di teorie nichiliste. Essendo un alunno diligente, Innocent decide di prendere sul serio il professore e di verificare, alla prova dei fatti, se la vita è nulla. La notte in cui Smith decide di andare dal Prof. Eams per ingaggiare con lui una partita all’ultimo sangue (per entrambi), l’autore è molto puntiglioso nel descriverci l’ambiente e l’atmosfera che circonda il giovane studente, la cui anima è sinceramente lacerata dal terrore che la visione cupa del nulla sia l’ultimo orizzonte sul vivere umano:
«Il paesaggio che circonda gli edifici di questo College è pianeggiante, ma non ha un aspetto affatto piano per chi lo osserva dall’interno del College. Perché tra queste piatte paludi si creano sempre degli occasionali laghetti o dei ristagni d’acqua e questo cambia costantemente la prospettiva, mutando quello che dovrebbe essere uno schema orizzontale di linee in uno schema di linee verticali. In tutti i punti in cui quest’acqua crea delle pozze, l’altezza degli edifici si raddoppia, così che una comune casa inglese in mattoni assume l’aspetto di una torre babilonese. Perché su quella superficie luminosa e piatta le case si riflettono perfettamente, producendo un’immagine capovolta ma corrispondente all’originale fino al comignolo più alto e a quello più basso. Il riflesso di ogni nube corallina, visto attraverso quello specchio d’acqua, sprofonda dentro il mondo tanto quanto l’originale s’innalza nel cielo. […] Sotto i piedi dell’uomo la terra si spacca a metà, creando vertiginose prospettive aeree […]».

Foto di Loic Lagarde
Il tremendo pericolo di un eccesso di riflessione, ecco cosa descrive qui GKC. E lo fa usando la cosa più efficace possibile, un’immagine: la mente dell’uomo è come uno specchio d’acqua, riflette. Riflettere significa vedere due volte la stessa cosa, come accade in una pozzanghera o uno stagno: c’è l’oggetto reale e c’è il suo riflesso identico e capovolto (ma inesistente) nell’acqua; lo stesso accade nella mente umana, che è il luogo in cui l’uomo riflette, cioè ri-vede il reale. E questa capacità riflessiva può diventare vertiginosa («una semplice casa può diventare una torre babilonese»), insomma può tramutarsi in uno sgradevole strabismo, come dichiarato da GKC nell’Autobiografia, se l’immagine (irreale) della mente diventa più reale di quella della realtà. Cioè se l’incubo prevale sulla realtà. Ecco, infatti, cosa accade al giovane Smith che – simbolicamente e pericolosamente – cammina (per affrontare il Prof. Eams) in questo paesaggio pieno di specchi d’acqua che raddoppiano la vista di ogni oggetto:
«Era nel mezzo del suo cammino, in quella notte stellata dalla luce sconcertante, le stelle erano sopra e sotto di lui. E la sua cupa fantasia gli sussurrava che il cielo sotto i suoi piedi era più profondo di quello sopra la sua testa: era ossessionato dall’idea terribile che, se si fosse messo a contare le stelle, ne avrebbe trovata una di troppo nella pozza. […] Per lui, come per quasi tutti i giovani studenti del suo tempo, le stelle erano cose crudeli. Anche se brillavano ogni notte nella grande volta celeste, erano un enorme e tremendo segreto, perché mettevano a nudo la natura, come se mostrassero chiari indizi degli ingranaggi di ferro e delle pulegge che stanno dietro la scena. Perché i giovani cresciuti in quell’epoca triste pensavano che il divino provenisse dalla macchina. Non sapevano che, in realtà, è la macchina a provenire dal divino. In breve, erano tutti dei pessimisti e la luce delle stelle era crudele ai loro occhi … ed era crudele perché li metteva di fronte alla verità. Per loro l’universo era tutto nero con qualche puntino bianco».
Nel mezzo del cammin di sua vita, il giovane Gilbert si trovò a percorrere la stessa strada di Innocent Smith: si trovò a fronteggiare quel dubbio estremo che colpisce la mente quando rivolge «gli occhi più verso l’interno che verso l’esterno», e arriva persino a credere che l’universo riflesso dentro la mente abbia una stella in più di quello reale, cioè sia più vera la riflessione della realtà. Come Dante, Chesterton seguì la via più coraggiosa per uscire dalla selva mortale: quella di scendere agli inferi, quella di vivere l’incubo fino in fondo:
«io mi sentivo un impulso irresistibile a scrivere idee orribili e a disegnare immagini orribili, sguazzandoci dentro in una sorta di cieco suicidio spirituale … vorrei dire che ho scavato talmente in profondità, da incontrare il diavolo e misteriosamente riconoscerlo» (da Autobiografia).
E qui entra sulla scena Gabriel Syme, il poeta-poliziotto filosofico, protagonista de L’uomo che fu Giovedì. Ecco colui che scaverà in profondità tutti i meandri dell’incubo, e ne riemergerà segnato, ma vivo. Alive, un sopravvissuto che … nel tempo… sarà capace di gridare manalive!, cioè: Evviva!.
Ed ecco perché, rispetto a tutte le esegesi critiche che si erano soffermate a indagare la visione religiosa sottesa al Giovedì, Chesterton preferì di gran lunga la testimonianza di chi gli disse che molte persone in difficoltà avevano trovato pace leggendo questo libro:
«Vorrei piuttosto citare l’elogio che mi fu fatto da un uomo di tipo completamente diverso, che, per qualche ragione, fu uno dei pochi a trovare il bandolo della matassa del disgraziatissimo romanzo della mia giovinezza. Era un celebre psicanalista, dei più all’avanguardia e dei più scientifici. … Era uno studioso attento e competente e mi fece rizzare i capelli in testa, quando disse che aveva trovato il mio romanzo giovanile un rimedio utilissimo per i suoi pazienti, soprattutto il lungo processo con cui il diabolico anarchico si rivela un rispettoso cittadino travestito. “Conosco molti che erano vicini alla pazzia” mi disse con tutta serietà, “e che trovarono la pace per aver capito L’uomo che fu Giovedì». Era sicuramente eccessivo, nella sua generosità, anzi forse era lui a essere pazzo. Ma confesso che mi lusinga che in quel periodo di personale follia, io possa essere stato di un piccolo aiuto ad altri pazzi come me».
2/ L’uomo che fu Giovedì, parte 2: la notte della battaglia
Nel fondo del cuore di ogni uomo, ovunque trascorra la sua vita,
c’è un male di vivere che è nobile, un sacro scontento.
G.K. Chesterton, da Adveniat regnum tuum
L’impresa che, nella trama de L’uomo che fu Giovedì, Gabriel Syme deve compiere, è quella di confrontarsi con un nemico spietato, che sparge terrore e disordine nel mondo: l’anarchia. La sua discesa agli inferi assume, innanzitutto, la forma della discesa nel covo di una congregazione di anarchici, la cui sede sotterranea è stipata di fucili, rivoltelle e bombe. Sottoterra, c’è un luogo esplosivo che vorrebbe dilaniare il mondo consegnandolo al caos e al nulla della distruzione. Allo stesso modo, nel fondo del cervello di un uomo, può covare una forza che spinge la mente a confrontarsi con l’incubo supremo del nulla. Il Segretario del Grande Consiglio Anarchico, che Gabriel incontrerà nel corso di una colazione, afferma:
«Il coltello rappresenta il tipo di vendetta personale di vecchio stampo, quella del singolo uomo contro il singolo tiranno. La dinamite, oltre a essere la nostra arma migliore, è anche il nostro simbolo migliore. È un simbolo perfetto quanto lo è l’incenso che accompagna le preghiere dei cristiani: si espande. Ed è distruttiva proprio perché si diffonde; allo stesso modo, il pensiero è distruttivo proprio perché si diffonde. La mente di un uomo è una bomba».
2.Luce e ombra
Chi sceglie di confrontarsi con questo nemico, affronta un duello mortale e vitale insieme. Il paradosso che prende corpo in tutta la produzione di GKC è che l’uomo si accorge davvero della luce (vita) solo mettendola a fuoco sullo sfondo del buio (morte). La mente dell’uomo può essere una bomba distruttiva – quando rivolge eccessivamente gli occhi verso l’interno – ma essa può anche generare un’esplosione benefica, se rivolge lo sguardo alla sua relazione con il mondo esterno e vivente. Si tratta, attraverso un percorso audace, di mettere a fuoco questa risorsa buona che giace nel profondo di ogni uomo. E, come insegnava la fotografia di un tempo, affinché in un’istantanea emergano i colori, si deve passare dalla camera oscura.
Dunque Syme deve scendere al buio, abbandonando il regno della luce. Il romanzo, infatti, inizia col tripudio di un tramonto bellissimo, in cui il cielo dà il meglio di sé … quasi per tendere una mano al giovane Gabriel, che di lì a poco sprofonderà nella notte:
«Se non per altro, nella zona ci si ricorda di quella sera particolare a causa di uno strano tramonto. Sembrava l’apocalisse. Tutto il cielo si era rivestito di un vivace piumaggio quasi palpabile: il cielo era proprio un tripudio di piume che parevano sfiorare le teste con una carezza e riempivano gran parte della volta celeste con tinte grigie, che si mescolavano alle più strane sfumature di violetto e malva, per arrivare anche a un rosa surreale e al verde pallido. A occidente la vista era addirittura indescrivibile: in un cielo terso e infuocato le ultime falde di quella livrea piumata erano d’un rosso incandescente e coprivano il sole, quasi fosse qualcosa di troppo bello per essere guardato. Questa scena celeste s’abbracciava stretta alla terra, come per trattenere un ardente segreto».
Quando, quella stessa sera ma qualche ora più tardi, Gabriel Syme sarà pienamente arruolato nella sua missione segreta di investigatore mandato tra gli anarchici, il cielo testimonierà che la battaglia col buio è cominciata. Tutto il tripudio di luce si tramuta in freddezza e oscurità innaturale:
«Quando Syme mise piede sul rimorchiatore ebbe la strana sensazione di inoltrarsi verso qualcosa di assolutamente nuovo; non semplicemente di trovarsi in un paese sconosciuto, ma di essere stato catapultato su un altro pianeta. Questo dipendeva dalla decisione folle eppure ferma presa nel corso di quella serata, ma anche dal completo stravolgimento del cielo e del clima da quando era entrato nel pub due ore prima. Ogni traccia di quel folto piumaggio di nubi che aveva avvolto il tramonto era scomparsa e ora la luna brillava limpidissima in un cielo altrettanto terso. La luna era così piena e splendente che (per un paradosso che si nota spesso) sembrava piuttosto un sole affievolito: non dava l’impressione di un lucente chiaro di luna, ma piuttosto di un giorno spento. Sull’intero paesaggio pesava una luce innaturale e sbiadita, quel crepuscolo apocalittico di cui parla Milton riferendosi all’eclissi solare; e quindi, fu spontaneo per Syme ritornare al suo primo pensiero, quello di essere finito su qualche pianeta desolato, che ruotava attorno a una malinconica stella. Ma più avvertiva la pungente desolazione di quel paesaggio illuminato dalla luna, più la sua follia cavalleresca ardeva come un fuoco nella notte. […] E così, in quel paesaggio disumano, c’era un briciolo di autentica immaginazione perché ne faceva parte un uomo davvero umano».
Questo è un pilastro fondamentale o, se vogliamo, cruciale: non ci sono scorciatoie o alternative. La battaglia che l’uomo deve combattere col buio è una lotta solitaria. Vedremo, poi, che l’uomo non è da solo a combattere, ma il primo grande passo che coraggiosamente bisogna fare è quello di sentire la solitudine desolante della lotta. Proprio come accadde a Giacobbe, nella sua lotta notturna con una presenza misteriosa:
«Così Giacobbe rimase solo e un uomo lottò con lui fino allo spuntar dell’alba. Quando quest’uomo vide che non lo poteva vincere, gli toccò la cavità dell’anca; e la cavità dell’anca di Giacobbe fu slogata, mentre quello lottava con lui. E quegli disse: «Lasciami andare, perché sta spuntando l’alba». Ma Giacobbe disse: «Non ti lascerò andare, se non mi avrai prima benedetto!». L’altro gli disse: «Qual è il tuo nome?». Egli rispose: «Giacobbe». Allora quegli disse: «Il tuo nome non sarà più Giacobbe, ma Israele, poiché tu hai lottato con DIO e con gli uomini, ed hai vinto». Giacobbe gli disse: «Ti prego, dimmi il tuo nome». Ma quello rispose: «Perché chiedi il mio nome?». E qui lo benedisse. Allora Giacobbe chiamò quel luogo Peniel, perché disse: «Ho visto Dio faccia a faccia, e la mia vita è stata risparmiata».
(Genesi, cap. 32)
Una benedizione attende l’uomo che, solo, affronta una battaglia nella notte. Si dice, peraltro, che con le sue ultime parole Chesterton ribadisse sul letto di morte che la battaglia costante e perenne dell’uomo è quella di scegliere la sua parte tra la luce e il buio.
Il compagno di scuola, e amico di una vita, Lucian Oldershaw disse di Chesterton, riguardo al tempo della sua crisi: «Sentivamo che stava cercando Dio» (cit. da Maisie Ward). E nel suo quaderno degli appunti, Gilbert descrisse, infatti, in forma simbolica la lotta/ricerca che stava facendo, tratteggiandola in modo alquanto simile alla vicenda di Giacobbe:
«È sera.
E nella stanza entra di nuovo un’immensa e indistinta presenza.
È un uomo o una donna?
È morto da tempo o è uno che deve ancora venire?
Ecco chi siede con me la sera».
E così, il tramonto lancia a Gabriel un ultimo infuocato messaggio, prima che scenda la notte della lotta. Ma anche dentro l’oscurità della notte non tutto è buio, finché ne fa parte un «uomo davvero umano». Per comprendere cosa significhi quest’affermazione, occorre rifarsi ancora una volta al quaderno degli appunti di Gilbert e sempre al periodo arduo della sua giovinezza. Stephen Medcalf, nell’edizione da lui curata de L’uomo che fu Giovedì, cita un breve passaggio dal diario di Gilbert, che pare una poesia e che lascia basiti quanto a radicalità di speranza e ragionevolezza:
It is not a question of Theology,
It is a question of whether,
Placed as a sentinel of an unknown watch,
You will whistle or not.
Traduzione:
Il punto non è la Teologia,
Il punto è se tu,
Messo di sentinella per un turno di guardia sconosciuto
Fischierai oppure no.
Qui, oso dire, c’è l’osso attorno a cui si salda il corpo del pensiero chestertoniano: GKC è stato un uomo che, partendo dalla tabula rasa, ha trovato, proprio nel buio del deserto del nulla, la radicalità della speranza connaturata nell’uomo. «Il punto non è la Teologia», ovvero: prova a ragionare a partire dal grado zero; immagina di essere catapultato nel peggiore dei mondi possibili, un pianeta alieno e desolato, come quello in cui si sente immerso Gabriel la notte in cui comincia la sua avventura. Ebbene, anche in un contesto di eclissi solare (cioè di assenza di riferimenti luminosi), l’uomo non smette di essere uomo. Fischia. Perfino se è messo di guardia nel contesto di una guerra a lui sconosciuta (in cui non si sa né chi è il nemico né chi è l’amico, ovvero la guerra di un dubbio radicale su tutto), l’uomo è quella creatura in grado di fischiare. È colui che manda segnali, è qualcuno la cui natura si esprime nella ricerca di un vincolo. Anche in un pianeta vuoto e desolato, l’uomo sarebbe l’unica cosa non vuota e desolata. Manderebbe segnali anche in un mondo in cui, regnando il caos e il nulla, non sarebbe possibile ricevere risposta.
Da questo grado zero, da questa pars destruens, Chesterton mette a fuoco la speranza, non più come idea positiva e astratta, ma come ragionevole presenza. Infatti: se tutto il mondo è solo un caotico coacervo che progressivamente tende al nulla, come può essere che ne faccia parte una creatura che – non per sua scelta, ma per natura – contraddice il caos e il nulla, essendo cosciente e capace di lanciare fischi interrogativi? Se il nulla e il caos sono la cifra dell’universo, perché dell’universo fa parte anche una sentinella?
La scoperta vitale che attende Gabriel Syme, in fondo a tutti gli scontri mortali che affronta nel romanzo, è proprio questa: giunto al limite estremo di ogni scontro, quando tutto sembra perduto e nient’altro che la morte pare attenderlo, ecco che la sentinella (che è in lui) ode un fischio di ritorno. Proprio quando è al fondo della desolazione, qualcosa di concreto, semplice e vivo lo ridesta, come mandandogli un fischio di vita. Capita una prima volta, quando Gabriel si trova al cospetto del gigantesco e imperscrutabile Presidente del Consiglio degli Anarchici, il cui nome è Domenica, e sa che la sua strada è giunta a un punto di non ritorno, non può più tirarsi indietro dalla sua impresa:
«Il momento della scelta decisiva era giunto, ora aveva la pistola alla tempia. […] Per strada fu azionato un organetto da cui si diffuse un motivetto allegro. I nervi di Syme si tesero, come se fosse stato lo squillo di tromba che prelude alla battaglia e sentì il suo animo invaso da un coraggio che proveniva da chissà dove. Gli pareva che quel tintinnante motivetto contenesse tutta la vivacità, la trivialità e l’inconcepibile valore della povera gente, quella che pur abitando in quelle vie sudicie si aggrappava a tutto ciò che di decoroso e caritatevole c’era in seno alla cristianità. […] Si sentiva l’ambasciatore della buona gente comune che passava per strada, di tutti quelli che affrontavano la propria quotidiana battaglia marciando al ritmo dell’organetto. E il grande orgoglio di appartenere a questa umanità lo aveva innalzato infinitamente al di sopra degli uomini mostruosi che lo circondavano».
Capita una seconda volta, quando Gabriel si scontra a duello con il più feroce degli anarchici, il Marchese di St. Eustache:
«Perché non appena vide il bagliore del sole correre lungo il filo della lama del suo rivale e non appena sentì quelle due lingue d’acciaio toccarsi e vibrare come fossero vive, si rese conto che il suo nemico era un avversario terribile e capì che probabilmente era arrivata la sua ora. Avvertì in modo stranamente vivido il valore di tutta la terra che lo circondava, anche dell’erba sotto i suoi piedi; sentiva l’amore alla vita che c’è in ogni cosa vivente».
Ecco il primo e gigantesco frutto buono di uno scontro all’ultimo sangue con l’anarchia: accorgersi che c’è una stella in più nella realtà, e non nella pozza della nostra mente. Il quid in più, e buono, è nella realtà. Perché – e questo è il grande rovesciamento – la realtà nel suo insieme, tragico e comico, non è altro che un fischio di risposta al fischio dell’uomo. Una chiamata. La realtà è una vocazione: dentro il reale c’è qualcosa che risponde all’uomo, e interagisce con quel bisogno di legame che l’uomo sente. E chi ha provato la vertigine di sentirsi una sentinella sperduta in un mondo desolato e alieno, diventa un testimone attendibile. Credibile, in nome del suo dolore.
O, meglio, questo è il frutto buono che ne ricavò GKC. Non fu sua intenzione lodare la solitudine titanica dell’uomo che lotta contro il buio, ma chiarire che anche la solitudine – dolorosa –, che ci accompagna nei momenti bui, serve.
Le prove e i dolori più laceranti, in cui ciascuno è chiamato a una battaglia solitaria terribile, hanno un senso; il senso di metterci a nudo completamente, di riconsegnarci un’innocenza radicale. Proprio quando non ci sono più speranze, l’uomo può guardarsi candidamente, senza filtri di ideologie e teorie, e decidere se il nulla ha l’ultima parola oppure no.
Per Chesterton la risposta è «oppure no».
Re Alfred, protagonista de La ballata del cavallo bianco, troverà il seme di questa innocenza proprio quando, sul campo di battaglia e di fronte a un nemico che lo sta per schiacciare, decide di dare il tutto per tutto, anche se il risultato sarà un sconfitta:
«Perché nella foresta densa di paure,
come una strana folata che giunge dal mare,
lo sospinse quell’antica innocenza
che è molto più della destrezza»
Non è un’innocenza candida quella che Chesterton trovò nel fondo cupo della sua crisi, ma un’innocenza segnata da ferite mortali. È quel genere di innocenza che rende coraggioso un soldato, pronto a sparare al vero nemico eterno che oscura le stelle, il Diavolo. Così, afferma Gabriel Syme alla fine della sua avventura:
«Ora capisco – gridò – capisco tutto. Perché ogni singola cosa sulla Terra fa guerra a tutte le altre? Perché ogni piccola cosa esistente al mondo deve combattere contro il mondo intero? […] Per lo stesso motivo per cui io dovevo sentirmi da solo in mezzo al tremendo Consiglio dei Giorni: e cioè affinché ogni cosa che obbedisce alla legge possa avere la gloria e la solitudine dell’anarchico, affinché ogni uomo che combatte in nome dell’ordine possa essere tanto impavido e devoto quanto un terrorista. Solo così la bugia di Satana può essere ritorta contro quella sua faccia da bugiardo, solo così noi possiamo guadagnarci il diritto, attraverso le lacrime e il sangue versato, di dirgli in faccia: “Tu menti!”».
Come a dire: «Tu menti, Satana. Tu dici menzogne: perché io – Gabriel Syme – anche al fondo della disperazione ho fischiato. Ho cercato un legame, e qualcosa mi ha risposto». Il compito del Diavolo è proprio quello di separare dai vincoli (dia-ballo), cioè di alterare la vista così che l’uomo dimentichi la sua stessa natura, quello di essere una sentinella … l’unica creatura vigile, l’unica creatura la cui stessa esistenza – persino in assoluta solitudine – è una lode al bisogno di un legame.
E a partire da ciò, l’uomo sopravvissuto alla discesa negli inferni – alive – comincia a guardare la realtà esistente e ogni altro essere umano come fratello e amico, come un compagno di battaglia.
3/ L’uomo che fu Giovedì, parte 3: sveglia!
«Questo non è il migliore dei mondi possibili, ma, tra tutte le cose possibili, la migliore è che il mondo sia possibile»
GKC
Scendere nei dettagli della trama de L’uomo che fu Giovedì è un atto di slealtà nei confronti dei futuri lettori. Perché un giallo va seguito passo dopo passo, e non c’è niente di peggio del tizio che salta su prematuramente a dire: “L’assassino è il maggiordomo!”. Perciò, per quanto possibile, cercherò di parlare per metafore, cioè cercherò di mettere a fuoco l’ultimo tassello della mia riflessione, senza esplicitare troppo gli elementi specifici della storia.
Giù la maschera! … oppure: W la mucca
Uno dei temi più sviscerati dalla letteratura novecentesca è stato il rapporto tra realtà e apparenza. Quel gigante di Pirandello ha sondato ogni meandro del rapporto dell’uomo con la sua identità, o meglio, col problema della sua identità: chi sono io? chi è l’altro?
Scelgo una citazione, tra le mille possibili, da Il piacere dell’onestà:
«Ecco veda, signor Marchese: inevitabilmente, noi ci costruiamo. Mi spiego. Io entro qua, e divento subito, di fronte a lei, quello che devo essere, quello che posso essere – mi costruisco – cioè, me le presento in una forma adatta alla relazione che debbo contrarre con lei. E lo stesso fa di sé anche lei che mi riceve. Ma, in fondo, dentro queste costruzioni nostre messe così di fronte, dietro le gelosie e le imposte, restano poi ben nascosti i pensieri nostri più segreti, i nostri più intimi sentimenti, tutto ciò che siamo per noi stessi [...]».
Chi parla è Angelo Baldovino, un pover’uomo che per denaro ha accettato di sposare Agata, rimasta incinta dal Marchese Colli, che non può sposarla perché già ammogliato. Il tema della maschera viene evocato in modo inappuntabile in queste parole, e Baldovino/Pirandello descrive benissimo qualcosa di concreto e vero, che tutti conosciamo. Nelle relazioni tra noi e gli altri c’è sempre un filtro, che poi si rifrange in una moltitudine di filtri: c’è l’immagine di me che io do agli altri, c’è l’immagine che gli altri si fanno di me; c’è l’immagine con cui gli altri si mostrano a me, c’è l’immagine che io mi faccio degli altri. Da questo punto di vista, ogni incontro umano potrebbe apparire solo un gioco di specchi, con l’implicazione che sia impossibile un contatto umano autentico.
Tutto ciò è una ferita bruciante. Gli autori, come Pirandello, che hanno documentato questa lacerata e imperfetta natura nei rapporti umani, hanno fatto sanguinare la ferita. Ed è un bene.
Anche Chesterton ci fece i conti, e vorrei quindi sollecitare gli insegnanti a tenere conto della sua voce nell’ambito della letteratura novecentesca, perché lui ci ha lasciato un contributo di valore, offrendoci un punto di osservazione che sconfigge l’ombra scura dell’apparenza e propone una via per ridare pieno valore di autorità alla realtà.
Mi spiego, Chesterton non ha risolto il problema della «maschera», ma ha proposto un modo coraggioso per affrontare con energica fiducia il tema dell’identità, affinché il dubbio non avesse l’ultima parola nel nostro rapporto col mondo e con gli altri. L’uomo che fu Giovedì, ne è una delle testimonianze più luminose. Fu scritto nel 1908, quando contemporaneamente Pirandello pubblicava L’umorismo; fu scritto, ci informa Stephen Medcalf, da un confronto con Joseph Conrad (in occasione di un pranzo presso un circolo culturale, GKC e Conrad discussero di un attentato dinamitardo avvenuto a Londra, e ciò diede lo spunto a Conrad per scrivere il celebre L’agente segreto, che uscì nel 1907, e a Chesterton per scrivere il Giovedì). Insomma, è un’opera pienamente collocata nel dibattito del suo tempo, eppure le storie della letteratura la ignorano.
Il tema della maschera, cioè dell’aspetto di sé che ciascuno offre agli altri e – forse – dietro cui ciascuno vuole celare se stesso, è uno degli elementi cardine dell’avventura di Gabriel Syme; lui stesso indosserà una maschera, cioè si fingerà un anarchico per sedere nel Grande Consiglio degli Anarchici. Fanno parte di questo consiglio sei Consiglieri e un Presidente; essendo in sette, ciascuno porta il nome di un giorno della settimana. Scrutando a uno a uno i Consiglieri, durante una colazione del consiglio, Gabriel (eletto a ricoprire il ruolo di Giovedì) ne resta atterrito. Ne è un esempio perfetto il Dottor Bull, che porta il nome di Sabato, e il cui volto pare un enigma terrificante:
«All’estremità del tavolo sedeva l’uomo chiamato Sabato, il più semplice e insieme il più sconcertante di tutti. […] Non c’era nulla di strano in lui, tranne il paio di occhiali scuri e opachi che portava. […] Lo sguardo di Syme era catturato da quegli occhiali neri e dalla smorfia cieca di quel viso. […]. Quelle lenti impedivano di comprendere il senso di quel volto, perché era impossibile dire cosa significassero quel sorriso e quell’austerità».
Non occorrono mirabolanti travestimenti, a volte basta un tocco di oscurità o un velo di opacità per renderci imperscrutabili agli occhi degli altri. Lo scontro con ciascuno di questi sei terribili Consiglieri porterà Gabriel a esasperare l’angoscia di sentirsi catapultato in un mondo di maschere, in un universo in cui non esistono criteri per distinguere un amico da un nemico. Un universo anarchico, appunto; e questo è un altro tassello dell’incubo. Per Gabriel l’ossessione del dubbio raggiunge il vertice nel momento in cui si trova a fuggire proprio da una folla di anarchici che lo inseguono col volto mascherato; la fuga lo porta ad attraversare un bosco – una selva oscura – in cui sprazzi di luci e ombre disorientano completamente la vista:
«Il fitto del bosco era pieno di sprazzi di luci improvvisi e ombre vibranti; tutto ciò diffondeva sulle cose un tremolio, che procurava una sorta di vertigine … . Per Syme era persino difficile distinguere le solide figure di chi gli camminava accanto, a causa di quel balletto di luci e ombre. […] E se tutti stavano indossando una maschera? Chi era cosa? … Dopo tutti questi stravolgimenti era propenso a chiedersi cosa distinguesse un amico da un nemico. Esisteva qualcosa oltre l’apparenza?»
Interrompo la citazione in corso per spiegarne il senso simbolico, usando le parole dello stesso Chesterton, il quale non si lasciò sfuggire un’occasione golosa che gli offrirà l’inglese, lingua in cui le parole amico (FRIEND) e nemico (FIEND) sono ancora più simili che in italiano. Spiega quindi GKC:
«In un incubo anche le facce degli amici (FRIENDS) possono apparire come facce di nemici (FIENDS). Ma c’è davvero del bene da scovare nei posti più improbabili e può accadere che chi si combatte a vicenda stia in realtà combattendo dalla stessa parte, quella giusta; ma è un bene che noi lo ignoriamo, perché l’anima deve sentirsi solitaria nella lotta o non ci sarebbe spazio per il coraggio».
Ecco qua il ribaltamento – paradossale – di cui l’intelligenza di Chesterton è stata capace: ci può essere un valore positivo nei mascheramenti reciproci degli esseri umani. Io non leggo candidamente nel cuore di chi mi sta accanto; questa «imperfetta» conoscenza concede al singolo di «sentirsi» solo nel momento della lotta, di non nascondersi dietro una facile compagnoneria. Ma poi, il senso anche vertiginoso e doloroso di questo confronto solitario, ha proprio lo scopo di farmi accorgere che, davvero, chiunque ho accanto a me – anche il nemico – è un amico. Perché tutti siamo sentinelle cooptate in questa battaglia di dare un nome al mistero del mondo. Con drammi diversi e persino opposti, perseguendo scopi divergenti, aderendo a ideali umani differenti, tutti – nel profondo – siamo dentro la stessa battaglia. Stiamo al cospetto del buio e cerchiamo quella lampada luminosa che possa far sparire le tenebre.
L’unico nemico reale e di ogni creatura è la menzogna diabolica della separazione, la tentazione di chiudere i ponti con il reale, di ergere la mente a idolo. È quella tentazione che il giovane Innocent Smith di Uomovivo sentiva quando era portato a credere che l’universo riflesso nella pozzanghera avesse una stella in più del cielo vero e proprio. E qui torno alla citazione, che riguarda Gabriel smarrito nel bosco e in preda a dubbi sull’esistenza di ogni cosa:
«In fondo, non era forse vero che tutto, come in quel bosco incantato, consisteva in una danza tra il buio e la luce? Ogni cosa è solo un bagliore, un bagliore che giunge sempre inaspettato e che sempre viene subito dimenticato. Ecco che Gabriel Syme aveva trovato nel fitto di quel bosco punteggiato di luce ciò che vi trovarono molti pittori moderni: era ciò che la gente moderna definisce Impressionismo, un altro nome per identificare quello scetticismo estremo, incapace di trovare le fondamenta dell’universo».
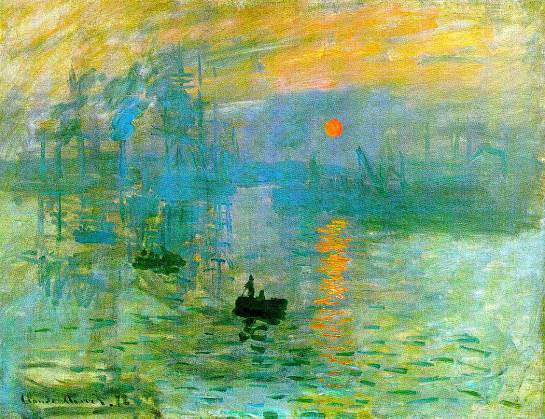
Claude Monet – Impression, soleil levant
Intendiamoci, qui Chesterton non sta scagliandosi contro Monet&Co, ma sta puntando il dito contro una pericolosa visione dell’umano e che egli traduce per immagini richiamandosi all’Impressionismo. Chesterton frequentò la scuola d’arte e rimase poi, in qualsiasi contesto di scrittura, una mente essenzialmente pittorica. Nella sua Autobiografia spiegò bene questo appunto critico nei confronti del presupposto teorico che muove l’artista impressionista:
«Penso tuttavia ci fosse qualcosa di spirituale nell’impressionismo, in rapporto con la sua epoca, che era l’epoca dello scetticismo. Intendo che raffigurava lo scetticismo nel suo aspetto soggettivo. Il suo principio era che, se di una mucca si vedeva una linea bianca e una sfumatura color porpora, bisognava ricreare la sfumatura, non la mucca. Era necessario credere nella linea e nella sfumatura, non nella mucca».
Lo scetticismo, quel dubbio radicale che è capace di portare la mente fino all’anarchia, può essere sconfitto solo in un modo: ascoltare il fischio che proviene dal reale, non lasciare che le voci delle mente coprano la voce del mondo reale. La sentinella messa alla prova fino all’estremo, Gabriel, ha sentito una voce semplice e concreta che proveniva dall’esserci delle cose. A quella voce bisogna dare credito. Ed è proprio quello che Gabriel fa in quel bosco oscuro: sentendosi pervaso dalle ombre del dubbio, costringe sé stesso a muoversi verso le persone che gli stanno vicino e «con due impazienti falcate» raggiunge l’ispettore Ratcliffe, che lo precede. Bisogna costringere lo sguardo a confrontarsi con la presenza delle cose, non con il loro riflesso inesistente creato dalla mente.
Se il primo passo è la lotta solitaria col buio, la seconda fase della lotta è non perdere il frutto buono dello scontro col buio: l’aver distintamente udito il fischio della realtà. E, in questa seconda parte della battaglia, che è la pars costruens, ci è compagno e amico chiunque si trovi accanto a noi, anche se ha l’aspetto di un nemico. Ed è amico perché la sua battaglia è, al fondo, la nostra stessa. Ne è un altro esempio la condotta di Innocent Smith, il quale non decide in solitudine, rimuginando, se l’orizzonte del nichilismo è l’ultima parola sul mondo, ma lo verifica coinvolgendo il Professor Eams; cioè catapultandosi nella realtà del rapporto con quell’uomo (che pure è suo avversario). Se il Professore sarà disposto a morire, per dimostrare che la vita dell’uomo è nulla, allora anche Innocent si darà la morte. Ma, alla prova dei fatti, il confronto reale tra Eams e la morte dimostra ciò che anche Gabriel Syme ha scoperto, cioè che l’uomo – quando sta nudo di fronte all’esistenza – è una sentinella: ode una voce buona che proviene da ciò che esiste. La mucca c’è davvero e muggisce. Il Professor Eams avendo una pistola puntata alla tempia, improvvisamente si accorge della realtà e che l’esistente lo interpella:
«Mentre parlava spuntò il sole. E sembrò che infondesse il colore su ogni cosa, con la rapidità di un fulmineo artista volante. Una flottiglia di piccole nubi che navigava nel cielo mutò di colore passando dal grigio tortora al rosa. […] Attraverso un piccolo scorcio che si apriva tra una vecchia taverna di legno e l’imponente massa grigia del College, [il Professor Eams] poteva vedere un orologio dalle lancette dorate che il sole aveva incendiato di luce. Lo fissò ipnotizzato e d’improvviso l’orologio si mise a battere l’ora, come volesse rispondergli».
Per svegliarsi da un incubo bisogna cacciare un urlo, bisogna essere capaci di un gesto concreto e violento per aprire gli occhi. Le ombre sono solo ombre mute, mentre la luce del sole ci parla. E poiché il tempo di vita che ci è concesso sarà sempre un costante destreggiarsi tra buio e luce, è bene armarsi e trovare alleati valorosi.
Uscendo dalle tenebre del proprio incubo giovanile, Chesterton gridò a voce alta e in piena coscienza: Evviva! Perché la realtà è viva. Ed è un miracolo. Poi passò il resto del tempo che trascorse su questa terra a lasciare ai suoi lettori testimonianze autentiche e ragionevoli della verità di queste parole scritte ne L’uomo che fu Giovedì:
«Il male è così malvagio da farci pensare che il bene sia solo un caso; ma il bene è così buono da darci la certezza che dev’esserci una spiegazione per il male».



