Andrea Lonardo presenta le basiliche di San Pietro, di San Paolo fuori le Mura, di San Giovanni in Laterano, di Santa Croce in Gerusalemme, di San Lorenzo fuori le Mura, di San Sebastiano con le catacombe, la Chiesa Nuova, la chiesa della SS. Trinità dei Monti con la cappella della Mater admirabilis nella quale pregò Santa Teresa di Lisieux, Santa Maria della Vittoria con l’estasi di Santa Teresa d’Avila, Santa Brigida, Santa Cecilia (nel ricordo di Santa Ildegarda di Bingen benedettina), Sant’Ivo alla Sapienza (nel ricordo di Santa Edith Stein), Santa Maria sopra Minerva (nel ricordo di Santa Caterina da Siena), Santa Maria degli Angeli e dei Martiri, la Chiesa del Martirio di San Paolo, l’Ara Coeli (come luogo di riferimento anche per l’Unione Europea), la Basilica di San Clemente, la Chiesa del Gesù
Riprendiamo sul nostro sito le presentazioni di alcune fra le basiliche e chiese romane preparate da Andrea Lonardo in occasione del Giubileo 2025, per i libretti messi a disposizione nelle varie basiliche e chiese dal Dicastero per l’Evangelizzazione. Della basilica di San Giovanni in Laterano sono messi anche a disposizione i testi preparati da Andrea Lonardo per il sito web della stessa basilica. Restiamo a disposizione per l’immediata rimozione se la sua presenza non fosse gradita a qualcuno degli aventi diritto. I neretti sono nostri ed hanno l’unico scopo di facilitare la lettura on-line. Per ulteriori testi, cfr. le sezioni Roma e le sue basiliche e Arte e fede.
Il Centro culturale Gli scritti (18/5/2025)
N.B. Le basiliche e chiese qui presentate sono disposte secondo il quadruplice itinerario proposto dal Dicastero per l’evangelizzazione (a/ Il pellegrinaggio alle quattro basiliche e alle sette chiese b/ L’Europa a Roma c/ Donne patrone d’Europa e Dottori della Chiesa d/ Chiese giubilari). Per ovvie ragioni, sono messi a disposizione solo i testi preparati da Andrea Lonardo, quindi mancano altre chiese preparate da altri autori.
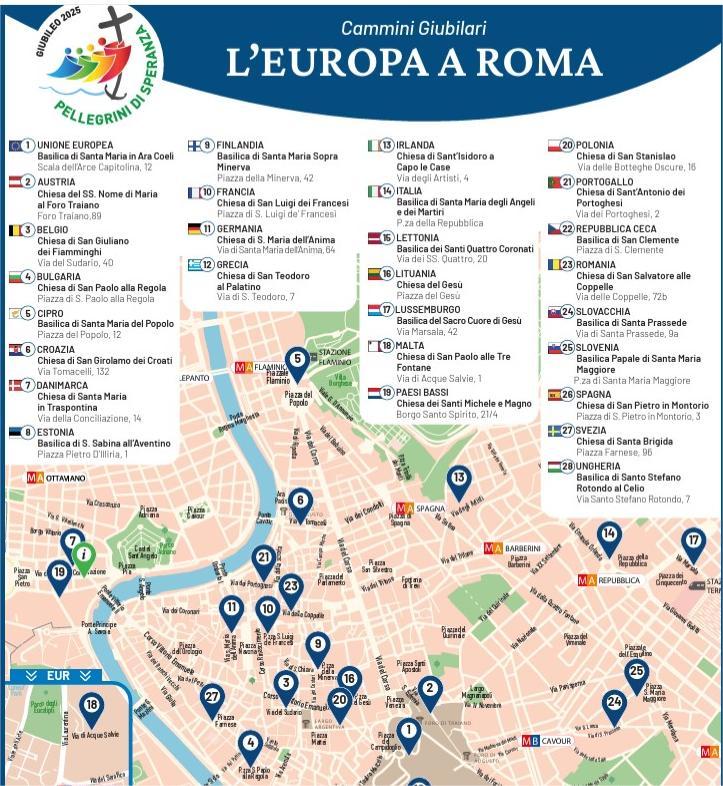
a/ Il pellegrinaggio alle quattro basiliche e alle sette chiese
1/ La basilica di San Pietro
1/ Motivi di un pellegrinaggio giubilare
Alcuni oggi contestano la Chiesa, affermando che i cristiani di questo tempo sono lontani da Gesù. Ma la critica si spinge fino alle origini: sarebbero già stati Pietro e gli apostoli a tradire il maestro, che non avrebbe avuto l’intenzione di far nascere la Chiesa stessa.
Già il nome di Pietro ci fa comprendere che così non è. Né il nome aramaico Cefa, né il corrispettivo greco Petros, erano nomi propri di persona ai tempi di Gesù. Fu Gesù a dare a Simone, suo apostolo, il nome di Cefa/Pietro, segno che intendeva la nascita di una “costruzione”, della sua Chiesa: “Tu sei Pietro e su questa pietra edificherò la mia chiesa”.
Anche il numero dei “dodici” apostoli indica tale intenzione del Cristo. Prima dei dodici figli di Giacobbe, c’erano stati i patriarchi Abramo e Isacco, ma solo con quei dodici figli nasce il “popolo” di Israele. Gesù, chiamando i Dodici, volle indicare che la nascita del “popolo di Dio” si stava realizzando in pienezza.
Pietro, dopo un lungo peregrinare di cui non è dato cogliere con sicurezza tutte le tappe, giunse a Roma. Nell’urbe venne martirizzato. Non vi è dubbio alcuno su questo, sia perché tutte le fonti antiche ricordano la sua morte a Roma, sia perché nessun’altra chiesa antica vanta di aver posseduto le sue reliquie.
Come a Nazareth o a Gerusalemme si dice “Hic”, “Qui”, “Qui è avvenuta l’Annunciazione, qui la morte e la resurrezione”, altrettanto si dice di Roma: “Qui Pietro è stato martirizzato”.
È questo che fa di Roma una città il cui destino è cambiato per sempre. Se Pietro fosse stato ucciso in un’altra città quel luogo sarebbe divenuto la sede del vescovo successore del primo degli apostoli e Roma sarebbe stata una città diversa.
Roma, invece, è la sede del successore di Pietro e la presenza del papa è il segno più evidente che proprio qui egli sia stato ucciso.
È un’elezione divina, perché non esiste solo una storia della salvezza, ma anche una geografia della salvezza che ha tappe e luoghi precisi. Sarebbe banale affermare che il ruolo particolare di Roma per la Chiesa sia stato dato semplicemente dal fatto che l’urbe fosse allora la capitale dell’impero: no, il disegno di Dio è “misterioso”, così come non è possibile spiegare precisamente perché proprio quella persona debba essere la moglie di quell’uomo o quel ragazzo debba divenire sacerdote. Ogni elezione ha un “mistero” che è nel segreto di Dio, ma di cui noi possiamo contemplare gli effetti, perché quella persona e quei luoghi sono stati scelti per noi.
Roma deve la sua identità certamente al suo passato classico ed è città modernissima perché mostra come siano transeunti i poteri e le ideologie: lo splendore di Roma divenne poi decadenza e di quel potere restano solo pietre ed è per questo che Roma ricorda al mondo come ogni potere storico sia destinato a scomparire nel corso dei secoli e dei millenni.
Ma Roma deve la sua identità alla presenza di Pietro e Paolo che rinnovarono la primitiva fondazione della città ad opera di Romolo e Remo. Alla cultura classica si aggiunse la memoria cristiana e la città è, da allora, la sede del successore di Pietro.
Per questo si giunge a Roma e alla tomba di Pietro per confessare la fede. Per avere conferma che la nostra fede è quella della Chiesa. Da sempre la professione del Credo risuona dinanzi alla sua tomba, per confessare che Gesù è il volto di Dio e che perciò Dio è amore – è la novità dell’annunzio cristiano.
Pietro e Roma attestano ad ogni uomo, che in ogni tempo e in ogni luogo ha cercato di "vedere” il volto di Dio, che chi conosce l’amore di Cristo conosce l’amore di Dio, chi vede il Cristo vede Dio.
Prima dell’Incarnazione sembrava che di Dio fosse possibile avere solamente una vaga idea. I grandi uomini religiosi avevano sempre affermato che Dio era troppo grande per essere conosciuto dagli uomini. Alcuni avevano creduto che Dio avrebbe potuto inviare all’umanità un qualche suo scritto con i suoi comandamenti, ma non che Egli potesse chiamarci amici e farsi conoscere come solo un amico è conosciuto dai suoi amici.
Pietro confessò, invece, a Cesarea di Filippo che Gesù era il Cristo - colui che Dio aveva promesso -, e il Figlio di Dio - colui nel cui volto era possibile vedere finalmente chi Dio fosse. Questa stessa fede Pietro confessò a Roma con il martirio.
Si giunge in pellegrinaggio alla tomba di Pietro perché si riconosce che solo dalla sua predicazione e da quella della Chiesa apostolica è risuonato nel mondo il grido: «Dio è amore».
Per questo e a ragione, l'iconografia, per rappresentare il ruolo di Pietro nella storia, ha scelto il simbolo delle chiavi, a partire dalle parole del Signore: «A te darò le chiavi del regno dei cieli: tutto ciò che legherai sulla terra sarà legato nei cieli, e tutto ciò che scioglierai sulla terra sarà sciolto nei cieli» (Mt 16,19).
Due sole chiavi, una per “aprire” e l’altra per “chiudere”. Per aprire alla vera come per chiudere ad idoli che pretendessero di proporsi come vero Dio.
Ecco il ruolo del magistero petrino: confermare chi confessa che Dio è amore e che ha l’autorità di donare la resurrezione e, d’altro canto, sconfessare chi pretenda che Dio sia violenza o impotenza.
Ma le chiavi dicono anche che è stato dato agli uomini in terra il potere di perdonare e che tale perdono dato dalla Chiesa vale anche in cielo.
Le chiavi affidate a Pietro dicono così che egli deve custodire la memoria del vero volto di Dio rivelateci dal Cristo, perché nessuno si permetta di snaturarlo. Ma, poiché quel volto è amore e misericordia, a Pietro è affidata anche la missione di manifestare con il perdono che Dio è amore: Pietro e i suoi successori debbono assolvere i peccati, essendo state loro affidate le chiavi della riammissione nella piena comunione con Dio e con la Chiesa.
Le chiavi petrine spalancano insomma sia la porta della verità che la porta del perdono e, insieme, denunciano le false immagini di Dio e i peccati che offendono l'uomo. Dio è agape e logos (i due termini usati dall'evangelista Giovanni per annunciarci il Cristo), Dio è amore e verità. Se si eliminasse l'amore, la fede diverrebbe una fredda professione nella mera esistenza di Dio. Se si eliminasse la verità, l'amore non sarebbe il cuore dell'universo, ma solo un’illusione romantica destinata ad essere smentita dalla vita.
Pietro è, invece, lì a dirci che Dio ci ha rivelato la chiave della vita, la verità del suo amore.
2/ Visitando la basilica
L’ingresso alla basilica è preceduto dal colonnato che venne commissionato al Bernini. La pianta del colonnato è ottenuta tramite due circonferenze vicine che passano rispettivamente ognuna per il centro dell'altra. La forma vuole esprimere l'abbraccio della Chiesa a tutti coloro che si riuniscono in piazza San Pietro e, idealmente, tale abbraccio è rivolto al mondo intero.
Alcuni schizzi a matita, forse di un discepolo del Bernini, disegnano il colonnato come se fosse formato da due braccia e la basilica come se fosse il capo, manifestando con quale simbologia lo progettò il grande architetto barocco.
Tale significato è riconosciuto da studiosi moderni come Paolo Portoghesi, che sottolinea «il diretto, felice, riferimento allegorico al gesto accogliente delle braccia, che dà a quest'immagine un'apertura comunicativa, costituendo la testimonianza maggiore delle qualità di Bernini come architetto, rivelando una profonda adesione di fede agli ideali rappresentati».
Gli interstizi fra le colonne vogliono, infatti, dare l’idea di uno spazio delimitato, ma insieme aperto. La piazza ha una sua precisa funzione e non venne per questo mai considerata un'opera eccessiva, bensì un dono alla città di Roma: in essa si raduna il popolo di Dio all'elezione del nuovo pontefice, ma anche ogni volta che i fedeli si raccolgono in preghiera con il loro vescovo o per ascoltare la sua parola. Senza quella piazza sarebbe impossibile a tanti pellegrini vedere il papa che si affaccia alla finestra per benedirli. Papa Francesco ha voluto anche che sotto il colonnato sorgessero servizi per l'accoglienza dei senza fissa dimora.
Dalla piazza è ben visibile, alla destra della basilica, la sagoma della Cappella Sistina sulla quale viene eretto, all’occasione, il comignolo delle fumate. Quando un nuovo papa viene eletto, da quel camino si sprigiona il fumo bianco e tutti possono così sapere che in breve tempo il nuovo pontefice si affaccerà dal balcone che è al di sopra del portone centrale della basilica.
Al centro della piazza si erge l’antico obelisco del Circo di Nerone: esattamente in quel circo Pietro e i protomartiri romani dettero testimonianza del Vangelo con la loro vita. È possibile immaginare i loro ultimi momenti di vita, proprio dinanzi a quel monumento, quando morirono pregando per i loro persecutori.
Sul lato destro della piazza, poco prima del punto di aggancio fra il colonnato e la basilica, una piccola lapide a terra ricorda il luogo dove Giovanni Paolo II venne ferito in un attentato e protetto dalla Vergine.
Furono gli uomini del Rinascimento a decidere la ricostruzione della basilica costantiniana, ma la facciata porta, come il colonnato, un'impronta barocca, perché i lavori si protrassero a lungo: l’antica facciata costantiniana fu abbattuta solo a partire dal 1605 per permettere al Maderno di concludere la nuova basilica con il prolungamento delle navate. L’originario progetto di Michelangelo prevedeva, invece, una chiesa a croce greca, con una cupola ben visibile: in questo modo anch’egli, in maniera diversa dal definitivo progetto barocco, ma con lo stesso significato, intendeva realizzare un luogo aperto verso il mondo, in ogni direzione. Di Michelangelo è tuttora visibile il bellissimo tamburo della cupola che anche dall'esterno indica il luogo preciso della tomba di Pietro, mentre nell'interno gli arconi intorno all'altare mostrano ancora il disegno del Bramante.
Nel portico si aprono cinque porte. Quella di destra è la Porta santa. Alla sua sinistra è affissa una riproduzione della Bolla con la quale Bonifacio VIII indisse il primo Giubileo, quello del 1300.
La Porta centrale è l'unica che sopravvive dell'antica basilica: venne realizzata dal Filarete tra il 1439 e il 1445. Nelle sue ante, oltre al Cristo e alla Vergine, oltre a San Paolo e a San Pietro con il loro martino, è rappresentato il patriarca armeno, giunto in Italia per il Concilio di Ferrara-Firenze, segno del perenne desiderio di unità della Chiesa, poiché il papato non esclude il collegio dei vescovi, anzi necessita di esso, così come i vescovi del suo ministero. Un'ulteriore lapide ricorda la revoca delle scomuniche fra Roma e Costantinopoli.
All'estrema sinistra vi è la Porta del giudizio, detta anche "Porta della morte", opera del 1964 di Giacomo Manzù. In essa sono rappresentati i diversi modi con cui la morte ghermisce gli animali e gli uomini, ma tutto è come illuminato dai due pannelli più grandi con la morte di Cristo, deposto dalla croce, e quella di Maria che, appena morta, viene assunta in cielo, per non conoscere la corruzione del sepolcro. Un tralcio di vite e delle spighe recise mostrano le realtà terrene che, offerte e consacrate, divengono il pane e la bevanda della vita eterna.
Nel portico, di fronte all'ingresso centrale, si trova il monumentale mosaico della Navicella, che rappresenta la Chiesa in balia della tempesta: è il rifacimento seicentesco dell'originale di Giotto che era posto sulla facciata interna del grande quadriportico antistante la basilica costantiniana e abbattuto a partire dal 1605. È certo che Giotto fosse a Roma in occasione del Giubileo del 1300, anche se, secondo diversi studiosi, il mosaico gli venne commissionato dopo la partenza dei papi per Avignone. Dato il contesto storico, è ancor più evidente che l'immagine intendesse evocare il cammino tempestoso della Chiesa e insieme la guida provvidenziale a opera di Cristo. Santa Caterina da Siena, proclamata da Giovanni Paolo II compatrona d'Europa, dopo essersi recata ogni mattino a pregare sulla "fenestrella" che permetteva allora di guardare alla tomba di Pietro, sostava in preghiera, raccontano le fonti, proprio davanti al mosaico giottesco, per pregare per il ritorno del papa da Avignone a Roma.
Appena entrati in basilica, sulla destra, si trova la Cappella che conserva la Pietà di Michelangelo, la prima delle tre da lui realizzate. La scolpì giovanissimo, ancora ventitreenne, nel 1498. Il corpo del Cristo nudo visualizza la concretezza della sua Incarnazione e della sua morte. L'iconografia di Maria è inusuale, più giovane del suo stesso Figlio. Maria è, come disse Dante, la «Vergine Madre, figlia del suo Figlio».
Come la piazza, anche l'ampiezza della basilica è funzionale alla vita della Chiesa. Non è, insomma, una grandezza fine a sé stessa: lo si comprende bene immaginando lo svolgimento del Concilio Vaticano II proprio nella navata centrale di San Pietro. Per quell’occasione i banchi vennero posti ai due lati della navata centrale ed è bello immaginare i circa 3000 vescovi che dal 1962 al 1965 si sedettero lì per ascoltare il soffio dello Spirito. Alcuni banchi del Vaticano II sono utilizzati ancora nella vicina chiesa dei Santi Michele e Magno, dove sono stati trasferiti.
Anche il Concilio Vaticano I porta tale nome perché si svolse in basilica, ma con un numero infinitamente minore di partecipanti. Spesso si visitano le grandi basiliche quando sono vuote o sono affollate solo di turisti e si dimentica che nelle grandi liturgie delle feste, come in quelle delle ordinazioni sacerdotali, esse sono addirittura incapaci di contenere le tante persone che vorrebbero partecipare.
Le quattro Costituzioni conciliari scritte dai padri conciliari permisero di rileggere la fede della Chiesa secondo una rinnovata visione che andava al cuore della persona del Cristo. Nella Dei Verbum,che tratta della rivelazione, i padri conciliari vollero sottolineare che Dio si rivela in persona e che Gesù è la Parola di Dio, proprio perché il cristianesimo non è una religione del Libro: la Parola di Dio “precede ed eccede la Scrittura”, come ha detto papa Francesco.
La Sacrosanctum Concilium, che affronta il tema della liturgia, afferma analogamente che nella liturgia è Cristo stesso che continua ad essere presente, è Lui che dona sé stesso e la Chiesa celebra come suo corpo vivente.
La Lumen gentium tratta, invece, della Chiesa vivente è mostra come essa sia il segno e il sacramento dell’unione con Dio, suo popolo eletto – la dimensione popolare della Chiesa è stata posta in evidenza in maniera peculiare da papa Francesco, per annunciare che essa non è fatta solo da una ristretta cerchia intellettuale, bensì dalla gente comune - la “classe media della santità”, come ha più volte ricordato.
La Gaudium et spes si rivolge alla missione della Chiesa nel mondo e parte anch’essa dallo sguardo assolutamente nuovo sulla persona offerta dalla rivelazione: è l’uomo, ogni uomo, ad essere creato a immagine e somiglianza di Dio e per questo dotato di dignità incancellabile. La Gaudium et spes intende ricordare il ruolo proprio dei laici chiamati ad animare la realtà temporale e quindi a condividere il cammino della storia con tutti gli uomini, senza rimanere rinchiusi in prospettive autoreferenziali.
Nella navata centrale della basilica, sulla destra, si trova la statua bronzea di San Pietro, la cui vetustà è visibile a tutti, nel particolare conosciutissimo del piede consumato dalla devozione dei fedeli. Un'energia affiora sotto la durezza del bronzo: il braccio destro si solleva solennemente, mentre l'altro braccio stringe le chiavi con estrema fermezza. La storia critica dell'opera è assai tormentata, segnata da due ipotesi che hanno sempre diviso gli studiosi: la prima è quella di un'origine tardo-antica (IV-VI sec.), la seconda di un'esecuzione di età gotica, databile intorno al XIII secolo: oggi si propende per un’origine medioevale con un artista, però, che scelse volutamente di ispirarsi al mondo classico.
La cupola segna il fulcro della basilica, con l'altare detto della Confessione, che sorge esattamente sulla verticale della tomba di Pietro. "Confessione" significa testimonianza, professione di fede. È l'altare che sorge sulla professione di fede di Pietro, resa a Cesarea di Filippo con le parole «Tu sei il Cristo, il Figlio del Dio vivente» e resa poi a Roma con il martirio.
Urbano VIII nel 1624 incaricò il Bernini di erigere un grande baldacchino sopra questo altare, a sottolineare la centralità della celebrazione eucaristica secondo il dettato tridentino: fu la prima commissione affidata all'artista per San Pietro, cui seguiranno poi il colonnato e infine la Cattedra. Il risultato finale offre una tale illusione di leggerezza da far sembrare incredibile la quantità di bronzo impiegata nell'opera: assurdo è che dinanzi ad una tale meraviglia taluni studiosi si limitino a ricordare il detto scritto per dileggiare i Barberini paragonandoli ai barbari.
Calvesi ne ha, invece, scritto da vero storico dell’arte: «Al ciborio e al tabernacolo tradizionali, strutture architettoniche fisse, Bernini sostituisce l'idea di un baldacchino concepito come se fosse fatto di legno o di stoffa, cioè come un elemento trasportabile e mobile. Questo grande dispositivo non è eretto, ma posato sulla tomba dell'Apostolo: ha l'aria di essere stato trasportato a braccia e lasciato lì al termine di un'immaginaria processione».
Il baldacchino cela anche i simboli dei sacramenti del battesimo e dell'eucaristia. Sui quattro basamenti di marmo si possono vedere le fasi di un parto, in un divertissement barocco: sette volti di donna che esprimono la progressione delle doglie fino all'ultima figura, quella di un bambino appena nato, sorridente.
La vigorosa torsione delle quattro colonne vuole invece richiamare non solo le antiche colonne erette in quella foggia da Gregorio Magno, ma anche i tralci della vite, come simbolo eucaristico.
Nell'abside è posta la Cattedra di San Pietro, grandiosa "macchina devozionale" opera del Bernini, realizzata tra il 1656 e il 1666, circa trent'anni dopo il baldacchino. L'opera è un gigantesco reliquiario, che conteneva al suo interno un antico trono, sul quale la tradizione voleva si fosse assiso il Principe degli Apostoli - oggi nel Museo della basilica stessa.
Il reliquiario è sorretto da quattro monumentali statue raffiguranti due dottori della Chiesa latina - sant'Agostino e sant'Ambrogio - e due della Chiesa greca – san Giovanni Crisostomo e sant'Atanasio -, a simboleggiare l'unità della fede e il suo radicamento nella Tradizione.
La Cattedra e il ministero papale sono illuminati dalla manifestazione dello Spirito Santo rappresentato, in forma di colomba, al centro della vetrata di alabastro.
Il grandioso reliquiario va apprezzato anche nella prospettiva del baldacchino. Non è un caso che uno studio autografo del Bernini mostri la Cattedra vista attraverso le colonne del baldacchino, rivelando così come l'artista guardasse ai due monumenti come a un tutto unico.
Le spoglie dei pontefici canonizzati vengono traslate nella basilica ed è così che si trovano gli altari con i corpi di san Giovanni XXIII, di san Paolo VI e di san Giovanni Paolo II.
Scendendo alle Grotte Vaticane si giunge invece alle altre sepolture dei papi che non sono in basilica e, soprattutto, si può giungere al luogo più prossimo alla tomba dell'Apostolo Pietro. È possibile pregare proprio dinanzi al luogo della sua sepoltura indicata dalla Nicchia dei Palli, corrispondente moderno del "trofeo di Gaio", prima solennizzazione del luogo della sepoltura di Pietro. È infine possibile visitare la Necropoli Vaticana, sotto la basilica, per giungere fino alla tomba di Pietro. Bisogna però prenotare previamente la visita presso l'Ufficio Scavi, a cui si accede dall'Arco delle Campane.
Dopo aver attraversato le fondamenta della basilica costantiniana, che sono ancora visibili, si percorre l'antico viottolo pre-costantiniano, fiancheggiato a destra e a sinistra da mausolei sepolcrali pagani, con sarcofagi e resti di mosaici e affreschi. Alcuni mausolei rivelano già una presenza cristiana, come quello di Valerius Hemna, in cui compare una lapide con il monogramma di Cristo, e il mausoleo detto del «Cristo Sole», nella cui volta figura Cristo trainato da cavalli bianchi, come sole che sorge ad illuminare l'umanità.
Alla fine del viottolo si ascende il piccolo clivo che conduceva al "campo P", un tempo all’aperto, dove si intravede ancora una delle due colonnine del "trofeo di Gaio".
Il luogo del martirio di Pietro
Esiste una testimonianza dettagliata della persecuzione che portò Pietro al martirio, anche se il suo nome non figura perché non era conosciuto allo storico che la redasse. Tacito, infatti, descrive il rapporto fra pagani e cristiani, negli anni dell'imperatore Nerone, e la prima grande persecuzione contro i cristiani da lui scatenata. Il luogo esatto del martirio, indicato da Tacito, è il circo neroniano che sorgeva a fianco del colle Vaticano.
Nell'anno 64 d.C. si sviluppò un vasto incendio a partire da alcune botteghe site nella zona del Circo Massimo. L'incendio divampò per tutta la città e ne fece scempio per nove giorni. Quando si placò, Roma aveva cambiato volto e grande fu la disperazione fra i superstiti. Nerone, che si trovava ad Anzio, rientrò in città e si adoperò per organizzare i soccorsi. Nella sua mente prese corpo l'idea di una Roma nuova. Questa sensazione non sfuggì al popolo, presso cui cominciò a serpeggiare la voce che l'incendio fosse stato voluto da Nerone stesso per intraprendere il suo megalomane piano di ricostruzione. La Domus Aurea, residenza imperiale neroniana sul Colle Oppio, venne, difatti, costruita requisendo terreni sui quali era divampato l'incendio - saranno poi i Flavi a restituire alla popolazione romana la zona e, dove Nerone aveva creato un lago artificiale per i propri giardini, essi invece costruiranno il Colosseo, con i beni predati al Tempio di Gerusalemme. Nerone, per placare il malumore, trovò il capro espiatorio cui addossare le colpe: la comunità dei cristiani.
Questo il racconto di Tacito, negli Annali: «Nerone inventò i colpevoli e sottopose a raffinatissime pene quelli che il popolo chiamava cristiani [...] Il loro nome veniva da Cristo, che sotto il regno di Tiberio era stato condotto al supplizio per ordine del procuratore Ponzio Pilato [...] Ne fu arrestata una gran moltitudine [...] Quelli che andavano a morire erano anche esposti alle beffe: coperti di pelli ferine, morivano dilaniati dai cani, oppure erano crocifissi, o arsi vivi a mo' di torce che servivano ad illuminare le tenebre quando il sole era tramontato. Nerone aveva offerto i suoi giardini per godere di tale spettacolo, mentre egli bandiva i giochi nel circo ed in veste di auriga si mescolava al popolo, o stava ritto sul cocchio. Perciò, per quanto quei supplizi fossero contro gente colpevole e che meritava tali originali tormenti, pure si generava verso di loro un senso di pietà, perché erano sacrificati non al comune vantaggio, ma alla crudeltà di un principe».
Teatro del cruento spettacolo fu il Circo di Gaio e Nerone nella zona del Vaticano. Il Circo era situato dove oggi sorgono l'Arco delle Campane, la piazza di Santa Marta e le navate di sinistra della basilica di San Pietro. A metà della «spina», cioè del muretto che divideva le due parti della pista, sorgeva l'obelisco portato da Caligola dall'Egitto, l'unico resto dell'antico circo che è possibile ancora vedere. L'obelisco non è però più nella sua posizione originaria, ma venne spostato in avanti, dinanzi alla basilica, nel 1586, prima ancora che venisse eretto il colonnato del Bernini. Gli altri resti della costruzione neroniana sono sepolti sotto gli attuali edifici.
Una tradizione vuole che Pietro sia stato crocifisso a testa in giù per sua stessa richiesta, al fine di dimostrare, anche in punto di morte, la propria piccolezza rispetto al Signore.
A lato del Circo correva la via Cornelia, che partiva all'altezza di Castel Sant'Angelo e saliva poi sul colle Vaticano. Lungo la via, sul lato destro, sorgeva un sepolcreto a cielo aperto. Fra le tombe allineate qualcuno seppellì il corpo di Pietro in un'umile tomba a terra.
Nel calendario liturgico romano la memoria dei protomartiri romani, celebrata il 30 giugno, segue di un giorno la solennità dei santi Pietro e Paolo, che cade il 29 giugno. La Chiesa unisce così al martirio di Pietro e Paolo i martiri romani, uccisi insieme da Nerone. Fu la Chiesa di Roma stretta intorno a Pietro che testimoniò con la vita la speranza riposta nel Signore.
La tomba di Pietro
La storia del ritrovamento della tomba di Pietro prende l'avvio nel 1939, quando, in seguito all'elezione di Pio XII, vennero intrapresi nelle Grotte Vaticane i lavori per la sistemazione del sepolcro del suo predecessore Pio XI. Fu portata alla luce una vera e propria necropoli, certamente in uso fino al IV secolo d.C., quando l'imperatore Costantino livellò il sepolcreto per edificare la basilica di San Pietro. L'area più importante di questa necropoli è un piccolo spiazzo denominato «campo P».
Esattamente in verticale, sotto l'altare maggiore dell'attuale basilica, su di un lato di questo spiazzo, si trova un'umile tomba a terra, la tomba di Pietro.
Tutti gli interventi successivi lasciarono illesa, anzi protessero, quell'umile tomba. Dagli scavi risulta infatti che, quando intorno all’anno 160 nella zona del Vaticano cominciarono a moltiplicarsi i mausolei sepolcrali, l'area della tomba di Pietro venne delimitata con un muro, che fu intonacato di color rosso (ragione per cui gli archeologi lo hanno poi chiamato «muro rosso»). Tale muro, però, fu costruito in modo da rispettare la sepoltura, attraverso una piccola nicchia. Per la precisione, nel punto esatto della tomba, venne eretta una piccola edicola, con due colonnine, per renderla più riconoscibile.
La più antica testimonianza letteraria della sepoltura di San Pietro al Vaticano è riportata nella Storia Ecclesiastica di Eusebio di Cesarea, teologo e storico, elogiatore dell'imperatore Costantino. Eusebio cita uno scritto di «un uomo della Chiesa di nome Gaio», vissuto a Roma al tempo del vescovo Zefirino [cioè tra il 199 e il 217], che si trovò in polemica con Proclo, capo della comunità montanista di Roma, il quale, dovendo provare l'autenticità delle tradizioni apostoliche dei cristiani di Roma, scrive: «Io ti posso mostrare i trofei degli apostoli. Se andrai al Vaticano o sulla via Ostiense, vi troverai i trofei dei fondatori della Chiesa».
L'edicola ritrovata dagli archeologi è stata allora chiamata «trofeo di Gaio» a partire dalla testimonianza di Eusebio: un trofeo (tropaion) che ricorda sì una vittoria, ma quella ultima sulla morte ottenuta attraverso il martirio, a indicare che i sepolcri degli apostoli sono anche e soprattutto monumenti di vittoria. La testimonianza di Gaio, confermata dagli scavi, dimostra che, intorno al 200, i cristiani di Roma conoscevano bene l'ubicazione del sepolcro: era trascorso troppo poco tempo dal martirio perché se ne potesse perdere la memoria.
Nel 250 circa intervenne un nuovo cambiamento: l'innalzamento di un muro, detto il «muro G», immediatamente a destra dell'edicola. Pur non essendo chiaro il motivo della costruzione, è certo che essa entrò subito in relazione con il culto di Pietro: infatti il muro fu presto ricoperto da una selva di graffiti, nei quali ricorre continuamente il nome di Pietro, segno della venerazione e della preghiera di intercessione a lui rivolta. Fra i graffiti, che vennero interrati con la costruzione della basilica e sono quindi precedenti, figura anche il monogramma costantiniano, abbreviazione del nome di Cristo e, soprattutto, una famosa iscrizione che è stata interpretata come «Pietro è qui».
Quando giunsero tempi più sereni per la Chiesa, Costantino, dopo la battaglia vinta contro Massenzio, promulgò insieme a Licinio l'editto detto di Milano, con cui venne data libertà di culto ai cristiani, e intraprese una serie di opere destinate a celebrare la fede cristiana. Spinto forse anche dalla madre Elena e dal pontefice Silvestro, Costantino decise di "monumentalizzare il luogo dove già esisteva l'edicola e di erigere, su di essa, una basilica.
Il monumento costantiniano della "Memoria" venne ottenuto racchiudendo l'edicola del II secolo e il "muro G" tra lastre di marmi preziosi e lasciandone aperto un solo lato, perché la nicchia con le due colonnine rimanesse visibile.
Sopra questa "Memoria", Costantino intraprese la costruzione della basilica: si tratta di un fatto estremamente importante perché offre un'ulteriore conferma della tradizione, ormai consolidata, che proprio lì fosse situato il sepolcro di Pietro. Espressione di tale convinzione è il fatto che la costruzione della basilica venne portata avanti superando grandissimi ostacoli di varia natura, proprio perché quella tomba fosse il fulcro dell’edificio.
Anzitutto la collocazione: il colle Vaticano presentava una pendenza tale che, per creare la spianata su cui erigere la basilica, fu necessario effettuare un ingente sbancamento da un lato, e un altrettanto ingente interramento dall'altro. A questo si aggiunga che la parte da interrare includeva la necropoli, all'epoca di Costantino ancora in uso: rendere inaccessibile un'area, frequentata dai congiunti dei sepolti, era un atto al limite del sacrilegio.
La pianta basilicale esisteva già presso i Romani, con funzioni di luogo d'incontro: era solitamente rettangolare, con l'ingresso su uno dei lati lunghi e, quindi, con più absidi. Gli architetti di Costantino integrarono questa tipologia con un nuovo orientamento: i fedeli, entrando, si incamminavano, simbolicamente, verso la zona absidale, che rappresentava la luce di Cristo che veniva loro incontro.
La basilica vaticana costituisce un'altra tappa innovativa, in quanto luogo di culto ma anche di memoria del martirio di Pietro: l'abside, sotto il cui arco si trovava il monumento celebrativo, aveva bisogno di un'area di transito che facilitasse il passaggio per venerare le reliquie. Nacque così il transetto, che divenne da allora elemento caratteristico dell'architettura delle chiese.
Un ulteriore cambiamento si ebbe con papa Gregorio Magno (590-604), che fece innalzare un altare sulla "Memoria", perché proprio sulla tomba di Pietro potesse essere celebrata l'eucaristia. Nel Medioevo, Callisto II (1119-1124) sovrappose all'altare di Gregorio Magno un nuovo altare che lo includeva. Infine nel 1594, durante i lunghi lavori che portarono alla scomparsa della basilica costantiniana e alla costruzione di quella attuale, Clemente VIII innalzò l'odierno altare, esattamente sul punto dove già erano sorti gli altari precedenti. Questa successione di costruzioni trova il suo culmine nel baldacchino bronzeo, ideato dal Bernini nel 1626, che riprende nel motivo delle colonne tortili, come si è già detto, la decorazione del monumento al tempo di san Gregorio Magno.
Insomma una successione impressionante di costruzioni sorte una sopra l'altra dice la venerazione immutata nei secoli: proprio lì venne sepolto Pietro. Il mito non ha luogo, né tempo. La fede cristiana, invece, nasce da fatti storici: hic, qui. Qui in Roma Pietro venne martirizzato e sepolto.
2/ La basilica di San Paolo fuori le Mura
1/ Motivi di un pellegrinaggio giubilare
Non è stato Paolo ad inventare il cristianesimo. Anzi egli è la prova che il cristianesimo era sé stesso e nuovo fin dalle origini. Infatti, da principio, egli lo perseguitò e giunse a partecipare al martirio di Stefano che proclamava che Gesù era figlio di Dio.
Paolo, come già il sinedrio al momento del processo, avvertiva chiaramente, da vero maestro ebreo, che ciò che Gesù diceva di sé era inaccettabile: egli non era un rabbino, bensì uno che si poneva allo stesso livello del Dio vivente.
Per questo si oppose con fermezza al cristianesimo, giungendo a chiedere l’incarico di perseguitare i cristiani anche a Damasco. Proprio Paolo è la prova di cosa fosse il cristianesimo, fin dalle origini.
Non fu Paolo a cambiare il cristianesimo, ma Cristo a cambiare lui.
Infatti, nel momento in cui Saulo non era in ricerca, non era scontento della sua fede nella Legge, Gesù gli apparve per grazia - è l'ultima apparizione del Risorto: è un dono imprevisto, poiché tale è sempre il miracolo della rivelazione di Dio.
Quell’incontro sulla via di Damasco fu per lui un cambiamento epocale: divenne cieco, si accorse di non aver mai visto pienamente, finché non fu battezzato nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
Nella prima lettera ai Corinti esprime con parole fortissime quella trasformazione: «Ultimo fra tutti apparve anche a me come a un aborto» (1 Cor 15,8). Da quel giorno la sua precedente vita gli apparve come un aborto, come una vita mai pienamente nata, e solo dal Battesimo in poi vita piena.
Per visualizzare tale ribaltamento, la tradizione iconografica ha aggiunto un cavallo alla scena, cavallo che come è noto non è nemmeno citato nelle tre diverse versioni della conversione dell’apostolo negli Atti degli Apostoli – ripetuta tre volte, tanto fu per lui decisiva.
L’antichità aveva sempre dipinto l’autorità a cavallo, come nel caso dell’imperatore, si pensi al famoso Marco Aurelio del Campidoglio. I grandi pittori avevano continuato a dipingere i grandi, eretti sul loro cavallo, come ancora farà Velasquez. Oggi un pittore contemporaneo dipingerebbe un potente all’interno di un SUV coni vetri oscurati.
L’invenzione iconografica del disarcionamento, dell’essere schienati – come in Caravaggio – dell’essere sbalzati giù, dice il rovesciamento: Cristo rovescia letteralmente le sicurezze di Paolo e lo trasforma.
Da quel momento, la scoperta di quel dono che gli preesisteva lo rese apostolo. Da quel momento san Paolo visse tutta la sua vita consapevole di dover fare dono a sua volta di quella grazia inaspettata che lo aveva sorpreso.
In un passo di apertura della lettera ai Romani, scritta prima ancora di giungere a Roma, l’apostolo scrive: «Sono in debito verso i Greci come verso i barbari, verso i sapienti come verso gli ignoranti: sono quindi pronto, per quanto sta in me, ad annunciare il Vangelo anche a voi che siete a Roma» (Rm 1,14-15).
Abitualmente il debito è qualcosa di terribile, di chi deve del denaro ad altri. Per Paolo, invece, essere in debito verso i romani che nemmeno conosce dipende dall’aver ricevuto un dono tanto grande, l’incontro con il Signore, che egli sarà appunto “in debito” finché vi sarà sulla terra qualcuno che ne sia ancora ignaro – e, difatti, Paolo avrebbe voluto recarsi poi anche in Spagna per proseguire quell’offerta da “restituire” a tutti, a greci, a barbari, a sapienti e ad ignoranti.
Papa Francesco, nella scia dei suoi predecessori, ha richiamato, in Evangelii Gaudium, al fatto che la scoperta della misericordia di Dio nella croce di Gesù spinge la Chiesa all'annuncio e più volte ha ripetuto l'esortazione di Paolo, già fatta propria da Paolo VI: «Annunciare il Vangelo non è per me un vanto, perché è una necessità che mi si impone: guai a me se non annuncio il Vangelo!» (1Cor 9,16).
Ha sottolineato anche che il dono della fede appartiene alla condivisione a cui è tenuto ogni “ricco” nella fede: «Desidero affermare con dolore che la peggior discriminazione di cui soffrono i poveri è la mancanza di attenzione spirituale. L'immensa maggioranza dei poveri possiede una speciale apertura alla fede; hanno bisogno di Dio e non possiamo tralasciare di offrire loro la sua amicizia, la sua benedizione, la sua Parola, la celebrazione dei Sacramenti e la proposta di un cammino di crescita e di maturazione nella fede. L'opzione preferenziale per i poveri deve tradursi principalmente in un'attenzione religiosa privilegiata e prioritaria» (EG 200).
Si è calcolato che Paolo abbia percorso a piedi, a cavallo o in barca, 16.500 km nei suoi tre viaggi apostolici e nel quarto viaggio, quello della prigionia, alla volta di Roma, tanta era l'urgenza che avvertiva di portare il Vangelo dove non era ancora conosciuto. Quando, finalmente, giunse a Roma fu, per lui, l’avverarsi di un sogno lungamente atteso e preparato.
Il desiderio di incontrare i cristiani di Roma è palpabile già nella Lettera ai Romani. In essa insegna che sia gli ebrei, sia i pagani, non possono giungere alla salvezza con le proprie forze. La ferita del peccato originale, infatti, è talmente evidente, che l'uomo non riesce ad amare con quell'amore che desidererebbe e si ritrova a fare spesso ciò che sa essere male, cioè il peccato: compie insomma consapevolmente il male che non vorrebbe compiere. La misericordia di Dio, però, non abbandona l'uomo ed è in grado di cambiare il cuore e di dare il perdono e la giustificazione.
Ma fu per la prima volta a Efeso, nel corso del terzo viaggio missionario, che Paolo dichiarò di voler venire a Roma: «Dopo essere stato a Gerusalemme, devo vedere anche Roma» (At 19,21). E fu al ritorno da tale viaggio che si concretizzò per lui l'occasione di giungere a predicare anche a Roma. Paolo venne, infatti, arrestato e falsamente accusato a Gerusalemme. Per poter sfuggire al tentativo di un gruppo di integralisti giudaici che avevano fatto voto di digiunare finché non lo avessero ucciso e per sottrarsi a un processo ingiusto, si appellò a Roma (At 22,27; 25,10-12), essendo cittadino romano.
La persecuzione divenne così per Paolo occasione per “saldare il debito”.
Fu lo stesso Gesù ad apparirgli, come sulla via di Damasco, mentre era recluso nella Città Santa, nella Fortezza Antonia, e a incoraggiarlo: nella notte «gli venne accanto il Signore e gli disse: "Coraggio! Come hai testimoniato a Gerusalemme le cose che mi riguardano, così è necessario che tu dia testimonianza anche a Roma"» (At 23,11). È l’unica volta che nel Nuovo Testamento la parola ‘Roma’ appare nella bocca del Signore.
Paolo poté così «portare il Vangelo fino agli estremi confini della terra». Roma non è geograficamente il confine estremo della terra (finis terrae era piuttosto la Spagna, dopo la quale cominciava il grande Oceano), ma, essendo l'urbe il cuore dell'Impero romano, giungere lì voleva dire per l’apostolo giungere al cuore delle "genti" che non conoscevano il Vangelo.
«Arrivati a Roma, fu concesso a Paolo di abitare per suo conto con un soldato di guardia» (At 28,16). Con linguaggio moderno, si potrebbe dire che Paolo fu posto "agli arresti domiciliari". La tradizione situa la sua casa nel luogo dove ora sorge la chiesa di San Paolo alla Regola, ma il luogo potrebbe essere stato anche diverso. A partire da questa sua condizione Paolo proclamerà nell’urbe: «Sia dunque noto a voi che questa salvezza viene ora rivolta ai pagani ed essi l'ascolteranno!» (At 28,28).
Il martirio avvenne probabilmente alle Acque Salvie, dove ora sorge la basilica delle Tre Fontane, tramite decapitazione, la condanna a morte riservata ai cittadini romani: Paolo morì in un luogo oscuro, lontano dalle folle, lui che era noto in tutto il mondo. Proprio l’oscurità di quel sito è l’elemento che più depone a favore di quell’indicazione topografica, che solo tardivamente si ritrova nelle fonti. Il suo corpo fu poi traslato nella basilica a lui dedicata.
Ma Paolo è anche l’apostolo delle lunghe lettere, scritte a comunità cristiane che già avevano ricevuto il kerygma, lettere che ancora oggi nutrono le comunità cristiane di tutto il mondo che vi ritrovano le loro tensioni e la loro speranza.
Nelle lettere Paolo esplicita da vero teologo anche una riflessione articolata sulla fede, si pensi solo all’elogio della carità che è in 1 Cor 13. Sia il discepolo amato, Giovanni, sia Paolo, usano il termine agape, amore, per indicare il cuore stesso di Dio. Entrambi sanno non stravolgere, ma anzi sintetizzare in maniera straordinaria tutta la novità cristiana apparsa nella croce di Cristo.
Non solo la narrazione, non solo la sintesi del Simbolo di fede, ma anche l’esposizione teologica è necessaria alla Chiesa ed è già nella Sacra Scrittura.
La basilica di San Paolo è divenuta sempre più negli anni luogo della preghiera struggente per l'unità dei cristiani. È proprio qui a San Paolo fuori le Mura che il 25 gennaio, ogni anno, si chiude la settimana di preghiera per l'unità dei cristiani, con la presenza del Papa e dei delegati delle diverse confessioni.
Tante volte san Paolo nella sua vita e nei suoi scritti ha esortato all'unità i cristiani del tempo, si pensi solo al cosiddetto Concilio di Gerusalemme o alle parole sulla divisione nella Chiesa di Corinto o ancora ai passaggi sull'unica fede e l'unico battesimo in Efesini.
San Giovanni Paolo II ha ricordato che l'ecumenismo non è un'appendice della vita ecclesiale, ma è costitutivo del mandato lasciato da Gesù. In particolare in Ut unum sint ha sottolineato il mutato atteggiamento generato dal Concilio: «Così credeva nell'unità della Chiesa Papa Giovanni XXIII e così egli guardava all'unità di tutti i cristiani. Riferendosi agli altri cristiani, alla grande famiglia cristiana, egli constatava: "È molto più forte quanto ci unisce di quanto ci divide"» (20).
Il pellegrinaggio a San Paolo fuori le Mura vuole così ricordare anche che tutti i cristiani condividono la fede in Gesù, vero Dio fattosi uomo. Ma poiché Gesù è il Figlio, allora Dio è Padre, Figlio e Spirito Santo. E poiché Dio è Trinità, allora riceviamo la vita con il Battesimo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il movimento ecumenico ha portato tutti i cristiani a riscoprire che credere nell'Incarnazione, credere nella Trinità e credere nel Battesimo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo sono tre aspetti dell'unica fede che ci accomuna: questa comunione che ci unisce è più grande di ogni differenza.
2/ Visitando la basilica
Dell'antica basilica non rimane quasi nulla: tutto venne distrutto da un incendio che divampò nel 1823. Le colonne superstiti vennero nuovamente erette all'esterno del transetto sinistro. Si salvò il ciborio, il portacero pasquale e una piccola sezione dell'abside. Fra l'altro, non esistendo allora l'idea di un restauro conservativo, tutto venne rifatto ex novo, limitandosi a ripetere nell'arco trionfale e nell'abside l'iconografia della precedente basilica.
La primitiva chiesa venne edificata nel 324 (o comunque pochi anni dopo la basilica del Laterano) dall'imperatore Costantino, il quale la volle distinguere, tra le tante memorie che a Roma ricordavano il passaggio di Paolo, come luogo privilegiato per la venerazione dell'Apostolo delle genti.
La più antica testimonianza della sepoltura di San Paolo sulla via Ostiense è riportata, insieme a quella di San Pietro, nella Storia Ecclesiastica di Eusebio di Cesarea. Restano controverse le circostanze precise del martirio di Paolo a Roma, legate comunque senza dubbio alla persecuzione neroniana.
Gli scavi archeologici realizzati fra il 2002 e il 2006 hanno riportato alla luce l'abside della piccola basilica costantiniana che aveva un orientamento opposto rispetto all'attuale - il tracciato di tale abside è visibile scendendo a venerare il sepolcro dell'Apostolo. I lavori di scavo hanno messo in luce il sarcofago che si ritiene contenga il corpo dell'Apostolo e che è ora visibile sul lato anteriore. La decisione di aprire il sepolcro non è stata ancora presa, anche a motivo del fatto che l'impresa richiederebbe lo smontaggio di gran parte dell'altare soprastante.
In epoca romana l'area si presentava come una zona di aperta campagna lungo la via Ostiense, utilizzata come sepolcreto. Scavi effettuati nel XVIII e XIX secolo sotto la confessione e intorno alla basilica portarono alla luce edifici funerari, lapidi, tratti di via lastricata. La tradizione vuole che il corpo dell'Apostolo sia stato sepolto dal suo discepolo Timoteo e da una matrona romana di nome Lucina (una donna di tal nome si incontra varie volte come soccorritrice di martiri cristiani a Roma, tanto da divenire quasi un cliché letterario).
Nel 386 gli imperatori Valentiniano, Teodosio e Arcadia dettero alla basilica l'orientamento attuale e la ingrandirono: tale edificio viene chiamato dagli studiosi la "basilica dei tre imperatori".
Leone Magno e Gregario Magno la abbellirono con i mosaici dell'arco trionfale e solennizzarono ulteriormente la tomba. Onorio III (1216-1227) fece realizzare il nuovo mosaico absidale.
Il reperto più importante a sottolineare la dedicazione paolina dell’edificio emerse durante i lavori di ricostruzione del secolo scorso, condotti dall'architetto Vespignani: è la lastra marmorea che era posta sotto l'altare, sulla tomba dell'Apostolo. Essa reca l'iscrizione Paulo Apostolo Mart(yri), cioè “All'Apostolo Paolo martire”. È controverso se essa risalga al periodo costantiniano della basilica o a quello "dei tre imperatori". La lastra è esposta nella pinacoteca annessa al chiostro e in essa erano stati praticati alcuni fori che documentano l'uso popolare di introdurvi lino o aromi da conservare quali reliquie per il “contatto” che così si era creato fra essi e la tomba.
La basilica di San Paolo è l'unica delle quattro basiliche giubilari romane ad essere ancora preceduta da un quadriportico. Tale struttura, in età paleocristiana, era un luogo di collegamento fra la città cosmopolita e la comunità cristiana. In particolare, i catecumeni che partecipavano tutte le domeniche all'ascolto della Parola insieme ai fedeli, inserendosi così nell'Eucaristia ancor prima di essere battezzati, ne uscivano però quando cominciava la seconda parte della messa, la liturgia eucaristica, e i catechisti li istruivano nel quadriportico, dove riecheggiavano a breve distanza i canti e le preghiere dei già battezzati. Terminata la liturgia, tutti si ritrovavano insieme in questo spazio che era quindi liturgicamente molto significativo.
Il monumentale quadriportico odierno ha al centro l'ottocentesca statua di San Paolo, che lo raffigura secondo un'iconografia stabilita fin dai primi secoli del cristianesimo: egli regge una spada che ricorda lo strumento con cui venne decapitato. Nell'altra mano ha un volume a ricordo delle lettere che Dio gli ispirò perché divenissero sua Parola per la vita dei credenti.
In un angolo del quadriportico sta, invece, la statua di san Luca. L'evangelista accompagnò Paolo a Roma, come indicano le cosiddette "sezioni-noi" degli Atti degli Apostoli, i brani cioè nei quali l'autore del libro, Luca, cammina al fianco dell'Apostolo. Il simbolo dell'evangelista è il toro. Più che preoccuparsi di determinare perché proprio quell'animale rappresenti Luca, vale la pena ricordare che i quattro esseri viventi, passati poi a indicare gli evangelisti, rappresentano in Ezechiele e nell'Apocalisse i quattro punti cardinali che la gloria di Dio raggiunge, senza poterne essere impedita, di modo che l'Agnello di Dio sia adorato ovunque: insomma quei quattro simboli, applicati ai Vangeli, indicano che l'annunzio della fede è per il mondo intero.
La Porta centrale venne fatta eseguire dall’allora abate della basilica padre Schuster: reca una grande croce e le immagini della vita e del martirio di Pietro e Paolo.
All’estrema destra è collocata la Porta santa. Essa è antichissima e per ammirarla pienamente dal lato più lavorato bisogna entrare nella chiesa. Fatta eseguire a Costantinopoli da Staurachio di Scio nel 1070, è composta da cinquantaquattro pannelli bronzei incisi, disposti su nove registri, e svela un programma iconografico di stile bizantino. I primi dodici pannelli in alto illustrano le dodici feste della liturgia bizantina e possono aiutare a riscoprire con spirito ecumenico la grande ricchezza dell'Oriente cristiano. Ad esempio, il terzo pannello della quarta fila rappresenta la Pentecoste: i dodici Apostoli sono raccolti intorno a una porta dalla quale esce il Kosmos, quale immagine del mondo che emerge dall'oscurità per ricevere dalla Chiesa l'annuncio della salvezza. Fu la liturgia, con le sue feste, in oriente e in occidente a porre in evidenza i “misteri” di Cristo, cioè gli eventi principali della sua vita, che sono come l’esegesi e la cristologia della Chiesa: chi li conosce, conosce Gesù Cristo.
Il monumentale arco trionfale, all’interno, ripete nella lavorazione ottocentesca lo schema iconografico presente nella basilica antica, con la rappresentazione del capitolo più importante dell'Apocalisse, il quinto. Cristo è al centro - nell'Apocalisse, sotto forma di agnello, qui con il viso radioso - adorato dai quattro esseri viventi e dai ventiquattro vegliardi, rappresentanti i quattro angoli della terra e il popolo di Dio erede dei dodici figli di Giacobbe e dei dodici apostoli del Signore.
Il catino absidale originario, di cui l'attuale ripete l'iconografia, venne realizzato sotto papa Onorio III (1216-1227), che è raffigurato ai piedi del Cristo. Al centro troneggia Cristo benedicente che mostra il libro sul quale è incisa la frase: «Venite, benedetti del Padre mio, ricevete in eredità il regno preparato per voi fin dalla fondazione del mondo» (Mt 25,34).
Alla sinistra sono San Pietro accompagnato dal fratello Andrea, e alla destra San Paolo accanto all'evangelista Luca, autore degli Atti degli Apostoli e testimone dell'evangelizzazione romana di Paolo.
Nella fascia inferiore due angeli e gli altri apostoli, ognuno con un cartiglio che recita una frase del Gloria, a partire dal primo angelo a destra che dice “Gloria in excelsis Deo”.
Al centro della fascia si erge l'Etimasia, cioè il trono di Dio con gli strumenti della passione allusiva del giudizio finale nel quale la croce di Cristo "peserà" a salvezza dei peccatori.
Vicino al trono si intravedono i due committenti (il sacrista Adinolfo e l'abate Giovanni Caetani), mentre dal basso non è visibile la raffigurazione dei Santi Innocenti, i primogeniti di Betlemme uccisi da Erode.
La parte inferiore del mosaico, con i piedi del Cristo e il papa prostrato, è molto più bella poiché è l'unica sopravvissuta all'incendio. Lo splendore delle sue tessere è, con evidenza, diverso da quello dell’ampio rifacimento all’intorno.
Il fulcro della basilica è il sepolcro dell'Apostolo cui si sovrappone l'altare, poiché nella celebrazione eucaristica la Chiesa del cielo e quella peregrinante in terra si uniscono.
Scendendo si può oggi vedere con i propri occhi il sepolcro di Paolo. È evidente anche l’abside della primitiva piccola chiesa di età costantiniana che era rivolta in senso inverso all’attuale.
Il ciborio fu scolpito da Arnolfo di Cambio intorno al 1285. Esso ha la funzione di porre in rilievo la presenza dell'altare. Vi sono scolpiti, oltre ai santi Pietro e Paolo, san Benedetto (o l'abate Bartolomeo) e san Timoteo, il primo in memoria del fondatore dell'ordine che presiede tutt'oggi il Monastero di San Paolo, mentre il secondo ricorda il più fedele discepolo di Paolo.
Sui pennacchi degli archi sono raffigurate, insieme all'offerta del ciborio a san Paolo da parte dell'abate Bartolomeo, tre coppie di personaggi dell'Antico Testamento: Adamo ed Eva che compiono il peccato originale, Caino e Abele che sacrificano i prodotti delle greggi e dei campi a Dio, e Davide e Salomone.
Il candelabro pasquale rappresenta la vittoria della luce di Cristo sul peccato e sulla morte. Fu scolpito dalla famiglia di marmorari dei Vassalletto tra la fine del XII e l'inizio del XIII secolo, e si salvò dall'incendio del 1823. Il basamento presenta quattro figure che afferrano al collo coppie di animali simbolici (sfingi, montoni e leoni), da interpretare quale raffigurazione della sconfitta del male.
Seguono alcune fasce con animali e motivi vegetali. La figura di vendemmiante che compare tra i racemi vuole ricordare la ciclicità del lavoro dell'uomo, illuminata dalla storia della salvezza.
Salendo ancora si vedono tre fasce "storiche".
Nella prima è raffigurata la cattura di Cristo da parte di guardie in armatura cui si accompagnano, alla sinistra di Gesù, due volti raffiguranti un sommo sacerdote e Giuda (quasi figura demoniaca) a ricordare il complotto che portò all'arresto. Il racconto prosegue con Caifa nel Sinedrio che, con il libro sacro alla mano, giudica Cristo colpevole, seguito dalla derisione di Cristo, legato mani e piedi a un trono, con in mano una canna quale scettro, beffeggiato da soldati.
La fascia sovrastante raffigura Cristo portato da Caifa a Pilato. A Pilato che si lava le mani segue la Crocifissione con i due ladroni nelle croci più piccole, Maria alla destra e Giovanni alla sinistra di Gesù e personaggi recanti i simboli della passione.
L'ultimo registro narrativo raffigura la Resurrezione: i soldati addormentati vicino al sepolcro si confondono con gli angeli reggenti la mandorla entro la quale avviene l'Ascensione, dove Cristo appare in tutta la sua maestà, seduto sopra l'arcobaleno, con una mano benedicente e uno scettro nell'altra.
L'iscrizione in basso recita: Arbor poma gerit. Arbor ego lumina gesto. Porto libamina. Nuntio gaudia, sed die festo. Surrexit Christus. Nam talia munera p[rae]sto («L'albero reca i frutti, lo sono un albero che reca luce. E doni. Annunzio gioia in un giorno di festa. Cristo è risorto. E io offro tali doni»).
Per ripercorrere le tappe della vita di san Paolo un ciclo di trentasei affreschi corre lungo la parte alta delle pareti della navata centrale e del transetto, dipinti per volere di Pio IX nel 1857.
Dove ha inizio questo ciclo di affreschi si sviluppa parallelamente una serie di ritratti di papi a partire da San Pietro: la sequenza ovviamente non ha finora un termine, perché viene aggiornata con l'immagine di ogni nuovo papa eletto.
La prima cappella a sinistra dell'abside conserva il crocifisso della fine del XIII secolo (attribuito da alcuni studiosi al Cavallini), che secondo la tradizione parlò nel 1350 a santa Brigida di Svezia, una delle sante che più vissero il desiderio di unità dei cristiani intorno al pontefice.
Nella stessa cappella, nel 1541, dinanzi all'icona allora ancora presente della Vergine con il Bambino, Ignazio di Loyola e i suoi primi compagni fecero la loro professione religiosa di gesuiti.
3A/ La basilica di San Giovanni in Laterano
A seguire i testi preparati da Andrea Lonardo per il sito web della basilica di San Giovanni in Laterano.
1/ Storia
San Giovanni è la prima basilica cristiana costruita esplicitamente per radunare l’intera comunità cittadina intorno al suo vescovo, anche se già prima dell’avvento al potere di Costantino i cristiani avevano iniziato a costruire chiese: di esse si hanno soprattutto testimonianze letterarie che affermano che a Roma ne esistevano già quaranta, mentre lo sviluppo artistico è testimoniato dall’arte precedente delle catacombe. Questo mostra a sufficienza come il cristianesimo, pur perseguitato, fosse talmente vitale da necessitare di luoghi e di mezzi espressivi.
Entrando in Basilica si respirano le volumetrie delle antiche basiliche pagane: essa venne, infatti, eretta dagli stessi architetti delle basiliche dei Fori Imperiali, ma con evidenti modifiche.
Innanzitutto nelle basiliche pagane si entrava nelle basiliche dal lato lungo, avendo le due absidi a sinistra e a destra. In San Giovanni in Laterano, invece, per la prima volta, con una traslazione di 90 gradi, si entra dal lato corto, poiché l’edificio è orientato verso l’unica abside, che rappresenta il Cristo che viene incontro a chi celebra l’Eucaristia.
Una seconda grande novità è data dalla posizione dell’altare: mentre nei templi antichi esso era all’esterno dell’edificio, ora è all’interno e su di esso non vengono più sgozzati gli animali, ma viene riproposto l’unico ed eterno sacrificio del Cristo presente nell’eucaristia.
Inoltre, mentre nelle strutture templari il popolo restava all’esterno, nella basilica cristiana - di cui San Giovanni è il prototipo che sarà ovunque imitato – tutti, uomini e donne, schiavi e liberi, nobili e gente del popolo, sono ammessi insieme all’Eucaristia.
Dell'edificio costantiniano sono superstiti le due colonne al lato sinistro e destro del ciborio.
A Roma Costantino sovvenzionò non solo la costruzione della Basilica del Salvatore - chiamata poi di San Giovanni in Laterano – ma anche di altre nove basiliche.
Egli donò per la costruzione del Laterano il terreno della Caserma della guardia privata di Massenzio. Si continuò a utilizzare il toponimo “in Laterano”, perché il luogo era precedentemente appartenuto alla famiglia dei Laterani.
2/ La Cattedrale e l’antica predella medioevale della cattedra
La basilica custodisce la “cattedra” del Papa, segno del suo essere “pastore”. Mentre le cattedre accademiche sono costituite da “tavoli” su cui poggiare libri, quelle delle cattedrali, invece, da una sede, perché è con la parola pronunciata a voce e con la testimonianza che, innanzitutto, si trasmette la fede.
Ma certo insegnare resta una delle espressioni più belle della carità. “Consigliare i dubbiosi”, “insegnare agli ignoranti”, “correggere i peccatori”, sono opere di misericordia spirituali: il vescovo di Roma - e con lui la Chiesa -, ha ricevuto da Cristo l’incarico di predicare, perché l’uomo ha bisogno di una parola che illumini la sua vita. Questa necessità è viva oggi, in un tempo disorientato simile a quello del Cristo: «Gesù vide una grande folla, ebbe compassione di loro, perché erano come pecore che non hanno pastore, e si mise a insegnare loro molte cose» (Mc 6, 34).
Dalla “cattedra” il pontefice che vi siede non insegna sé stesso, non afferma le proprie opinioni, ma la Parola di Dio, di cui è servo, perché risplenda dinanzi a tutti.
Fu Niccolò IV a risistemare la cattedra papale di cui è oggi rimasta la predella: vi si riconosce l’iconografia di Cristo vincitore sul male, rappresentato da quattro figure demoniache ai suoi piedi: aspide, basilisco, leone e drago, in riferimento al Salmo 91,13: «Calpesterai leoni e vipere, schiaccerai leoncelli e draghi».
Quelle immagini insegnano che il male esiste e va combattuto, ma che Cristo è ben più forte, non solo perché egli protegge la Chiesa dagli assalti del nemico, ma molto più perché è in grado di strappare al male chi è nel peccato e nella morte, come annuncia la fede: Cristo discese agli inferi e ne trasse fuori tutto il genere umano. Il male non viene dimenticato, ma vinto e vinto attivamente.
Il rituale dell’elezione di ogni nuovo papa si conclude ancora oggi con l’insediamento su questa cattedra. Il pontefice si reca in basilica in processione partendo da San Pietro e si siede sulla cattedra, attorniato da tutto il clero di Roma che prega per lui e lo applaude.
3/ Facciata e Logge
L’attuale facciata si deve ad Alessandro Galilei che la rinnovò sotto papa Clemente XII, nella prima metà del Settecento. Nella scritta in alto si vede chiaramente che la basilica è dedicata “Christo Salvatori”, al Cristo Salvatore e, infatti, subito sopra sta un mosaico con il volto del Signore. Nella basilica dovette subito riecheggiare il Simbolo di Fede (il “Credo”) di Nicea – oggi İznik in Turchia - che unì tutti i cristiani nella confessione dell’unica fede nell’anno 325.
Ma, subito a sinistra, sono indicati anche i nomi di san Giovanni Battista, a cui la Basilica fu presto dedicata a motivo del Battistero che aveva generato alla fede tanti romani, e poi di san Giovanni evangelista, che si aggiunse quando il futuro papa Ilaro, alla metà del V secolo, ritenne di essere stato protetto ad Efeso proprio dall’evangelista che era lì sepolto.
La Basilica di San Giovanni in Laterano è detta “omnium Urbis et Orbis ecclesiarum Mater et Caput” “madre e capo di tutte le chiese dell’Urbe e dell’Orbe”. Così recita l’iscrizione ai due lati dell’ingresso centrale. In realtà è la chiesa “apostolica” ad essere “madre”, poiché ognuno riceve la fede dall’unica chiesa sorta dai dodici Apostoli del Signore. Come riceviamo la vita, di generazione in generazione, non solo dai genitori, ma indirettamente da tutte le famiglie che nei secoli si sono succedute dalla prima coppia umana fino a loro, così riceviamo la fede da coloro che ci hanno donato il Battesimo che a loro volta lo hanno ricevuto dai primi discepoli del Signore. Siamo tutti figli della “madre chiesa”. La Chiesa di Roma, di cui San Giovanni è la cattedrale, può, però, essere detta madre di tutti, perché chiunque è in comunione con lei è certo di aver ricevuto la fede della chiesa madre di tutti, a motivo del ruolo peculiare del Vescovo di Roma che garantisce l’adesione a quell’unica fede.
L’altro portico d’ingresso è detto “sistino” perché venne rifatto da papa Sisto V che fece anche erigere dinanzi ad esso l’obelisco lateranense, il più antico monumento presente a Roma, perché venne scolpito dal faraone Tutmosis III (XV secolo a.C.) e poi trasferito a Roma dagli imperatori pagani. Tale facciata accoglie tutti i pellegrini che giungono alla basilica da San Pietro o comunque dal centro città.
Proprio l’esistenza delle due basiliche così lontane di San Giovanni – dove i papi risedettero fino all’esilio di Avignone – e di San Pietro, con le conseguenti processioni che si sono snodate nei secoli dall’una all’altra, hanno conservato a Roma le sue dimensioni urbanistiche fino ad oggi, senza mai ridurre le dimensioni della città.
4/ Costantino e la tomba di Lorenzo Valla
Lorenzo Valla è noto per aver dimostrato che la cosiddetta Donazione di Costantino non era un documento di età imperiale, bensì un testo altomedioevale. Valla non era assolutamente un umanista anti-clericale, tanto è vero che morì proprio a San Giovanni in Laterano, come canonico della basilica, reso tale dal papa: oggi la sua lapide sepolcrale è stata ricollocata nella cappella del Crocifisso nel transetto destro.
Oggi appare evidente che la Donazione di Costantino non è un falso costruito per giustificare un potere temporale estorto con la frode o la violenza, bensì è una leggenda che abbellisce, alla metà dell’VIII secolo, il dato di fatto del potere civile che il vescovo di Roma aveva necessariamente assunto, poiché l’imperatore da Costantinopoli non aveva più le forze per venire in soccorso di Roma, perché assediato a più riprese da avari, arabi, e barbari. Quando nel 751 cadde in mano ai Longobardi Ravenna, che era la città dove risiedeva il rappresentante del potere imperiale, Roma divenne di fatto una città indipendente dall’antico impero romano. Ma tale processo non ha né una data identificabile storicamente, né quella nuova entità territoriale un nome nuovo che la caratterizzi, poiché l’autorità temporale crebbe negli anni come una necessità storica che si impose nell’urbe. In Roma non ci fu più alcuno che potesse non solo difendere la città, ma ancor più essere punto di riferimento per la popolazione, ad eccezione del pontefice: la Donazione di Costantino trasforma in leggenda tale dato di fatto.
La stessa esigenza emerse nei terribili mesi dell’occupazione nazista di Roma, quando fu solo il pontefice a ritrovarsi a difendere la popolazione della città ed anzi l’intero paese.
5/ Borromini e la Gerusalemme celeste
La Basilica si presenta oggi nella forma che le dette Papa Innocenzo X per il Giubileo del 1650. Egli volle che Francesco Borromini conservasse la struttura della primitiva basilica, unitamente alle nuove forme curvilinee che si vedono nella controfacciata, tanto amate dal barocco per raffigurare l’accoglienza dell’intera umanità nella Chiesa.
La navata centrale si presenta come l’interno della Gerusalemme Celeste descritta dall’Apocalisse con dodici porte protette dai dodici 12 apostoli. Infatti, nelle nicchie, sono raffigurate dodici porte e dinanzi a ognuna di esse vi è la statua di uno dei Dodici. Chi partecipa alla liturgia nella Basilica è idealmente nel numero dei salvati all’interno della Gerusalemme discesa dal cielo. Le colombe sopra i tabernacoli e nella volta d’ingresso, oltre a commemorare il papa Pamphilj, si ricollegano idealmente alla raffigurazione dello Spirito Santo.
Borromini conservò il pavimento medioevale, opera dei maestri consumati, come un prato marmoreo che conduce all’altare. Gli ovali, in cui egli aveva lasciato il muro a vista come reliquia della chiesa antica, vennero ricoperti nel Settecento da dipinti rappresentanti profeti.
I bassorilievi a stucco, che secondo le intenzioni del Borromini sarebbero dovuti essere provvisori, illustrano storie bibliche secondo la lettura tipologica della storia della salvezza, caratteristica della fede cristiana e fatta propria della liturgia e dalla catechesi: ogni episodio dell’Antico Testamento è visto come prefigurazione del Nuovo. Ad esempio, nella seconda coppia di stucchi a partire dall’altare, l’Arca di Noè è prefigurazione del Battesimo.
Dietro il terzo pilastro della navata destra è stato spostato un frammento di affresco medioevale, detto della Loggia delle Benedizioni, raffigurante Papa Bonifacio VIII nell’atto di prendere possesso della sede Lateranense o nell’atto di indire il primo Giubileo. È controversa l’attribuzione a Cavallini o a Giotto.
6/ L’abside e l’immagine del Salvatore
L’abside è oggi arretrata rispetto all’antica. Nel 1884, infatti, Leone XIII volle un ampliamento del presbiterio. Secondo i discutibili criteri di intervento artistico del tempo, venne eseguito un rifacimento del mosaico duecentesco, mantenendone invariata l’iconografia, ma corrompendone irrimediabilmente la dimensione artistica.
Il mosaico era stato commissionato da papa Niccolò IV (1288-1292), primo francescano ad essere eletto papa, a Jacopo Torriti che modificò a sua volta il mosaico del V secolo.
Il mosaico absidale rappresenta in alto il volto di Cristo - che la tradizione vuole sia miracolosamente apparso in San Giovanni - e sotto di lui la colomba dello Spirito. Probabilmente, in origine, sopra il volto di Cristo era rappresentata la mano del Padre a comporre La Trinità.
Tutta la Misericordia della Trinità si rivela nella croce gemmata sottostante che è come avvolta da luce che diviene acqua. Al centro della croce vi è un clipeo con il battesimo di Gesù: l’incarnazione annuncia che Gesù è il figlio prediletto di Dio, ma anche che nel Battesimo noi veniamo uniti a Lui per diventare anche noi figli.
Infatti alla base della Croce sta un monte paradisiaco da cui sgorga acqua che si suddivide in quattro fiumi, ricordo della fecondità promessa in Genesi e realizzata nella Gerusalemme Celeste (Gen 2,10-14 e Ap 22,1). A quell’acqua si abbeverano due cervi e un’infinità di creature che traggono vita dalla Trinità rivelatasi nella croce. Insomma è tutta la Chiesa, sacramento dell’umanità, che beve alla sorgente della vita.
La chiesa è rappresentata anche dalle mura gemmate della Gerusalemme Celeste protette dall’arcangelo Michele che è sotto la croce. Gli apostoli Pietro e Paolo sono sulle sue torri dorate, mentre al centro si vede l’araba fenice, simbolo medioevale di immortalità.
Alla sinistra della croce la Vergine intercede per papa Niccolò IV inginocchiato, al quale segue San Francesco, in dimensioni ridotte, accompagnato dai santi Pietro e Paolo; alla destra il Battista, che completa la deesis, è seguito da sant’Antonio, anche lui in piccolo, e dai santi Giovanni e Andrea.
Più in basso sono gli altri nove apostoli e due piccole figure in abito francescano che ritraggono Jacopo Torriti, l’artista del mosaico, e Jacopo da Camerino che lo aiutò, evidentemente frati artisti.
7/ La Porta Santa
La Porta Santa è, nel portico, l’ultima a destra, ed è la prima ad essere stata aperta nella storia dei Giubilei, durante l’Anno Santo del 1423. Fu papa Martino V - sepolto davanti all’altare maggiore - a individuare nell’attraversamento della porta quello che divenne da allora il segno per eccellenza del pellegrinaggio giubilare: passare attraverso la vera porta, che è Cristo, per accogliere il dono della sua grazia. Solo nel Natale del 1499, papa Alessandro VI istituì l’apertura della Porta Santa anche in San Pietro.
8/ Le reliquie
Le principali reliquie della Basilica sono nel transetto. Nell’altare papale che è al centro, è custodito l’altare di legno sul quale la tradizione vuole abbia celebrato lo stesso San Pietro. Papa Urbano V commissionò nel 1368 a Giovanni di Stefano il Ciborio che ne sottolinea la presenza: in esso, in alto, sono custoditi i reliquiari con le teste di san Pietro e san Paolo. Le dodici pitture che circondano il Ciborio sono opera quattrocentesca di Antoniazzo Romano e della sua scuola.
Sopra l’altare del Sacramento, alla sinistra del transetto, è custodito una tavola che la tradizione vuole sia parte della mensa dell’Ultima cena di Gesù.
Il transetto vide il suo totale rinnovamento sotto il pontificato di Clemente VIII, in occasione del Giubileo del 1600, che gli donò il suo aspetto manierista. Giacomo della Porta diresse il rifacimento architettonico, mentre il Cavalier d’Arpino ne curò la decorazione con collaboratori, rappresentando le storie di Costantino.
9/ Il chiostro
Il chiostro venne eretto a partire dal 1222 sotto papa Onorio III fino agli anni di Gregorio IX - ai tempi di San Francesco. Venne costruito dai canonici lateranensi, cioè da sacerdoti diocesani che avevano assunto la regola per una vita comune, ispirandosi a sant’Agostino. Proprio il chiostro, che è il cortile aperto che non solo collegava i diversi ambienti della loro vita, ma anche facilitava il dialogo, la fraternità, lo studio e la preghiera comune è immagine di tale forma di vita. L’iscrizione musiva, che è ancora perfettamente leggibile, afferma fra l’altro: «claustri structura sit vobis docta figura», cioè la stessa struttura del chiostro sia per voi figura “dotta” di tale vita comune.
Lungo le pareti è ancora conservata la cattedra papale di età medievale, detta “sedia stercoraria”, perché nell’antico rituale al neo-eletto veniva ricordato che egli era solo un uomo e che, come dice il Salmo che gli veniva proclamato:
«Solleva dalla polvere il debole,
dall’immondizia [dal letame] rialza il povero,
per farlo sedere tra i prìncipi,
tra i prìncipi del suo popolo» (Sal 113 (112), 7-9).
Nel chiostro si conserva anche ciò che resta del magnifico sepolcro scolpito da Arnolfo di Cambio per Riccardo Annibaldi, che fu zio di un Annibaldi, discepolo e amico di Tommaso d’Aquino.
Si vede nell’opera di Arnolfo, precedente a Giotto, l’umanesimo incipiente del medioevo romano, con raffigurazioni che non hanno più niente di bizantino: nel corteo funebre, sono raffigurati due portatori di torce, due che reggono il Messale e la mitra, un altro che regge il vaso dell’acqua santa e addirittura un ministrante che soffia, con le gote gonfie, nell’incensiere, per ravvivare il fuoco.
Nel chiostro è anche conservata la lapide con il volto di Lorenzo Valla, che morì come canonico lateranense: nella lapide sono anche i libri che dicono la sua caratura di umanista.
10/Cappelle e monumenti
Nella basilica sono da ricordare, fra le tante opere d’arte, i monumenti e le cappelle, il sepolcro di Leone XIII, il papa della Rerum Novarum, che volle essere seppellito in basilica. La sua tomba si trova sopra il portone che conduce in sacrestia – il corpo del pontefice venne traslato di nascosto di notte in basilica, in un periodo di anti-clericalismo successivo all’Unità d’Italia.
L’organo che è in alto, nel transetto destro, è un antichissimo strumento costruito da Luca Blasi negli anni 1597-1599, quando ancora gli strumenti non erano stati “temperati”. Fra gli altri, lo suonò G.W. Haendel. Proprio a San Giovanni in Laterano nacque la nomenclatura delle sette note tuttora in uso (ut[poi do]-re-mi-fa-sol-la-si), a partire da un inno a San Giovanni Battista – Ut queant laxis – i cui versi iniziavano con tali sillabe.
La Cappella Corsini, la prima a sinistra, venne realizzata dal Galilei, che eresse poi la facciata, per la famiglia del papa Clemente XII ed è un gioiello del tardo barocco romano.
Il portale centrale di ingresso alla basilica è una delle tre porte bronzee di età romana che si sono conservate. Anticamente apparteneva al Senato romano e fu Borromini, in occasione del restauro dell’interno della basilica, a farla “aggiustare” per la nuova sistemazione, innalzandola di alcuni centimetri.
Il Sancta Sanctorum
Dell'Antico palazzo papale è rimasta oggi la cappella, nota come Sancta sanctorum, perché conservava le reliquie più sante custodite in Roma, la cappella nella quale è posta l'icona del Cristo acheropita (cioè non dipinta da mani d'uomo).
Il Sancta Sanctorum ha affreschi, successivi a san Francesco, commissionati da papa Niccolò III fra il 1277 e il 1280.
Essa si trova in cima alla scala santa, che la tradizione ritiene essere la scala del palazzo di Pilato a Gerusalemme, la stessa che Cristo salì per essere da lui giudicato. Per tradizione i pellegrini la percorrono in ginocchio.
Tutti i santi dell'antichità, venuti in pellegrinaggio a Roma, l'hanno percorsa in questa forma penitenziale. Gli affreschi del Sancta Sanctorum, svelati dopo il recente restauro, sono opera di un pittore probabilmente romano, influenzato dal cantiere assisiate.
Iniziando dalla parete d'altare, si vede papa Niccolò III accompagnato da Pietro e Paolo, che presenta il modellino della Cappella a Cristo. La parete destra accoglie i due riquadri con il Martirio di san Pietro e di san Paolo. Nella parete di fronte all'altare vi sono due affreschi rappresentanti il Martirio di santo Stefano e di san Lorenzo. I due pannelli di sinistra ricordano il Martirio di Sant'Agnese e un Miracolo di san Nicola.
Battistero
1/ Storia
Benché sia fantasiosa la narrazione del battesimo di Costantino amministrato da papa Silvestro, è certo che l'imperatore volle personalmente che a fianco della basilica sorgesse il monumentale battistero. Costantino si battezzò solo in punto di morte, nell’anno 337.
Quello Lateranense è il primo battistero cittadino ed è stato, come la basilica stessa, modello per tutti gli altri battisteri antichi, almeno della penisola italiana.
I primi cristiani di Roma si battezzarono nel Tevere, come ricorda Tertulliano, esattamente come in ogni regione della Chiesa antica dove si utilizzava l’acqua corrente e “viva”, soprattutto quella dei fiumi.
Ma presto la comunità sentì il bisogno di luoghi propri, coperti e abbelliti da immagini cristiane, perché la vita comunitaria ha bisogno di luoghi fisici in cui potersi incontrare e celebrare. Insomma i battisteri più antichi, come quello di Dura Europos in Siria, della metà del III secolo circa, non nacquero come una concessione da parte di un potere esterno, ma dalla vita stessa dei cristiani e dalla loro necessità di esprimere la fede in luoghi adatti, con parole, segni, canti e con un’adeguata espressione artistica.
2/ Il battistero paleocristiano
Il battistero costantiniano venne realizzato riadattando il ninfeo di un’area termale già esistente in loco, ma la costruzione si presenta attualmente nel rimaneggiamento voluto da Sisto III (432-440), lo stesso papa che edificò anche la basilica di Santa Maria Maggiore.
A lui si deve la pianta ottagonale del Fonte e il doppio ordine di colonne con l’architrave.
L'ottagono ricorda simbolicamente che il tempo scandito in settimane, come si è imposto a partire dal capitolo primo della Bibbia, è incompiuto, sebbene Genesi già conosca il settimo giorno come giorno di festa – è il grande dono del riposo settimanale sconosciuto prima dell’ebraismo, che la Chiesa ha donato al mondo intero.
Ma quel tempo che sempre si ripete, di settimana in settimana, ha bisogno di un compimento, di un giorno ulteriore, l’ottavo appunto, che spalanchi il fluire del tempo all’eternità, tramite la resurrezione di Cristo risorto “il primo giorno dopo il sabato”, come ricordano i Vangeli.
Sull’architrave si leggono i versi, forse del futuro papa Leone Magno allora diacono, con cui Sisto III volle si annunziasse il valore della grazia del battesimo nel corso della disputa pelagiana (Pelagio riteneva, a differenza della grande Chiesa e di Agostino che la illuminò su questo, che l’uomo potesse vivere la fede con le sole proprie forze, senza aver bisogno della grazia di Dio).
Così recita l’iscrizione:
“Nasce da questo seme divino un popolo da santificare che lo Spirito fa nascere da quest’acqua fecondata. Immergiti, peccatore, nel sacro fiume, per essere purificato. L’acqua restituirà nuovo quello che avrà accolto vecchio. Non c’è più distanza tra coloro che rinascono, una sola Fonte, un solo Spirito, una sola fede li uniscono. La Madre Chiesa partorisce i verginalmente in quest’acqua i figli che vennero concepiti alla morte. Se vuoi essere innocente, purificati in questo lavacro; sia che ti opprima la colpa paterna [quella di Adamo, cioè il peccato originale], sia la tua. Questa fonte è la vita e salva tutto il mondo, prendendo principio dalle ferite di Cristo. Sperate nel regno dei cieli, voi rinati a questa Fonte. Coloro che sono nati una sola volta non ricevono la vita felice. Nessuno sia atterrito dal numero o dalla forma dei propri peccati: chi è nato a questo fiume sarà Santo”.
3/ Il pronao dei catecumeni
L’originario ingresso consiste in un pronao biabsidato, che si presenta in tutto il suo splendore se osservato dall’esterno, con le colonne realizzate allora ex novo. Venne poi chiuso con lastre e su di esse si leggono, sempre dall’esterno, antiche iscrizioni a matita di pellegrini di età medioevale.
L’età costantiniana, il IV secolo, si caratterizzò per un ingresso amplissimo nel catecumenato – la parola “catechista” indica colui che attivamente fa “eco” alla Parola divina che viene dall’alto, mentre la parola “catecumeno” è nella forma “passiva” di chi la riceve.
Come Costantino fu probabilmente un catecumeno che ritardò il Battesimo, pur essendosi avvicinato alla fede cristiana, così è attestato di altri importanti personaggi che rinviarono a lungo il loro Battesimo – i più famosi sono Ambrogio, Agostino, ma anche Girolamo, Rufino e Paolino di Nola e, in oriente, Gregorio di Nazianzo, Basilio e Giovanni Crisostomo.
Nel pronao doveva avvenire la rinuncia al diavolo e la professione di fede nella Trinità, con la formula interrogativa che rappresenta il Simbolo di fede più antico.
Come attestano già gli Atti degli Apostoli, dove si racconta di chi riceveva il battesimo “insieme con quelli della sua casa”, anche a Roma chi decideva di ricevere il Battesimo lo riceveva insieme anche ai suoi bambini.
Nel pronao sono le due Cappelle dei santi martiri Cipriano e Giustina - con un mosaico del secolo V a racemi, un emiciclo con l’Agnello, quattro colombe e piccole croci gemmate - e delle sante vergini Rufina e Seconda martirizzate durante la persecuzione di Valeriano.
4/ Il Battistero barocco
La struttura paleocristiana di Sisto III venne ulteriormente modificata in età barocca.
Lungo il deambulatorio corrono cinque affreschi del Seicento che raccontano le gesta di Costantino.
La narrazione comincia con l’Apparizione della Croce – in realtà del monogramma costantiniano con le iniziali greche di Cristo - avvenuta secondo la tradizione nell’ottobre del 312 nella zona di Saxa Rubra (Grottarossa) lungo la via Flaminia.
Prosegue con la Battaglia di Ponte Milvio, conclusasi subito dopo, il 28 ottobre 312, nella quale Massenzio, nemico di Costantino, fu sconfitto e ucciso.
Si vede poi l’Ingresso in Roma di Costantino vincitore, per il cui trionfo il Senato romano fece erigere l’arco trionfale vicino al Colosseo, dove si afferma che l’imperatore venne ispirato “dalla divinità” – cancellando quindi ogni idea di politeismo.
Il quarto affresco rappresenta l’Abbattimento degli idoli e esaltazione della Croce, con riferimento anche agli scavi di Elena, madre dell’imperatore, la prima “archeologa”, che fece erigere la basilica del Santo Sepolcro a Gerusalemme e portò a Roma la terra di quello scavo insieme alle reliquie della croce, perché chi si recava alla basilica di Santa Croce potesse vivere come un pellegrinaggio “romano” in Jerusalem.
L’ultimo affresco raffigura il Concilio di Nicea, il primo concilio ecumenico del 325, che venne convocato e presieduto da Costantino stesso, forse proprio in quanto catecumeno. Nel dipinto l’imperatore fa bruciare le accuse degli ariani contro la fede cattolica e bacia le ferite dei martiri.
In alto, sono tondi affrescati con busti di Costantino e di papa Urbano VIII, aventi a fianco le chiese da lui restaurate in età barocca: San Pietro in Vaticano, San Paolo sulla via Ostiense, San Lorenzo al Verano, i Santi Pietro e Marcellino in via Merulana, Santa Croce in Gerusalemme e il battistero Lateranense.
5/ La cappella di San Venanzio
Nella Cappella di San Venanzio, realizzata dai papi Giovanni IV (640-642) e Teodoro (642-649), i neofiti appena battezzati nella notte di Pasqua ricevevano la Confermazione, prima di entrare solennemente in processione in basilica per celebrare l’Eucaristia.
La cappella, veneratissima dagli slavi e dai croati in particolare, venne pensata per accogliere le reliquie dei martiri dalmati Venanzio e Domnione. Il mosaico del catino absidale ha al centro il Salvatore e sotto di lui la sua Chiesa, rappresentata dalla Vergine orante con a destra san Pietro, con l’asta crociata, san Giovanni Battista, san Domnione e papa Giovanni IV e a sinistra da san Paolo, con le sue lettere in mano, san Giovanni evangelista, san Venanzio e Teodoro che offre la costruzione: è la Chiesa intera, celeste e terrestre, che prega il suo Signore.
In alto sono i simboli dei quattro evangelisti e a lato le due città di Betlemme e Gerusalemme, che ricordano l’Incarnazione la Pasqua.
Le Cappelle di San Giovanni Evangelista e di San Giovanni Battista furono, invece, edificate alla fine del secolo V da papa Ilaro (461-468), come ringraziamento ai due santi per lo scampato pericolo corso ad Efeso nel 449. L’architrave di ingresso della cappella dedicata a San Giovanni, l’evangelista che più è penetrato nel mistero della divinità e dell’umanità del Figlio, reca l’iscrizione dedicatoria: “Al suo liberatore il beato Giovanni evangelista, Ilaro, servo di Dio”, e la citazione giovannea: “Diligite alterutrum” (Amatevi gli uni gli altri).
Ilaro, diacono, era stato inviato da papa Leone Magno come suo delegato a Efeso, città giovannea, per contrastare Eutiche che affermava che Cristo non è consostanziale con l’umanità, ma che, una volta avvenuta l’incarnazione, si doveva affermare solo la natura divina di Cristo.
Il cosiddetto “latrocinio di Efeso” del 449 sembrò segnare la vittoria di tale posizione monofisita, ma due anni dopo, nel concilio di Calcedonia del 451, venne riaffermata la presenza in Gesù, nell’unica sua persona divina delle due nature, integre e complete, senza mescolanza, trasformazione, separazione o divisione. Succeduto a Leone Magno, Ilaro costruì queste due cappelle.
Palazzo Lateranense. Le due curie
La decadenza del Palazzo Lateranense ebbe inizio con quella che è chiamata la “cattività avignonese”, cioè il tentativo del regno di Francia di sottomettere a sé il pontefice e la sua Curia e il conseguente trasferimento dei papi ad Avignone – di cui la soppressione dei Templari è uno dei primi segni, cui il papato degli inizi del Trecento non poté opporsi con forza sufficiente.
Al ritorno da Avignone, la residenza papale si trasferì presso la basilica di San Pietro, di modo che il Laterano cadde in uno stato di progressivo deterioramento.
A nulla valse la riedificazione del Palazzo lateranense compiuta da Sisto V che, alla fin fine, fu più simbolica che effettiva: nei secoli successivi esso conobbe diversi utilizzi, ma nessuno permanente.
Furono i papi del Concilio Vaticano II ad intuire che era bene differenziare due organismi papali, uno a sostegno del mondo intero e l’altro al servizio di Roma.
Per questo oggi il papa ha due Curie: quella Vaticana, per il mondo intero, e quella Lateranense, nel suo servizio per la città di Roma.
Fu per primo Giovanni XXIII ad affermare: «Oh! Se il papa, vescovo di Roma, raccogliendo tutta l’amministrazione diocesana presso questa sua cattedrale, potesse radunare qui, con più grande larghezza di respiro, tutta l’organizzazione della Diocesi di Roma!».
Paolo VI, insistendo sul ruolo del papa come vescovo di Roma e riorganizzando in Laterano la vita del Vicariato, rese effettiva questa intuizione nel 1977.
In un discorso del 1975 in Laterano ricordò lo stato di desolazione del luogo e il suo sogno che prendeva forma: «Io mi ricordo che la prima volta che venni a Roma (avevo 8 anni e mezzo) si fece una escursione fino a San Giovanni in Laterano; ricordo ancora benissimo il senso di desolazione che mi sorprese in quella grande casa, tetra, chiusa, abbandonata d’intorno. E mi dissero: questa è la mater et caput. Ricordo tutte le volte che, giovane studente, avevo occasione di passare davanti a quell’edificio, bello ma cadente: lo si vedeva dalle finestre e dalle porte chiuse, dall’impossibilità d’entrare. E sempre i ragazzi e i giovani sognano: da qui bisogna ridare vita alla chiesa romana».
Sempre più, con i pontificati e con i Vicari successici, il Laterano si è configurato nella sua nuova dimensione di servizio a Roma: come l’amore del pontefice per il mondo intero è manifesto nella Curia Vaticana, così il suo amore alla diocesi si esprime nel lavoro degli Uffici del Laterano che supportano il Vicario in tale missione.
Così la basilica e gli annessi palazzi hanno ritrovato il loro senso originario: la loro funzione è oggi chiaramente leggibile per chi vi si reca in pellegrinaggio e vi trova un luogo vivo e accogliente, segno espressivo dell’intera comunità romana.
L’Ospedale di San Giovanni
L’Ospedale di San Giovanni e la basilica erano un tempo una sola cosa.
Chi giungeva in Laterano nel medioevo veniva ad incontrare il papa, ma vi trovava anche il luogo dell’accoglienza dei pellegrini e dei malati.
Il 1870 ha reso impossibile percepire tale unità, poiché l’ospedale è stato requisito da parte dello Stato e oggi quasi nessuno si accorge che i due grandi edifici in piazza San Giovanni - dal lato opposto della piazza rispetto al Palazzo Lateranense - sono le antiche corsie per i malati, quella per gli uomini e quella per le donne.
Quella degli uomini – che ha l’ingresso al centro della lunga facciata dalla parte opposta della strada dinanzi all’obelisco - è oggi detta Sala Mazzoni: reca ancora all’interno l’affresco del paralitico alla piscina di Bethesda, guarito da Gesù, e l’altare per le messe.
All’esterno dell’edifico si vede effigiato più volte il Santo Volto del SS. Salvatore, icona della Confraternita che vi prestava servizio – cui era legato anche il Bernini -, ma vi si trova anche la statua medioevale dell’arcangelo Michele, protettore dell’Ospedale.
Sul fianco destro dell’ospedale degli uomini si vede la più stretta facciata della corsia delle donne, che si sviluppa poi in lunghezza, nascondendosi alla vista di chi guarda dall’esterno.
L’ospedale ha origini già nell’alto medioevo, ma le sue forme attuali, come quelle del Palazzo Lateranense, risalgono alla fine del Cinquecento, ma con lavori che si protrassero poi lungo il Seicento.
Il Palazzo venne infatti riedificato da Sisto V negli anni 1585-1589, mentre la Corsia degli uomini dell’Ospedale del SS. Salvatore è degli anni 1580-1639 e il braccio delle donne è degli anni 1651-1655.
Fra gli ospiti più illustri dell’ospedale del Laterano figura certamente Francesco d’Assisi. Le fonti ricordano la sua permanenza presso la zona che è oggi chiamata del Presidio Santa Maria. Lì, giunto da Assisi per chiedere al papa in Laterano l’approvazione della Regola, si fermò a dormire dopo che gli ecclesiastici cui si era rivolto non gli avevano concesso di essere ricevuto dal papa. Ma il pontefice stesso lo mandò a chiamare dall’ospedale e lo ricevette infine nel vecchio patriarchio lateranense che era situato dove è oggi la Scala Santa con il Sancta Sanctorum.
3B/ La basilica di San Giovanni in Laterano
A seguire, presentazione della basilica di San Giovanni in Laterano preparata da Andrea Lonardo in occasione del Giubileo 2025, per il libretto messo a disposizione in basilica dal Dicastero per l’Evangelizzazione.
1/ Motivi di un pellegrinaggio giubilare
La basilica di San Giovanni in Laterano è detta omnium urbis et orbis ecclesiarum mater et caput («madre e capo di tutte le chiese dell'urbe e dell'orbe»). Così recita l'iscrizione ai due lati dell'ingresso centrale.
In realtà è la Chiesa apostolica ad essere "madre", poiché ognuno riceve la fede e la grazia da quell'unica Chiesa sorta dai dodici apostoli del Signore. Come riceviamo la vita, di generazione in generazione, non solo dai genitori, ma dalle famiglie che nei secoli si sono succedute dalla prima coppia umana fino a loro, così riceviamo la fede da coloro che ci hanno donato il battesimo e a loro volta lo hanno ricevuto dai primi che hanno battezzato nel nome del Signore, gli apostoli: siamo tutti figli della madre Chiesa.
La Chiesa di Roma, di cui San Giovanni è la cattedrale, può, però, essere detta "madre" di tutti, perché chiunque è in comunione con lei è certo di aver ricevuto la fede dalla madre Chiesa, a motivo del ruolo peculiare del vescovo di Roma di rappresentare e garantire l'unità della fede.
Più volte papa Francesco ha detto: «Una persona può battezzarsi da sé stessa? Nessuno può battezzarsi da sé! Nessuno. Possiamo chiederlo, desiderarlo, ma abbiamo sempre bisogno di qualcuno che ci conferisca questo Sacramento nel nome del Signore». La gratitudine per la Chiesa è la gratitudine di un figlio per la madre: ognuno sa che la fede è l'accoglienza di un dono che ci precede.
Contemporaneamente alla cattedrale di San Giovanni sorse il battistero (la cattedrale dedicata al Salvatore aggiunse presto la dedicazione a San Giovanni Battista a motivo del battistero, e successivamente, all'evangelista Giovanni). Alle origini i cristiani di Roma vennero battezzati in acqua corrente, nel fiume Tevere, ma poi sorsero i battisteri e, fra di essi, il primo e più importante fu quello del Laterano, espressione della maternità della Chiesa: anche oggi i catecumeni romani si recano in cattedrale per l’elezione e gli scrutini prima del Battesimo.
La basilica custodisce la "cattedra" del papa, segno del suo insegnamento. Insegnare è una delle espressioni più belle della carità. "Consigliare i dubbiosi", "insegnare agli ignoranti", "correggere i peccatori" sono opere di misericordia spirituale. Il vescovo di Roma - e con lui la Chiesa - ha ricevuto da Cristo l'incarico di predicare, di insegnare, perché l'uomo ha bisogno di una Parola che illumini la sua vita, ha bisogno di Dio che parli al cuore. Questa necessità è sentita ancora più oggi, in un tempo disorientato simile a quello che conobbe il Cristo: «Gesù vide una grande folla, ebbe compassione di loro, perché erano come pecore che non hanno pastore, e si mise a insegnare loro molte cose» (Mc 6,34).
Papa Benedetto XVI, nella sua prima visita a San Giovanni, disse: «La potestà di insegnamento [del vescovo di Roma] spaventa tanti uomini dentro e fuori della Chiesa. Si chiedono se essa non minacci la libertà di coscienza, se non sia una presunzione contrapposta alla libertà di pensiero. Non è così. Il potere conferito da Cristo a Pietro e ai suoi successori è, in senso assoluto, un mandato per servire. La potestà di insegnare, nella Chiesa, comporta un impegno a servizio dell'obbedienza alla fede. Il Papa non è un sovrano assoluto, il cui pensare e volere sono legge. Al contrario: il ministero del Papa è garanzia dell'obbedienza verso Cristo e verso la Sua Parola. Egli non deve proclamare le proprie idee, bensì vincolare costantemente sé stesso e la Chiesa all'obbedienza verso la Parola di Dio, di fronte a tutti i tentativi di adattamento e di annacquamento, come di fronte ad ogni opportunismo».
2/ Visitando la basilica
Prima dell'avvento al potere di Costantino, i cristiani avevano già iniziato a costruire chiese. Se ne hanno testimonianze letterarie, ma anche un edificio superstite precedente l'anno 256 a Dura Europos, nell'odierna Siria, con battistero e affreschi, e resti di un altro a Meghiddo, in Israele. Le catacombe di San Callisto sono certamente proprietà della comunità romana già nell'anno 200 d.C. I sarcofagi e gli affreschi presenti nelle catacombe mostrano a sufficienza come il cristianesimo, pur perseguitato, fosse talmente vivo e vitale da necessitare di luoghi e di mezzi espressivi. Con l'editto di Milano del 313 Costantino concesse la libertà di culto, ma successivamente egli incentivò anche l'edilizia cristiana. A Roma, in particolare, sovvenzionò la costruzione della basilica del Salvatore - chiamata poi San Giovanni in Laterano - come di diverse altre basiliche. Lo stesso fece a Gerusalemme, dove Elena, che può essere considerata quasi come la prima archeologa, fece riportare alla luce i luoghi della crocifissione, della sepoltura e dell’Anastasis di Gesù, riconoscendo il sito a motivo del Tempio che Adriano aveva fatto costruire per impedirne la venerazione, come ricorda Eusebio di Cesarea.
Costantino donò per la costruzione della basilica del Salvatore, poi San Giovanni, il terreno della caserma della guardia privata di Massenzio. Si continuò a utilizzare il toponimo in Laterano perché esso era precedentemente appartenuto alla famiglia dei Laterani.
San Giovanni è la prima basilica cristiana costruita esplicitamente per radunare l'intera comunità cittadina intorno al suo vescovo. Nella basilica riecheggiò il Credo che fu proclamato nel 325 a Nicea, l'odierna İznik, vicino l'antica Nicomedia capitale dell'Impero d'Oriente (Costantino fondò la nuova capitale Costantinopoli solo nel 330). I papi risiedettero in Laterano fino al periodo avignonese.
San Giovanni conobbe una svolta in età recente quando Giovanni XXIII scelse il suo Palazzo come cuore della vita della Diocesi di Roma e quando Paolo VI riorganizzò la vita del Vicariato e insistette sul ruolo del papa come vescovo di Roma. In un discorso del 1975, tenuto nella basilica, ricordava ancora lo stato di desolazione degli edifici, precedente alla svolta di Giovanni XXIII: «Io mi ricordo che la prima volta che venni a Roma (avevo 8 anni e mezzo) si fece con la mia famiglia una escursione fino a San Giovanni in Laterano; ricordo ancora benissimo il senso di desolazione che mi sorprese in quella grande casa, tetra, chiusa, abbandonata d'intorno... e mi dissero: questa è la mater et caput [...] Ricordo poi tutte le volte che, venuto a Roma, giovane studente, appena detta la santa messa, avevo occasione di passare davanti a quell'edifico, bello ma cadente: lo si vedeva dalle finestre e dalle porte chiuse, dall'impossibilità d'entrare. E sempre, fino da allora, i ragazzi e i giovani sognano: da qui bisogna ridare vita alla Chiesa romana». I pontefici successivi hanno proseguito nelle sue intuizioni.
La Porta santa è, nel portico, l'ultima a destra, ed è la prima ad essere stata aperta nella storia dei Giubilei, durante l'Anno Santo del 1423. Fu papa Martino V – sepolto davanti all'altare maggiore - a individuare nell'attraversamento della Porta quello che divenne da allora il segno del pellegrinaggio giubilare: passare attraverso la vera porta, che è Cristo, per accogliere il dono della sua grazia. Solo nel Natale del 1499, papa Alessandro VI istituì l'apertura della Porta santa anche in San Pietro.
L'assetto della basilica è quello ricevuto sotto papa Innocenzo X (1644-1655) per il Giubileo del 1650. Il Papa volle che Francesco Borromini conservasse nella risistemazione barocca la struttura della primitiva basilica - e, in effetti, negli ovali in alto, si dovevano vedere le murature costantiniane - di modo che tutto fosse in continuità con la storia precedente.
La navata centrale si presenta come l'interno della Gerusalemme celeste, descritta dall'Apocalisse con dodici porte caratterizzate da dodici apostoli: infatti, nelle nicchie sono raffigurate dodici porte e dinanzi a ognuna di esse vi è la statua di uno degli apostoli. Chi partecipa alla liturgia nella basilica è allora idealmente nel numero dei salvati, all'interno della Gerusalemme discesa dal cielo. Le colombe sopra i tabernacoli e nella volta d'ingresso, oltre a commemorare il papa Pamphilj, si ricollegano idealmente alla raffigurazione dello Spirito Santo.
Il Borromini conservò il pavimento medioevale, opera dei maestri Cosmati. Gli ovali in cui egli aveva lasciato il muro a vista, come reliquia della chiesa antica, vennero ricoperti nel Settecento da dipinti rappresentanti i profeti, mentre i bassorilievi a stucco, che secondo le intenzioni del Borromini sarebbero dovuti essere provvisori, illustrano storie bibliche secondo la lettura tipologica della storia della salvezza, caratteristica della fede cristiana e fatta propria dalla liturgia e dalla catechesi: ogni episodio dell'Antico Testamento è visto come prefigurazione del Nuovo. Ad esempio nella seconda coppia di stucchi a partire dall'altare, l'arca di Noè è prefigurazione del Battesimo.
Dietro il terzo pilastro della navata destra, è stato spostato un frammento di affresco medioevale, detto della Loggia delle Benedizioni, raffigurante papa Bonifacio VIII nell'atto di prendere possesso della sede Lateranense o nell'atto di indire il Giubileo. È controversa l'attribuzione al Cavallini o a Giotto.
Il transetto vide il suo totale rinnovamento sotto il pontificato di Clemente VII, in occasione del Giubileo del 1600, che gli donò il suo aspetto manierista. Giacomo della Porta diresse il rifacimento architettonico, mentre il Cavalier d'Arpino ne curò la decorazione con collaboratori, raffigurando le storie di Costantino.
All'interno dell'altare del Sacramento, sulla sinistra del transetto, è custodito un legno che la tradizione vuole sia parte della mensa dell'ultima cena di Gesù.
Al centro del transetto si trova il ciborio in stile gotico con l'altare papale. Al suo interno è custodito l'altare di legno sul quale la tradizione vuole abbia celebrato lo stesso san Pietro. Papa Urbano V commissionò nel 1368 il nuovo ciborio a Giovanni di Stefano, dove potessero essere custoditi i preziosi reliquiari con le teste di San Pietro e San Paolo. Le dodici pitture che circondano il ciborio, opera quattrocentesca di Antoniazzo Romano e della sua scuola, raffigurano La Crocifissione, Gesù Buon Pastore, la Vergine con il Bambino e l'Incoronazione della Vergine, circondati da diversi santi e sante.
Addossata alla parete, dietro l'altare, Nicolò IV sistemò una nuova cattedra papale dove si riconosce l'iconografia di Cristo e della Chiesa che vincono e calpestano il Male, rappresentato da quattro figure demoniache ai suoi piedi: aspide, basilisco, leone e drago, in riferimento al Salmo 91,13: «Calpesterai leoni e vipere, schiaccerai leoncelli e draghi». Tale basamento è ancora quello originario medioevale, mentre il resto della cattedra è una ricostruzione recente.
L'abside è oggi arretrata rispetto all'antica struttura; nel 1884, infatti, Leone XIII volle un ampliamento del presbiterio. Secondo i discutibili criteri di intervento artistico del tempo, venne eseguito un rifacimento del mosaico duecentesco, mantenendone invariata l'iconografia ma corrompendone irrimediabilmente la dimensione stilistica. Il mosaico era stato commissionato da papa Niccolò IV (1288-1292), primo frate francescano ad essere eletto papa, a Jacopo Torriti che modificò a sua volta il mosaico del V secolo.
Il mosaico absidale rappresenta in alto il volto di Cristo - che la tradizione vuole sia miracolosamente apparso in San Giovanni - e sotto di Lui la colomba dello Spirito. Probabilmente, in origine, sopra il volto di Cristo era rappresentata la mano del Padre a comporre la Trinità. Tutta la misericordia della Trinità si rivela nella croce gemmata sottostante che è come avvolta da luce che diviene acqua. Al centro della croce vi è un clipeo con il Battesimo di Gesù: l'Incarnazione annuncia che Gesù è il Figlio prediletto di Dio, ma anche che nel Battesimo noi veniamo uniti a Lui per diventare anche noi figli.
E infatti alla base della croce sta un monte paradisiaco da cui sgorga acqua che si suddivide in quattro fiumi, ricordo della fecondità promessa in Genesi e realizzata nella Gerusalemme celeste (Gen 2,10-14 e Ap 22,1). A quell'acqua si abbeverano due cervi e un'infinità di creature che traggono vita dalla Trinità rivelatasi nella croce. Insomma è tutta la Chiesa, sacramento dell'umanità, che beve alla sorgente della vita. La Chiesa è rappresentata anche dalle mura gemmate della Gerusalemme celeste protette dall'arcangelo Michele che è sotto la croce. Gli apostoli Pietro e Paolo sono sulle sue torri dorate, mentre al centro si vede l'araba fenice, simbolo medioevale di immortalità.
Alla destra della croce la Vergine intercede per papa Niccolò IV inginocchiato, al quale segue san Francesco, in dimensioni ridotte, accompagnato dai santi Pietro e Paolo; alla sinistra il Battista, che completa la deesis, è seguito da sant'Antonio, anche lui in piccolo, e dai santi Giovanni e Andrea.
La base della calotta ci mostra gli altri nove Apostoli e due piccole figure in abito francescano che ritraggono Jacopo Torriti, l'artista del mosaico, e Jacopo da Camerino che lo aiutò.
San Francesco e il Laterano medioevale
Francesco d'Assisi venne più volte a Roma a incontrare il Papa. A quel tempo il pontefice risiedeva in Laterano. San Pietro divenne Palazzo residenziale solo dopo il ritorno da Avignone. Infatti, nelle storie francescane e negli affreschi che da esse dipendono, il pontefice sogna Francesco che sorregge la basilica di San Giovanni e non quella di San Pietro.
Francesco fu totalmente innovatore nella spiritualità cristiana; scrisse nel Testamento: «Dopo che il Signore mi donò dei frati, nessuno mi mostrava che cosa dovessi fare: ma lo stesso Altissimo mi rivelò che dovevo vivere secondo la forma del santo Vangelo. Ed io con poche parole e semplicemente lo feci scrivere, e il signor Papa me lo confermò». D'altro canto fu talmente radicato nella tradizione da essere sempre fedele al Papa e alla Chiesa; sempre nel Testamento dice: «Il Signore mi dette e mi da tanta fede nei sacerdoti che vivono secondo la forma della santa Chiesa Romana, a causa del loro ordine, che se mi dovessero perseguitare voglio ricorrere ad essi. E se io avessi tanta sapienza, quanta ne ebbe Salomone, e mi incontrassi in sacerdoti poverelli di questo mondo, nelle parrocchie dove abitano, non voglio predicare contro la loro volontà. E questi e tutti gli altri voglio temere, amare e onorare come miei signori, e non voglio in loro considerare il peccato, poiché in essi io vedo il Figlio di Dio e sono miei signori. E faccio questo perché, dell'Altissimo Figlio di Dio nient'altro io vedo corporalmente, in questo mondo, se non il santissimo Corpo e Sangue suo che essi soli consacrano ed essi soli amministrano agli altri».
Il santo di Assisi sapeva che il suo modo di vita non era la forma ordinaria della vita cristiana, tant'è vero che creò il Terz'Ordine francescano di cui fanno parte ancora oggi i laici e i preti che si ispirano a lui, ma che, per vocazione, conservano responsabilità familiari, civili ed ecclesiali e perciò hanno esigenze di maneggiare il denaro, pur volendo vivere con serietà il Vangelo.
I superstiti luoghi medioevali in Laterano permettono di immaginarvi Francesco e i suoi frati, innanzitutto il magnifico chiostro che è visitabile con ingresso dalla navata sinistra della basilica. Il poverello di Assisi potrebbe aver lì passeggiato insieme al Papa e il chiostro stesso conserva ancora la cattedra papale di età medioevale, come la tomba scolpita da Arnolfo di Cambio per Riccardo Annibaldi, che fu zio di un Annibaldi discepolo e amico di Tommaso d'Aquino.
Francesco si recò certamente al Palazzo papale di cui è rimasta oggi la Cappella papale, nota come Sancta Sanctorum, perché conservava le reliquie più sante custodite in Roma. La Cappella nella quale è posta l'icona del Cristo acheropita (cioè non dipinta da mani d'uomo) ha affreschi, successivi a san Francesco, commissionati da papa Niccolò III tra il 1277 e il 1280. Essa si trova in cima alla Scala santa, che la tradizione ritiene essere la scala del Palazzo di Pilato a Gerusalemme, la stessa che Cristo salì per essere da lui giudicato. Per tradizione i pellegrini la percorrono in ginocchio. Tutti i santi dell'antichità, venuti in pellegrinaggio a Roma, l'hanno percorsa in questa forma penitenziale.
Francesco è ricordato esplicitamente nell'abside della basilica: Niccolò IV, primo Papa francescano, volle l'inserimento dei due santi francescani (Francesco e Antonio), accanto alla deesis. I due sono così ritratti, solo pochi decenni dopo la loro morte, nel mosaico.
Gli affreschi del Sancta Sanctorum, svelati dopo il recente restauro, sono opera di un pittore probabilmente romano, influenzato dal cantiere assisiate. Iniziando dalla parete d'altare, si vede papa Niccolò III accompagnato da Pietro e Paolo, che presenta il modellino della Cappella a Cristo. La parete destra accoglie i due riquadri con il Martirio di san Pietro e di san Paolo. Nella parete di fronte all'altare vi sono due affreschi rappresentanti il Martirio di santo Stefano e di san Lorenzo. I due pannelli di sinistra ricordano il Martirio di sant'Agnese e il Miracolo di san Nicola.
Il battistero lateranense
Benché sia fantasiosa la narrazione del battesimo di Costantino amministrato dal papa Silvestro, è certo che l'imperatore volle personalmente che a fianco della basilica sorgesse il monumentale battistero. Costantino si battezzò solo in punto di morte, nell'anno 337, a Nicomedia.
La costruzione fu successivamente rimaneggiata da Sisto III (432-440), lo stesso Papa che edificò anche la basilica di Santa Maria Maggiore. A lui si deve la pianta ottagonale del fonte. L'ottagono richiama simbolicamente la Pasqua, l'ottavo giorno, in cui la creazione viene portata a compimento, ricevendo la vita eterna.
Sull'architrave si leggono i versi, forse del futuro Leone Magno, con cui papa Sisto III volle si annunziasse il valore della grazia del battesimo nel corso della disputa pelagiana (Pelagio riteneva a differenza di Agostino che l'uomo potesse vivere il Vangelo con le proprie forze, senza la grazia di Dio):
Nasce da questo seme divino
un popolo da santificare
che lo Spirito fa nascere
da quest'acqua fecondata.
Immergiti, peccatore, nel sacro fiume
per essere purificato.
L'acqua restituirà nuovo
quello che avrà accolto vecchio.
Non c'è più distanza
tra coloro che rinascono,
una sola fonte, un solo Spirito,
una sola fede li uniscono.
La madre Chiesa partorisce verginalmente in quest'acqua
i figli che vennero concepiti alla morte.
Se vuoi essere innocente, purificati in questo lavacro
sia che ti opprima la colpa paterna (di Adamo), sia la tua.
Questa fonte è la vita e salva tutto il mondo,
prendendo principio dalle ferite di Cristo.
Sperate nel regno dei cieli
voi rinati a questa fonte.
La vita felice non riceve coloro
che sono nati una volta.
Né qualunque numero o forma dei propri peccati atterrisca:
chi è nato a questo fiume sarà santo.
Lungo il deambulatorio corrono cinque affreschi del XVII secolo rispettivamente con l'apparizione della Croce a Costantino, la battaglia di Ponte Milvio, l'ingresso trionfale a Roma di Costantino vincitore, l'esaltazione della Croce e l'abbattimento degli idoli, il Concilio di Nicea.
Nella Cappella di San Venanzio, realizzata dai papi Giovanni IV Dalmata (640-642) e Teodoro (642-649), i neofiti appena battezzati nella notte di Pasqua ricevevano la Confermazione, prima di entrare solennemente in processione nella basilica per celebrare l'Eucaristia.
4/ La basilica di Santa Croce in Gerusalemme
1/ Motivi di un pellegrinaggio
Elena imperatrice, madre di Costantino, può essere considerata la prima archeologa. Ella, infatti, anche se non utilizzò i moderni metodi scientifici di scavo, volle insieme al figlio ritrovare il luogo della resurrezione di Cristo dal sepolcro, scavando lì dove l'imperatore Adriano (117-138) – che aveva fortemente osteggiato la fede cristiana -, come raccontano Eusebio di Cesarea e san Girolamo, aveva interrato l'area nella quale i cristiani veneravano i luoghi della passione e della resurrezione, costruendovi sopra una zona templare dedicata a Giove e Venere, per occultarlo.
Il risultato fu, invece, quello di segnalare in modo definitivo la localizzazione del sepolcro di Gesù. La Rotonda del Santo Sepolcro, indagata da Elena, è stata oggetto di studi e di indagini recentemente da parte degli archeologhi dell’Università La Sapienza di Roma.
Tutto sembrerebbe confermare che Elena e Costantino decretarono di abbattere il tempio di Adriano e di costruire al suo posto il Martyrion, sulla roccia del Calvario emersa negli scavi, e la rotonda dell'Anastasis (in greco Resurrezione), sulla tomba ritrovata.
Parte del terreno di scavo venne fatto trasportare da Elena da Gerusalemme a Roma come reliquia e posto nella nuova basilica di Santa Croce in Gerusalemme (appunto perché chi calpestava il suo pavimento è come se calpestasse la stessa Terra Santa).
Secondo la tradizione, durante questi lavori di sterro e costruzione, Elena Augusta, madre dell'imperatore, ritrovò sul Golgota i resti del legno della Croce del Signore. Reliquie così preziose meritavano un'attenzione speciale e l'imperatrice decise perciò di costruire a Roma una cappella per custodirle nel Sessorianum, sua residenza privata, proprio lì dove l'imperatrice fece stendere uno strato di terra del Calvario, «macchiata dal sangue del Signore».
2/ Visitando la basilica
Oggi il pellegrino che si accosta a Santa Croce in Gerusalemme è accolto da uno dei capolavori del tardo barocco romano, la facciata settecentesca. L'aspetto è quello di un reliquiario aperto, dilatato a proporzioni gigantesche, con quattro grandi pilastri che dividono la facciata in una sezione centrale, su cui si aprono il portale e il finestrone ovale, e due sezioni laterali convesse.
Sulla sommità è una balaustra sormontata da statue: all'estremo sinistro Sant'Elena con la Croce, all'estremo opposto Costantino imperatore con Due angeli che adorano la croce e I quattro evangelisti. Si accede alla basilica tramite trova un atrio ellittico - l'ellissi è una delle forme predilette dall'architettura barocca.
Papa Benedetto XIV non solo commissionò tale nuova facciata al Gregorini e al Passalacqua per il Giubileo del 1750, ma volle anche completare l'opera di Sisto V che aveva collegato Santa Maria Maggiore con vie rettilinee sia al Laterano che a Santa Croce: collegò, infatti, quest'ultima con un rettifilo al Laterano.
In questo modo, venivano poste in relazione anche sul piano urbanistico le tre basiliche già unite sul piano devozionale: sin dal Medioevo, infatti, si veneravano nelle tre chiese vicine i tre momenti fondamentali della vita di Cristo: la Natività a Santa Maria Maggiore, la Passione a Santa Croce e la Resurrezione a San Giovanni, basilica del Salvatore. Dalla piazza di Santa Croce il pellegrino può vedere davanti a sé sia Santa Maria Maggiore sia la basilica del Laterano, abbracciando in un solo sguardo i tre massimi misteri della fede.
Entrati nella basilica si è subito attratti dal catino absidale. Fu Pedro González de Mendoza, arcivescovo di Toledo e primate di Spagna, cardinale titolare della basilica dal 1478 al 1495, a commissionarla al grande pittore Antoniazzo Romano.
L'area centrale del dipinto è occupata dal Redentore in gloria, racchiuso da una mandorla di cherubini, su uno sfondo di cielo stellato.
La fascia in basso è occupata, invece, dalla rappresentazione della scoperta della vera croce, secondo la Legenda Aurea di Jacopo da Varazze, un testo medioevale “da leggersi” nelle diverse feste liturgiche.
All'estremità sinistra dell'affresco, l'imperatrice Elena con la corona e l'aureola, inviata dal figlio Costantino a Gerusalemme, interroga l'ebreo Giuda a cui il padre Zaccheo, parente di santo Stefano, aveva trasmesso il segreto del luogo della crocifissione. Giuda - che poi si sarebbe convertito e sarebbe divenuto, secondo la Legenda Aurea, Ciriaco vescovo di Gerusalemme – rivela l'ubicazione del Golgota.
Nella seconda scena si vedono gli scavi e il ritrovamento delle tre croci, di Cristo e dei ladroni.
Per riconoscere fra le tre la croce del Signore, nella terza scena, si vede Giuda che fa stendere il cadavere di un giovane su ciascuna delle tre croci e, miracolosamente, al contatto con quella autentica, il morto ritorna in vita e rende gloria a Dio, sotto gli occhi della santa imperatrice in preghiera.
Al centro dell'affresco è dipinta la Croce ritrovata, retta a destra da sant'Elena, e adorata a sinistra dal cardinale committente in ginocchio.
Sulla destra dell'affresco è raffigurata la seconda parte della leggenda. Secondo la Legenda la Croce, depositata a Gerusalemme, venne trafugata da Cosroe, imperatore dei Persiani. L'imperatore cristiano Eraclio, nel 610, gli mosse guerra per recuperare la reliquia.
Si decise di affidare le sorti del conflitto a una singolar tenzone fra Eraclio e Cosroe: nella prima scena di sinistra si vedono i due che si fronteggiano su di un ponte.
La narrazione prosegue poi, nella seconda scena, con Eraclio vincitore che si reca a cavallo a Gerusalemme per deporre di nuovo la reliquia al suo posto. L'affresco mostra l'apparizione di un angelo (dipinto fiammeggiante su una nuvoletta all'estrema destra), che intima a Eraclio di non entrare a Gerusalemme col fasto di un sovrano.
E infatti l’ultima scena mostra Eraclio che, stavolta a piedi e spogliato dei suoi ornamenti, porta in spalla la croce per riporla in Gerusalemme.
Abbandonando la chiesa, si scende dalla navata destra nella Cappella di Sant'Elena, che riporta al motivo del sorgere stesso della basilica che riutilizzò un’antica aula del palazzo imperiale.
Santa Croce era nota anche col semplice nome di Hierusalem, perché si sapeva che proprio sotto il pavimento della Cappella di Sant'Elena giaceva la terra del Calvario. L'uso di portare con sé dai luoghi santi della terra come reliquia del pellegrinaggio era molto comune e quindi la notizia della tradizione è verosimile.
La Cappella di Sant'Elena, nella struttura dell'antico palazzo imperiale, doveva servire forse come oratorio privato dell'imperatrice, ma la recente scoperta di un battistero paleocristiano lascia intravedere che avesse già in antico un utilizzo pubblico.
I discendenti di Costantino, l'imperatore Valentiniano III insieme alla madre Galla Placidia e la sorella Onoria, ornarono la Cappella con un mosaico, fra il 425 e il 455. Esso venne rifatto da Baldassarre Peruzzi nel 1507-1508, su richiesta del cardinale titolare succeduto al Mendoza, Bernardino Lopez de Carvajal, e sull'onda dell'entusiasmo suscitato dal ritrovamento del titulus della croce. Il soffitto è oggi uno dei pochi esempi di mosaico rinascimentale a Roma. La volta è divisa da cornici e festoni ispirati ai mosaici antichi (secondo le norme dell'imitazione dei classici tipiche del tempo). Nel cerchio centrale si vede il Cristo benedicente e sorridente, che tiene in mano il libro con scritto Ego sum lux mundi; negli ovali stanno i quattro evangelisti. Nelle lunette, invece, alcune scene della “leggenda” della croce. A partire da quella posta a sinistra del Cristo, il Miracolo del giovane risuscitato dalla vera Croce, Sant'Elena che l'adora, Sant'Elena che ordina di dividerla in tre parti, e infine Eraclio che entra a Gerusalemme in processione.
Si ammira anche una statua di divinità pagana classica riadattata come effige di sant'Elena con la croce, sotto la quale è visibile l'antico pavimento con la terra riportata da Gerusalemme.
Le reliquie della Santa Croce
Le reliquie erano originariamente conservate nella Cappella di Sant'Elena. Durante i lavori di ristrutturazione medioevali ordinati da papa Lucio II nel 1144, furono collocate in una cassetta di piombo, murata al sommo dell'arco trionfale. Durante i successivi lavori di ristrutturazione, ordinati dal cardinale Mendoza, la cassetta contenente il titulus, ormai dimenticato, venne ritrovata il 1° febbraio 1492, lo stesso giorno in cui arrivò a Roma la notizia che in Spagna i re cattolici avevano costretto alla resa Granada, ultima roccaforte araba in Europa, e che perciò la Spagna era ormai nuovamente tutta cristiana.
Papa Innocenzo VIII accorse a venerare la reliquia. Alessandro VI nel 1496 emise la bolla Admirabile Sacramentum con cui autenticava la scoperta e concedeva l'indulgenza a chi avesse visitato la chiesa in quel giorno. Le reliquie ripresero perciò ad essere venerate nella Cappella di Sant'Elena sino a questo secolo, quando venne inaugurata, nel 1930, una nuova cappella alla quale si accede dalla navata di destra.
Nella teca in fondo alla cappella sono esposte le diverse reliquie. La più impressionante è senz'altro il titulus, l'iscrizione cioè che era stata posta sulla croce di Gesù (cfr. Gv 19,19-22).
Sul titulus che si venera a Santa Croce si può leggere ancora parte del testo latino US NAZARENUS RE nel rigo più basso, con i caratteri che i romani usavano per le leggi affisse all'albo pretorio, e al di sopra la stessa dicitura in greco e in caratteri ebraici molto deteriorati. Le scritte latina e greca corrono da destra a sinistra come quella ebraica.
Nella teca sono esposti anche tre frammenti di legno che la tradizione vuole siano appartenuti alla vera Croce, conservati in un unico reliquiario, oltre a un quarto frammento ritenuto appartenente alla croce del buon ladrone: quest'ultimo certamente faceva parte di un patibulum romano, cioè al braccio orizzontale di una croce utilizzata come strumento di morte. La cappella conserva anche un chiodo che sarebbe stato utilizzato per la crocifissione, una falange del dito di san Tommaso e due spine provenienti dalla Corona di Gesù.
Nel 1825 entrarono a far parte del tesoro di Santa Croce anche alcuni piccoli frammenti in pietra delle grotte di Betlemme e del Santo Sepolcro.
L'intero complesso delle reliquie è uno strumento prezioso per accostarsi all'Incarnazione e alla Morte di Cristo in croce per amore dei peccatori, che sono realtà e non mito, ben al di là delle reliquie stesse.
5/ La basilica di San Lorenzo fuori le Mura
1/ Motivi di un pellegrinaggio
Lorenzo fu diacono della chiesa di Roma. Una lettera di papa Cornelio a Fabio vescovo di Antiochia, scritta fra il 251 e il 253, ricorda che a quel tempo vi erano a Roma «quarantasei presbiteri, sette diaconi, sette suddiaconi, quarantadue accoliti, cinquantadue esorcisti, lettori e sacrestani, più di millecinquecento vedove e poveri» - è uno dei rarissimi casi antichi in cui è possibile sapere esattamente alcuni numeri della comunità cristiana di Roma.
Il nome “diacono” deriva dal verbo greco “diaconeo”, che vuol dire “servire”, ed indica il ministero nato per volontà del Signore già negli Atti degli Apostoli per servire gli orfani, le vedove e più in generale i poveri, ma anche per l’annunzio e il servizio dell’altare.
La persecuzione che condusse poi alla morte Lorenzo iniziò con l’imperatore Decio che, nell’anno 250, dette principio ad un’azione globale contro i cristiani: ogni cittadino dell’impero doveva sacrificare agli idoli pagani per ottenere un certificato di fedeltà alla religione ufficiale, chi non l’avesse fatto era cristiano ed era perseguibile.
Un anno dopo Decio morì e salì al trono Valeriano che indurì ancora di più la persecuzione: nel 258 un nuovo decreto comportava l’uccisione immediata di vescovi, presbiteri e diaconi, insieme ai senatori e cavalieri che fossero cristiani, con l’esilio delle matrone e la condanna alle miniere o al lavoro forzato dei cesariani trovati fedeli del vangelo: l’imperatore, insomma, intendeva eliminare del tutto la gerarchia ecclesiale e tutti quei laici di alto rango che erano favorevoli alla chiesa.
A motivo di tale disposizione avvenne prima il martirio di papa Sisto II (257-258) insieme a 4 diaconi, il 6 agosto del 258, e poi il martirio di san Lorenzo, quattro giorno dopo, il 10 agosto.
La persecuzione si arrestò solo nel 260, quando l’imperatore Valeriano fu fatto prigioniero in guerra. Gallieno, suo successore, modificò radicalmente la politica religiosa, tramite l’editto detto “di restituzione”, poiché prevedeva che venissero restituite ai cristiani proprietà e chiese.
Proprio il fatto che per due volte, a distanza di quattro giorni, la polizia dell’impero abbia arrestato il pontefice e i suoi diaconi nelle catacombe, prova che tutti sapevano che quei cimiteri erano di proprietà della chiesa che aveva edifici e chiese ben prima di Costantino, per permettere alla comunità di celebrare – falsa è, invece, la notizia che le catacombe servissero come rifugio dei cristiani.
Lorenzo, proprio perché aveva sovrinteso all'amministrazione dei beni ecclesiastici, accettando le offerte e custodendole, distribuendole ai più bisognosi, agli orfani e alle vedove, mostrando al vivo il volto materno e provvidente della comunità cristiana, divenne uno dei personaggi più noti della prima cristianità romana e uno dei martiri più amati e venerati, e la sua memoria fu ricordata nell'urbe da molte chiese e cappelle, innalzate in suo onore nel corso dei secoli.
Il suo corpo venne deposto dopo il martirio fuori della città in crypta nel cimitero che era sulla via Tiburtina dove oggi sorge la basilica a lui dedicata.
Costantino per primo fece erigere una chiesa - poi ampliata con pianta circiforme e infine distrutta - a fianco del cimitero.
Papa Pelagio II (579-590) sbancò il colle su cui si trovava il cimitero al fine di costruire una basilica esattamente sulla tomba del martire.
Papa Onorio III (1216-1227) ne aggiunse un'altra a quella di Pelagio, ma comunicante con essa, per cui, entrando oggi, si attraversa prima la basilica medioevale e si giunge poi a quella pelagiana divenuta il presbiterio dell'attuale. Onorio invertì anche l'orientamento della basilica.
2/ Visitando la basilica
Si accede alla basilica attraverso il portico, opera dei Vassalletto, una delle più importanti famiglie di marmorari romani detti anche Cosmati, attivi nel XII e XIII secolo.
Sopra l'architrave corre un fregio cosmatesco con mosaici in gran parte distrutti dal bombardamento del 1943. Sono sopravvissuti solo l'Agnello entro un clipeo, simbolo di Cristo che offre sé stesso, e la scena della presentazione a san Lorenzo di Pietro da Courtenay, incoronato nella basilica imperatore latino di Costantinopoli da papa Onorio III nel 1217.
Il nartece, il cui accesso è scandito dal ritmo sereno delle colonne, è decorato da affreschi duecenteschi. La tradizione vuole che, essendo imperatore Giustiniano I, le reliquie di santo Stefano, ritrovate a Gerusalemme nel 415, siano state traslate in Roma e deposte a fianco di quelle di san Lorenzo. I due corpi dei santi diaconi riposerebbero così l'uno a fianco dell'altro.
Gli affreschi dipingono, in parallelo, le storie dei due martiri, a destra quella di Lorenzo e, a sinistra, quella di Stefano.
Secondo la tradizione Lorenzo venne catturato presso le catacombe di San Callisto. Mentre il pontefice e gli altri diaconi subirono subito il martirio, Lorenzo fu temporaneamente risparmiato, con l'obiettivo di farsi consegnare i tesori della chiesa di cui era custode. Si narra che al magistrato, che gli imponeva la consegna dei tesori, Lorenzo abbia condotto i poveri e gli ammalati posti sotto le sue cure, e abbia detto: «Ecco i tesori della Chiesa».
Lorenzo fu allora dato in custodia al centurione Ippolito, che lo incarcerò in un sotterraneo del suo palazzo. In questo luogo buio e angusto si trovava prigioniero anche un certo Lucillo, privo di vista. Lorenzo confortò il compagno di prigionia, lo incoraggiò, lo catechizzò circa la dottrina di Cristo e, servendosi di una polla d'acqua che sgorgava dal suolo, lo battezzò. Dopo il battesimo, Lucillo riebbe la vista. Il centurione Ippolito, avendo costatato il miracolo, colpito dalla serenità e mansuetudine dei prigionieri, e lui stesso illuminato dalla grazia di Dio, si fece cristiano ricevendo il battesimo da Lorenzo. In seguito lo stesso Ippolito, riconosciuto cristiano, fu legato a un cavallo e trascinato per sassi e rovi fino alla morte. Lorenzo fu invece bruciato vivo sulla graticola, in un luogo poco lontano dalla prigione; il suo corpo fu poi portato al Campo Verano, nelle catacombe in seguito dette di Santa Ciriaca.
Tale storia è dipinta in tre file, ognuna con sei riquadri.
Nella prima in alto vediamo: Lorenzo riceve da Sisto II il comando di distribuire ai poveri i beni della Chiesa; Lorenzo lava i piedi ai poveri della casa di Narciso; Lorenzo guarisce una donna cieca; Lorenzo distribuisce i tesori della Chiesa ai poveri; Sisto II predice a Lorenzo il martirio; l'imperatore Valeriano ordina a Lorenzo di consegnargli i beni della Chiesa.
Nella seconda, la fila centrale, troviamo: Lorenzo guarisce santa Ciriaca; Lorenzo viene flagellato per ordine di Valeriano; Lorenzo battezza Romano, un soldato convertito; l'imperatore fa decapitare Romano; Valeriano ordina la morte di Lorenzo; Lorenzo è bruciato sulla graticola.
Nella terza fila, in basso, vediamo: Ippolito fa trasportare la salma di Lorenzo (tre quadri); Ippolito seppellisce Lorenzo; Ippolito scambia la pace con i servi della sua casa; Ippolito riceve l'eucaristia.
Nelle due pareti laterali, invece, sono descritti miracoli attribuiti ai santi diaconi dopo la loro morte in favore dell'imperatore Enrico II (1002-1024) e di papa Alessandro II (1061-1073).
Nel nartece, a sinistra, vi è la tomba di Alcide De Gasperi (opera dello scultore Giacomo Manzù), il grande statista italiano che diede un contributo decisivo nel condurre l'elettorato cattolico a scegliere la democrazia, nel referendum sulla forma istituzionale, e poi nel guidare l'intero Paese nel difficile cammino della ricostruzione fisica e morale dopo la seconda guerra mondiale.
Nella navata incontriamo i due amboni, tra i più belli conservati a Roma, opera dei maestri cosmati nella prima metà del XIII secolo. Quello di sinistra, detto dell'Epistola perché riservato alla lettura dei testi biblici non evangelici, è più semplice. Quello che lo fronteggia, adibito alla proclamazione del Vangelo - affidata, dove possibile, al diacono -, appare più ricco e ornato di marmi colorati. Accanto all'ambone e sostenuto da due leoni ruggenti si trova il bellissimo candelabro per il cero pasquale, ornato da un mosaico a spirale. Alla luce del cero pasquale, appena acceso dal nuovo fuoco benedetto nella notte di Pasqua, il diacono canta l'Exultet, l'annuncio della resurrezione del Signore Gesù.
Oltrepassati gli amboni, alcuni gradini conducono al presbiterio. Nella cripta sottostante troviamo, al centro, un altare dietro il quale vi è la tomba dei santi Lorenzo, Stefano e Giustino. È questo il centro della basilica, idealmente punto di unione delle due chiese, quella onoriana e quella pelagiana, da cui è costituita quella attuale.
Nel presbiterio alle spalle dell'arco (verso l'interno) si vede il mosaico dell'arco trionfale, realizzato sotto papa Pelagio II alla fine del VI secolo. La parte superstite dell'antica decorazione musiva rappresenta la Maiestas: Cristo benedicente e con la croce è al centro su di un globo azzurro, l'universo. Alla sua destra san Paolo che introduce santo Stefano con il libro aperto, e sant'Ippolito, il quale offre la corona del martirio. Alla sinistra del Cristo san Pietro che introduce san Lorenzo con il vangelo aperto alle parole del Magnificat, «disperse i superbi, dette ai poveri» e il pontefice Pelagio che offre la basilica. In basso, ai lati, Gerusalemme e Betlemme dalle mura gemmate.
In fondo alla navata destra sta la Cappella di San Tarcisio, nella quale venne sepolto, per suo espresso desiderio, il beato papa Pio IX.
Il chiostro, databile all'XI secolo, sorge sul fianco destro dell'attuale basilica. Esso è, insieme con il campanile e un'altra torre retrostante, l'ultimo resto di quello che era l'aspetto della Laurenziopoli medioevale, sorta a difesa del complesso a causa degli attacchi arabi del IX secolo.
6/ Le catacombe e la basilica di San Sebastiano
1/ Motivi di un pellegrinaggio
Le catacombe, un termine che nasce proprio a San Sebastiano
I pagani usavano chiamare i loro cimiteri con il vocabolo greco necropoli, “città dei morti”. I primi cristiani, invece, preferirono il nome cimitero, da loro stessi inventato, che deriva dal greco koimào che significa dormire. Già dal termine utilizzato traspare la fede dei cristiani nella resurrezione. Il termine “catacombe”, invece, si affermò molto tardi a partire dal toponimo catacumbas che indicava la località ove sorge ora la basilica di San Sebastiano, in cui si trovava un forte avvallamento oggi assai meno visibile. Da questo luogo, che rimase l'unico cimitero sotterraneo visitabile dai pellegrini fino al 1600, il termine prese poi a indicare le diverse catacombe. Le sepolture sotterranee non furono peculiari dei cristiani, anzi essi ripresero l'uso dai Romani pagani - inoltre a Roma esistono anche catacombe ebraiche.
Le fonti letterarie testimoniano che già agli inizi del III secolo - ben 100 anni prima di Costantino! - la comunità cristiana di Roma possedeva il cimitero che sarà detto poi "di Callisto". Nella Confutazione di tutte le eresie, tradizionalmente attribuita a Ippolito Romano (sebbene la paternità dell'opera sia discussa), si legge, infatti, che Callisto, allora diacono, venne incaricato da papa Zefirino, fra il 189 e il 222, della custodia delle catacombe oggi dette di San Callisto. Così recita il testo:
«Alla morte di Vittore, Zefirino, volendo [Callisto] come collaboratore nell'istruzione del clero, [lo] onorò a proprio danno, e trasferitolo da Anzio gli diede l'incarico di sorvegliante del cimitero» (IX,12,14).
Tale testo rivela così che la Chiesa disponeva di un vero e proprio cimitero sotterraneo di cui era proprietaria, al punto che il vescovo di Roma designava la persona destinata a incaricarsene. La proprietà cristiana del luogo era talmente nota che nello stesso cimitero di Callisto vennero arrestati poi, una cinquantina di anni dopo, papa Sisto II con quattro diaconi e successivamente san Lorenzo, anch'egli diacono, nel corso delle persecuzioni di Valeriano nell'anno 258. Il fatto è estremamente interessante perché mostra che l'esigenza di avere proprietà a servizio dei fedeli e l'abbellimento di tali luoghi per le celebrazioni – con la nascita, quindi, dell’arte paleocristiana - sono indipendenti dall'ascesa al potere di Costantino, ma sono piuttosto un'esigenza vitale di una comunità che ha bisogno di spazi comuni e di un'arte con la quale esprimere la propria fede. È a partire dagli affreschi delle catacombe e dalle sculture dei sarcofagi che si andò pian piano elaborando il linguaggio iconografico tipica dell'arte cristiana.
Una errata interpretazione delle fonti antiche ha dato origine alla leggenda che in esse la comunità cristiana trovasse rifugio al tempo delle persecuzioni, celebrandovi l'eucaristia, rimanendo nascosta ai persecutori e finanche soggiornandovi per periodi più lunghi quando il pericolo era maggiore. Il fatto che le catacombe fossero considerate dalla mentalità comune un luogo di rifugio appare come un dato di fatto nei primi scritti di età umanistica e rinascimentale che ne parlano. Esse erano invece ben conosciute dalle autorità romane che, evidentemente, chiudevano un occhio e tolleravano che i cristiani vi si recassero per le sepolture e per le preghiere di intercessione per i defunti. Dalle fonti letterarie, in particolare dalla documentazione sulla crisi donatista, risulta che all'arrivo di Costantino la comunità romana disponesse già di quaranta chiese in superficie: non voleva rimanere nascosta, ma anzi professava pubblicamente la fede anche con il linguaggio dell'arte.
Verissimo è, però, il legame fra le catacombe e i martiri, proprio perché man mano che in esse vi vennero seppelliti i testimoni uccisi per la loro professione di fede in Gesù i cristiani vollero che, intorno a tali sepolture, fossero sepolti anche i loro cari.
2/ Visitando la basilica
San Sebastiano e la memoria dei Santi Pietro e Paolo
La basilica porta oggi il nome di San Sebastiano, perché in essa si venera la sua sepoltura. I primi riferimenti alla figura del martire risalgono al IV secolo, ma notizie più complete, anche se meno attendibili, provengono dalla Passio sancti Sebastiani, della prima metà del V secolo. Sebastiano visse e subì il martirio sotto l'imperatore Diocleziano. Comandante di una coorte, venne condannato a morte perché cristiano. Il sepolcro del santo venne posizionato al centro di una grande cripta e diventò presto oggetto di venerazione.
Per paura di saccheggi a opera dei saraceni – gli arabo-musulmani che, dopo aver saccheggiato tutte le coste della penisola e aver costituito avamposti in vista di una futura conquista più stabile, attaccarono anche Roma, due volte, alla metà del IX secolo - i papi fecero traslare le reliquie del santo prima in Vaticano, nell'826, e successivamente, sotto Leone IV, nella chiesa dei Santi Quattro Coronati. Onorio III nel 1218 fece ritrasferire le spoglie del martire presso l'altare della cripta, situate sotto la basilica. Il cardinale Scipione Borghese e dopo di lui il cardinale Francesco Barberini, restaurando la chiesa in età barocca, diedero la sistemazione attuale alle reliquie che sono ora custodite in una cappella a sinistra della navata centrale, mentre in quella di fronte si venerano la colonna alla quale il santo sarebbe stato legato e una delle frecce del martirio. Nella stessa cappella a destra si venera una pietra che sarebbe l'originale sulla quale Gesù avrebbe lasciato impresso il segno dei suoi piedi quando Pietro gli disse «Domine quo vadis?», mentre nell'omonima chiesa, secondo tale tradizione, sarebbe esposta una copia.
Scendendo nelle catacombe di San Sebastiano il luogo più interessante da visitare è l'area della triclia. Dalla disposizione architettonica si ritiene che si tratti di una zona coperta utilizzata ad confrequentandam memoriam quiescentium. In questi luoghi venivano ricordati i defunti nelle annuali ricorrenze, pregando per essi e consumando piccoli pasti (refrigeria) in loro memoria. Sui pilastri del portico e sul muro, lungo cui corre un sedile, si trovano circa seicento graffiti, risalenti alla seconda metà del terzo secolo, con invocazioni agli apostoli Pietro e Paolo - uno di essi recita, ad esempio, Paule et Petre petite pro Victore.
Un antichissimo documento, la Depositio Martyrum, un catalogo di martiri con la data della loro commemorazione – ripreso poi dal cosiddetto Martirologio Geronimiano – lascia ritenere che nel 258 (si evince la data dal nome dei consoli indicati nel documento stesso),forse poco prima dell'inasprirsi delle persecuzioni con il martirio di papa Sisto, di Lorenzo e degli altri quattro diaconi, la celebrazione della festa di san Pietro si tenesse ad catacumbas, dal toponimo antico del luogo (come si è detto, solo poi il termine catacombe si estese da questo luogo ai diversi ipogei cimiteriali).
Gli studiosi discutono sul perché tale celebrazione avvenisse allora in questo luogo e si ipotizza che, a causa delle persecuzioni, i corpi dei due patroni di Roma fossero stati qui trasferiti per salvarli da eventuali profanazioni. Quel che è certo è che la Chiesa di Roma ha venerato Pietro e Paolo anche presso le catacombe di San Sebastiano, affidandosi alla loro protezione, consapevole che con il loro martirio Dio aveva donato una grazia particolare e unica alla città di Roma. Infatti, un'epigrafe del IV secolo, fatta scolpire da papa Damaso per San Sebastiano, così recitava: «Tu che vai cercando i nomi di Pietro e Paolo sappi che i santi dimorarono qui in passato. Questi Apostoli ce li mandò l'Oriente, lo riconosciamo volentieri, ma in virtù del martirio (seguendo Cristo su per le stelle vennero nelle regioni celesti e nel regno dei giusti) Roma poté rivendicarli suoi cittadini. Questo voleva dire Damaso in vostra lode, o nuove stelle».
Ad un livello più basso della triclia si vedono tre mausolei appartenuti a tre liberti facoltosi, che vennero interrati per i lavori di costruzione del luogo di culto e riscoperti durante scavi nel 1922. Il primo è appartenuto a un certo Marcus Clodius Ermete, il secondo è detto degli Innocentiores, forse un'associazione, il terzo mausoleo è detto dell'Ascia, poiché tale strumento è raffigurato in facciata.
Il Cristo Salvatore del Bernini
Oltre alla Cappella che custodisce le reliquie di San Sebastiano, una visita merita certamente il busto marmoreo raffigurante il Cristo Salvatore che è esposto sulla destra e che è stato recentemente fatto oggetto di studi e definitivamente attribuito a Gian Lorenzo Bernini. È il Salvator mundi, l'ultima opera del maestro, che egli terminò nel 1679, poco prima di morire. Il figlio dell'artista scrisse del padre: «Et adesso... corre l'anno 82 della sua età... con ottima salute havendo operato in marmo sino all'anno 81, quale terminò con un suo Salvatore per sua devotione». Il grande artista, che aveva dominato la scena del tempo, aveva voluto scolpire quel volto prima di morire perché lo accompagnasse negli ultimi momenti della sua vita.
San Filippo Neri e le catacombe di San Sebastiano
Uno dei testimoni al processo di canonizzazione riferì che san Filippo da giovane, ancora laico, «andava spessissime volte, solo, di notte, alle Sette chiese, pernottando nelle dette chiese, et, anco nel cemeterio di Calisto, et, che, quando trovava le chiese serrate, si fermava nelli porticati di dette chiese, a far oratione, et (...) alle volte a leggere qualche libro al lume della luna». L'unica catacomba allora aperta era quella di San Sebastiano e si riteneva, a torto, che essa fosse il cuore del cimitero di Callisto. Si accedeva ai cunicoli da due ingressi posti ai lati della basilica di San Sebastiano.
San Filippo si recava lì, perché quel luogo gli evocava la storia suggestiva delle prime generazioni cristiane, l'eroica professione della fede, la lunga schiera dei martiri, il martirio di Pietro e Paolo. Al cardinale Federico Borromeo, suo amico e penitente, confidò che supplicava «lo Spirito Santo perché gli desse spirito». Nel 1544 ebbe un'esperienza mistica che lo segnò profondamente. Benché l'episodio sia in gran parte avvolto nel mistero («Secretum meum mihi, secretum meum mihi» ripeteva Filippo), diversi testimoni affermano che il santo confidò loro che, mentre pregava presso le catacombe di San Sebastiano, lo Spirito Santo gli dilatò il cuore: «Questo eccesso di cuore la fiamma et lo spirito de Iddio gli soprabbondava talmente che pareva li volesse uscir fuor del petto, non potendosi contener dentro quei termini che la natura gli haveva prefissi».
L’esperienza di San Filippo Neri alle catacombe di San Sebastiano permette di comprendere quale importanza abbia soffermarsi sulla storia della Chiesa e sulle sue grandi figure per vivere una fede matura: Filippo affidò al suo primo successore, Cesare Baronio, di studiare storia della Chiesa proprio per raccontare come il Vangelo di Gesù fosse stato vissuto nei secoli ed equilibrare letture solo negative che taluni protestanti promuovevano a quel tempo.
b/ L’Europa a Roma
7/ Ara Coeli. Unione Europea
1/ Motivi di un pellegrinaggio
Il Campidoglio con i suoi palazzi e con la chiesa dell’Ara Coeli che sorge sul colle è luogo ideale per far memoria dell’Unione Europea innanzitutto perché essa proprio lì ebbe le sue origini storico-politiche.
Infatti, il 25 marzo del 1957, nella Sala degli Orazi e Curiazi in Campidoglio, sei nazioni europee - Francia, Germania Ovest, Italia, Belgio, Olanda e Lussemburgo - firmarono i trattati istitutivi della Comunità Economica Europea (CEE) e della Comunità Europea dell’Energia Atomica (CEEA, o EURATOM). Quegli accordi sono noti come i ‘Trattati di Roma’ e – aggiungendosi alla Comunità Europea del Carbone e dell’Acciaio (CECA), già istituita nel 1951 – rappresentano lo storico atto di nascita della Comunità europea, poi trasformatasi nell’odierna Unione. Il sogno dell’Europa unita, maturato negli animi dopo la II guerra mondiale, prese forma a partire dalla creazione di istituzioni comunitarie per l’integrazione delle economie nazionali e per la messa in comune della ricerca sulla produzione di armi, allo scopo di rendere impensabile il sorgere di una nuova guerra tra Paesi europei. Nel 2004 nella stessa sala in Campidoglio venne firmato il progetto di una Costituzione per l’Europa che poi venne abbandonato dopo i risultati negativi dei referendum in Francia e Paesi Bassi.
Ancora qui nel 2017, sessanta anni dopo i Trattati di Roma, furono non più solo sei, ma ventisette stati membri dell’Unione Europea, dotatasi ormai di un Parlamento, a incontrarsi nuovamente per affermare che quel “sogno di pochi è diventato la speranza di molti”. Nella Dichiarazione comune si affermava che “restare uniti è la migliore opportunità che abbiamo di influenzare le dinamiche mondiali e di difendere i nostri interessi e valori comuni”. Pur senza definire questi valori caratteristici della storia europea e senza nominare alcuna radice di essi, nondimeno si affermava l’esistenza dell’Europa come di una realtà unica al mondo. Si affermava che è bene che i giovani possano studiare e trovare lavoro in tutto il continente, perché “l’Unione preservi il nostro patrimonio culturale e promuova la diversità culturale” – ancora un richiamo a quel patrimonio che unico al mondo rispetta ogni cultura. La Dichiarazione terminava affermando che il cammino futuro doveva avvenire “nel rispetto del principio di sussidiarietà”. Tale principio, anch’esso tipico della storia europea, afferma che, se un ente inferiore è capace di svolgere bene un compito, l'ente superiore non deve intervenire, bensì ne sostiene l'azione: è l’affermazione sia dell’importanza della famiglia che deve essere rispettata e sostenuta nelle sue libere scelte, sia della decisività della società civile e delle sue libere organizzazioni, anche religiose, che è bene siano protette da ogni statalismo: è per questo stesso principio che ogni nazione, come ente “inferiore” all’intera Europa, non deve mai deve essere semplicemente assorbita e disciolta in essa, bensì sostenuta nella sua ricchezza di storia.
Nell’occasione di quel 60esimo anniversario, papa Francesco dichiarò ai diversi capi di Stato europei, citando gli statisti fondatori dell’Europa: «All’origine dell’idea d’Europa vi è “la figura e la responsabilità della persona umana col suo fermento di fraternità evangelica, con la sua volontà di verità e di giustizia acuita da un’esperienza millenaria” (De Gasperi). Roma, con la sua vocazione all’universalità, è il simbolo di questa esperienza e per questo fu scelta come luogo della firma dei Trattati, poiché qui – ricordò il Ministro degli Esteri olandese Luns – “furono gettate le basi politiche, giuridiche e sociali della nostra civiltà”».
Proprio nei Fori, infatti, si incontrarono la cultura classica e la fede cristiana che, insieme, dettero vita all’Europa. Si può immaginare dal Campidoglio ciò che avvenne ad Atene, quando Paolo dialogò con filosofi epicurei e stoici e si richiamò alla poesia e alla filosofia greca, per annunziare il Dio ignoto che si era fatto conoscere.
A partire dal modo in cui venne forgiato il rapporto fra cristianesimo e cultura classica in età apostolica, nei secoli la cultura europea elaborò un atteggiamento che è stato ed è veramente inter-culturale. Molto di ciò che era valido delle esperienze classiche ed ellenistiche venne conservato – si pensi solo al valore della razionalità, della dialettica e del pubblico dibattito, del diritto, della poesia, dell’arte che l’Europa seppe serbare ed anzi coltivare, raccogliendo l’eredità del passato.
Al contempo si operò un rifiuto degli elementi caduchi, ad esempio vennero rifiutati con forza i giochi gladiatori che apparvero per ciò che erano, una vergogna del mondo culturale latino, così come decadde il politeismo che non riscaldava più i cuori. Si iniziò al contempo un processo di liberazione dal disprezzo di cui erano coperti gli schiavi o i bambini malati che venivano esposti.
Nacque, insomma, il discernimento nel rapporto fra le culture e si comprese che la libertà doveva guidare questo libero confronto: la libertà religiosa, che solo lentamente si affermò, portò al desiderio di cercare insieme a tutti la verità sulla vita e su Dio, sempre amandosi e, al contempo, sempre spingendo più in là tale ricerca. Si comprese che ogni cultura è viva perché tende non a fossilizzarsi, ma anzi a spingersi sempre più avanti, in una ricerca che non esclude mai a priori di poter giungere a Dio stesso.
L’amore imparò a misurarsi con quella pienezza di dono di sé che è la croce.
Il “Date a Cesare quel che è di Cesare e a Dio quel che è di Dio” – cioè la scoperta della laicità e insieme di ciò che è indisponibile alla politica, come la sacralità della vita – si pose per la prima volta nella storia come esperienza capace di fecondare culture che non conoscevano tale principio.
Se Roma è assolutamente moderna, proprio perché mostra con le sue rovine che nessun impero, nessun potere, nessuna ideologia, è eterno e il tempo corrode e fa dimenticare tutto, al contempo ricorda quel discernimento che è alla radice di ogni scelta e quel desiderio di pienezza che mai potrà essere soppresso nel cuore degli uomini.
Dall’incontro fra cultura classica e cristianesimo nacque anche quella capacità auto-critica che è anch’essa radice dell’Europa – mentre molte altre religioni e culture ateistiche non conoscono la critica di sé stesse e nemmeno la possibilità di una tale dialettica.
2/ Visitando la basilica
Al tempio di Giunone Moneta, su cui sorge oggi la basilica dell’Aracoeli - così come al tempio delle divinità di Roma, la triade Capitolina, Giove, Giunone e Minerva - si accedeva anticamente tramite la via Sacra, dal lato dei Fori che era il cuore della Roma pagana, lì dove Paolo e Pietro avevano predicato.
Quando venne costruita la basilica dell’Aracoeli, Roma era ormai ridotta ad un decimo dell’urbe imperiale, a causa delle invasioni barbariche, e la città si era ristretta nei rioni che erano dall’altro versante del Campidoglio.
Fu così che si decise di monumentalizzare la salita al Campidoglio dall’altro versante. Fu Cola di Rienzo, nel 1348, a volere la scalinata attuale dell’Aracoeli, dopo aver fatto voto di realizzarla se Roma fosse stata divinamente risparmiata dall’epidemia di peste. Il Risorgimento volle una sua statua, al fianco della scalinata, perché lo idealizzo quale non fu, come eroe antesignano di una città anticlericale.
In realtà, in età avignonese, quando il pontefice risiedeva lontano dall’urbe. Cola di Rienzo si fece eleggere tribuno, condividendo il potere con il vicario del papa, e cercò di promuovere il giubileo del 1350, per richiamare i pellegrini in Roma. Ma il potere gli dette alla testa e iniziò a desiderare di essere consacrato imperatore, finché i nobili, il popolo e lo stesso potere pontificio lo condannarono. Fuggito ad Avignone, fu assolto dal papa e accompagnò il cardinale Albornoz, inviato in Italia dal papa per riprendere il controllo dei territori dello Stato Pontificio. Salito nuovamente al potere, inasprì lo scontro con la popolazione romana dando corso a vendette per il precedente esilio e aumentando le tasse, finché il popolo non si ribellò e lo uccise nel 1354, proprio ai piedi della scalinata, consegnandone poi il corpo ai Colonna.
A sinistra della basilica era il convento e la Torre di Paolo III che vennero abbattuti quando il nuovo Regno d’Italia decise di realizzare il Vittoriano. La fredda costruzione sul fianco sinistro della basilica è dedicata al re d’Italia Vittorio Emanuele II in quanto “padre della patria”. Per istillare ancor più sentimenti patriottici, nello stesso monumento venne anche posta nel 1921 la salma del Milite ignoto, a rappresentare tutti i caduti italiani della I guerra mondiale. Il Vittoriano è notoriamente un’opera non riuscita, poiché venne concepito a rappresentare l’Italia, ma solo a partire da simboli che non provenivano dalla ricchezza della tradizione del paese.
Sei gruppi scultorei rappresentano La forza, La concordia, Il pensiero, L’Azione, Il sacrificio e Il Diritto, mentre più in alto sono La Politica e La Filosofia da un lato e La Rivoluzione e La Guerra dall’altro e ancora più in alto stanno le raffigurazioni dell’Architettura, della Musica, della Pittura e della Scultura.
Se si guarda però agli stemmi dei diversi Comuni Italiani, che sono alla base del cavallo del sovrano, lì si ritrovano i simboli della fede cristiana, perché dove è la vita vera delle città italiane, lì la storia ne è intrisa: si vedono, ad esempio, il Leone di San Marco di Venezia o il simbolo della Croce nelle raffigurazioni di Genova e di Milano.
Sulla destra della basilica, invece, la magnifica piazza del Campidoglio è chiusa dal Palazzo Senatorio che è, forse, il più antico municipio d’Italia, sede degli organismi comunali fin dal 1144. Esso venne costruito sull’antico Tabularium che raccoglieva i dati relativi ai cittadini di ogni luogo dell’Impero. La piazza venne ristrutturata in forme rinascimentali da Michelangelo e poi da Giacomo Della Porta con la costruzione del Palazzo dei Conservatori e del Palazzo Nuovo e con la sistemazione al centro della statua di Marco Aurelio, che idealmente vuole creare un ponte fra la civiltà classica e i secoli successivi, di modo che il Rinascimento si dichiara erede non solo del cristianesimo, ma anche della sapienza greco-romana.
La facciata dell’Ara Coeli è rimasta incompiuta e risale agli anni 1285-1287, al momento cioè nel quale i francescani furono invitati a ricostruire la chiesa: la riedificarono con una pianta più grande della precedente, divenuta monastero benedettino, che doveva avere la grandezza dell’attuale transetto.
All’interno è evidente che la basilica è edificata con materiale di spoglio, come avviene sovente nel XIII secolo – è il motivo per il quale il Rinascimento vorrà cancellare gli edifici medioevali per la loro non uniformità e “classicità”.
La terza colonna di sinistra ha un foro che sarebbe stato prodotto, secondo la leggenda, dal raggio luminosissimo che avrebbe colpito Augusto in occasione della rivelazione divina a lui riservata, quando gli sarebbe apparsa la Vergine per annunciargli la nascita del Bambino Gesù: per tale leggenda i medioevali ritenevano che sul sito ove sorge la basilica fosse il suo cubiculum, la sua camera privata, e, infatti, scolpirono sulla colonna le parole “a cubiculo Augustorum” (“dalla stanza da letto degli Augusti”). Fu per questa tradizione che il nome della chiesa, che precedentemente era quello di Santa Maria in Campidoglio, venne mutato in quello di Santa Maria in Aracoeli.
Sull’altare centrale è l’icona della Madonna alla quale fu attribuita la salvezza dalla peste nel 1348, quella per la quale Cola di Rienzo salì, con il popolo al seguito, al Campidoglio per ringraziare la Vergine, quando venne eretta la scalinata.
L’antica icona è della metà dell’XI secolo, copia di una precedente Madonna detta di San Sisto, che era probabilmente del VI secolo. La leggenda attribuisce entrambe le immagini all’evangelista Luca, ritenuto da sempre pittore della Vergine per aver raccontato nei primi due capitoli del suo vangelo le storie di Maria e del suo Bambino. L’icona era posta in origine nel transetto sinistro e per l’altare centrale Raffaello dipinse la cosiddetta Madonna di Foligno, che è ora ai Musei Vaticani, su commissione della famiglia Conti, a motivo di una grazia ricevuta. Fu Pio IV (1559-1565) a volere questa immagine più antica e più venerata sull’altare maggiore.
Il soffitto a cassettoni (1572-1575) venne invece realizzato al tempo di Pio V per volere del Senato, come ringraziamento pr la vittoria di Lepanto del 1571 attribuita all’intercessione della Vergine che, secondo la tradizione, ne portò notizia allo stesso pontefice nella villa oggi nota come di Casale San Pio V e sede universitaria: l'ammiraglio Marcantonio Colonna, condottiero di quella battaglia importante per l’Europa, qui celebrò il suo trionfo.
A fianco dell’icona si vede una lampada con l’iscrizione del Comune di Roma, SPQR, proprio perché, a motivo della presenza in Campidoglio del Palazzo Senatorio, la basilica divenne la chiesa del Senato e del Popolo Romano. Per tutto il medioevo servì come aula delle adunanze del Consiglio Maggiore e Minore del Comune, per la discussione e la promulgazione delle leggi della città e, tuttora, è la chiesa dove si svolgono liturgie che riguardano personalità di Roma e del suo Comune.
La prima cappella a destra è la più bella della basilica: è la cappella Bufalini, affrescata dal Pinturicchio (Bernardino di Betto) con le storie di san Bernardino da Siena.
Gli affreschi sono del 1485 circa, in pieno Rinascimento.
San Bernardino visse nella prima parte del 1400 e dimorò come frate nel convento dell’Aracoeli. Si vede nella volta il trigramma IHS - da lui reso famoso con la predicazione -, che vuol dire Iesus Hominum Salvator (Gesù Salvatore degli uomini): esso sarà ripreso infinite volte, divenendo simbolo anche per Ignazio di Loyola che lo fece porre nelle chiese gesuitiche e, in età moderna, da Antoni Gaudí, ad esempio nella casa Batlló a Barcellona, che voleva sempre segni della fede cristiana anche nelle sue costruzioni civili. San Bernardino predicava avendo sempre in mano una tavoletta con il trigramma, quasi un “logo” che evidenziasse che Cristo è il Salvatore.
Il Pinturicchio dipinse sulla parete di fondo san Bernardino al centro, il quale, con il dito, indica in alto Cristo che è nella mandorla, segno di eternità. Nel libro è l’iscrizione: Pater manifestavi Nomen Tuum Omnibus, “Padre, ho manifestato il tuo nome a tutti”. Due angeli lo incoronano. Al suo fianco sono due santi francescani, san Ludovico da Tolosa e sant’Antonio da Padova.
Bernardino non solo annunciava il nome del Cristo, ma sapeva al contempo richiamare ai doveri civili. Come emblema di questo, i Bufalini vollero che Pinturicchio dipingesse insieme alla figura del santo anche la lotta fra la loro famiglia, che era di Città di Castello, e quella dei Baglioni, che era di Perugia. Si vedono i guerrieri delle due fazioni combattersi nelle piccole figure dipinte nella montagna, a sinistra dei tre santi. Fu solo san Bernardino che riuscì a pacificare le due famiglie rivali. La scena è rappresentata proprio perché fu la famiglia Bufalini a commissionare gli affreschi della cappella – incredibile è che Pinturicchio dipinse anche a Spello, per la famiglia rivale, gli affreschi della famosa Cappella Baglioni.
Di questa ricerca della pace civile, voluta dai santi nella storia, è erede l’Europa.
Sulla parete di destra, invece, sono tre scene. Nella prima si vede Bernardino che, come san Francesco, si spoglia, ricevendo le nuove vesti, mentre in alto è Dio Padre e, al di sotto del cornicione, la Madonna con il Bambino.
Al centro della parete è come se si aprisse una finestra che lascia intravedere figure che osservano chi visita la cappella, coinvolgendoli nell’opera.
A destra della parete, invece, è la raffigurazione delle stimmate di san Francesco.
Nella parete di sinistra è la scena più famosa, con la morte e la sepoltura di Bernardino. Il primo personaggio a sinistra, con la candela in mano, è il Bufalini. Intorno sono personaggi del tempo e sullo sfondo, vicino ai portici dipinti, si vedono alcuni miracoli del Santo.
Nella lunetta, invece, è il santo giovane che prega in solitudine, presso Porta Tufi di Siena, mentre la folla lo addita a distanza.
Nella navata sinistra, merita una visita almeno la quinta cappella di sinistra.
Essa è intitolata ai della Valle e Filippo della Valle vi è rappresentato, nel sepolcro alla parte sinistra, con ai piedi e al capo del letto dei libri - un modo per sottolineare il binomio fede-cultura tipico del Rinascimento e, più in generale, dell’Europa stessa.
La cappella conserva gli affreschi sulla vita di San Paolo del Pomarancio (Cristoforo Roncalli), completati entro il 1586, nel passaggio tra manierismo e barocco.
In alto il Pomarancio ha dipinto il Cristo salvatore che si manifesta.
Nella lunetta a sinistra, in alto, è la scena della conversione di Saulo, rappresentata come in tutta l’iconografia paolina con la caduta da cavallo. Paolo, vestito da romano, viene disarcionato e cade rovinosamente a gambe divaricate; in questa iconografia drammatica si esprime tutta la novità del l’incontro con il Cristo.
Nell’altra lunetta, a destra, è il battesimo di san Paolo. Non basta che san Paolo si converta, ma deve accogliere sacramentalmente la grazia.
Nell’affresco sotto la lunetta di sinistra è rappresentata la scena dell’Areopago: Paolo è al centro, circondato da filosofi pagani: l’apostolo è raffigurato mentre indica in alto Dio, rivelando il Dio ignoto, ormai manifesto in Cristo. Di nuovo è l’attestazione dell’incontro fra fede cristiana e cultura classica.
Nell’affresco sotto la lunetta di destra è il martirio di Paolo.
Più avanti, nel transetto di sinistra, è la cappella che custodisce le reliquie di Santa Elena imperatrice, la madre di Costantino: la primitiva sepoltura era nel mausoleo imperiale, oggi detto di Tor Pignattara, sulla via Casilina, ma esse vennero infine trasportate in basilica nel XII secolo.
La sistemazione medioevale del sepolcro di Elena venne modificata nel 1605, ma tutto venne poi distrutto dai francesi rivoluzionari nel 1798, quando la chiesa venne da loro trasformata in una stalla per i cavalli dei militari. Venne poi ricostruita nel 1833, nella forma di un’edicola con otto colonnine con cupola cui fa da altare un’urna con i resti della santa. In basso si intravede l’antico Altare medioevale detto di Augusto o dell’Ara Coeli, della seconda metà del XII secolo, con la visione della Madonna con il Bambino che appare all’imperatore e con l’Agnus Dei.
Dal transetto sinistro si accede alla Cappella di Gesù Bambino. Lì è la veneratissima statuetta di Gesù Bambino detta anche Santo Bambino, della fine del XV secolo. Secondo la tradizione venne scolpita da un anonimo frate francescano a Gerusalemme, utilizzando il legno d'ulivo del Getsemani, e venne poi immersa nel Giordano. È ritenuta miracolosa ed è ricoperta di numerosi ex voto. Nella cappella sono anche conservate lettere che i bambini di tutto il mondo scrivono al Bambino Gesù. L’originale venne trafugato nel 1994 e oggi si venera una copia.
Dietro il pilastro dell’ambone sta un’altra memoria dell’unità d’Europa, la tomba dell’ultima regina di Bosnia: la Beata Caterina, terziaria francescana. Nata in Erzegovina nel 1424, sposò il penultimo re di Bosnia e chiamò i francescani nella capitale, per contrastare gli eretici di matrice manichea. Quando i turchi conquistarono il regno, Caterina fu esiliata a Roma dove l’accolse papa Pio II, diventando terziaria francescana. Nel testamento dispose che fosse lasciato alla Chiesa il suo regno, con la clausola che se il figlio Sigismondo, fatto prigioniero dai turchi e costretto alla conversione, fosse stato liberato e fosse tornato al cristianesimo, egli divenisse nuovo re di Bosnia.
Nel transetto di destra sono, invece, conservate le reliquie di uno dei compagni di Francesco, san Ginepro, in latino Juniperus. Frate Ginepro fu presente alla morte di santa Chiara: la santa e lo stesso san Francesco lo chiamavano “giullare di Dio”, poiché egli era disposto a tutto per la gloria di Dio, come quando si denudò in segno di penitenza camminando senza vesti per Viterbo, o come quando tagliò la zampa ad un porco perché un confratello malato ne aveva fatto richiesta per nutrirsi alla Porziuncola – nel piccolo bassorilievo bronzeo lo si vede proprio con lo “zampone” nella sua bisaccia - o come quando spogliò un altare per aiutare una persona in difficoltà.
La settima cappella a destra è oggi dedicata a san Pasquale Baylon, ma era un tempo dedicata a san Giovanni Battista. La decorazione attuale ha cancellato l’originaria decorazione del tempo della costruzione della chiesa. Nell’anno 2000 i restauri hanno riportato alla luce sull’altare centrale una meravigliosa Madonna tra san Giovanni Battista e san Giovanni evangelista, datata intorno al 1290 e forse di mano del Cavallini o comunque di un pittore romano che aveva già il gusto di una pittura più umanistica. Ai lati, in alto, si riconoscono alcuni lacerti della stessa mano: si sono, infatti, conservate solo le sommità dei dipinti e si intuisce che a sinistra doveva essere raffigurato il banchetto di Erode, nel momento in cui veniva portata su di un piatto la testa del Battista, mentre a destra era probabilmente rappresentata la scena della morte di Giovanni Evangelista. Gli affreschi ritrovati forniscono argomenti a chi crede che il rinnovamento trecentesco della pittura non ebbe inizio con Giotto e con i toscani, bensì a Roma, con i pittori legati al pontefice, passati poi ad affrescare la basilica di Assisi.
8/ Santa Maria degli Angeli e dei Martiri. Italia
1/ Motivi di un pellegrinaggio
Il legame fra l’Italia e Santa Maria degli Angeli e dei Martiri nacque immediatamente, subito dopo l’Unità d’Italia. Innanzitutto per motivi urbanistici. La chiesa è, infatti, al culmine del tragitto della nuova via Nazionale – il nome dell’arteria è significativo – che venne inaugurata ufficialmente nel 1878 con lo scopo di congiungere il centro della città alla stazione ferroviaria. Quando poi venne realizzato il Vittoriano ecco che esso fu visibile dalla piazza antistante la basilica.
Intorno a via Nazionale avvenne la prima urbanizzazione del nuovo Stato con la costruzione, ad esempio, del Palazzo delle Esposizioni Nazionali di Belle Arti (1883), del Teatro Eliseo (1900), di Palazzo Koch, sede della Banca d'Italia (1892), ma anche della prima chiesa anglicana nell’urbe, la Chiesa di San Paolo dentro le Mura (1880). Inoltre via Nazionale corre quasi parallela all’antica via Pia, che oggi porta il nome prima di via del Quirinale e più avanti di via XX settembre, il giorno della presa di Roma: voluta da Pio IV unitamente a Porta Pia che porta il suo nome venne poi scelta dal Regno d’Italia per la realizzazione di grandi edifici per i diversi Ministeri, quando il re occupò per abitarvi quella che era la residenza dei pontefici fino a quel momento, il Quirinale.
Insomma, Santa Maria degli Angeli era nella posizione ideale per le celebrazioni che si fossero rese necessarie nella nuova nazione.
Lì si tennero le principali celebrazioni liturgiche dei reali – ad esempio, nel 1896 vi si svolse il matrimonio fra il futuro Vittorio Emanuele III e la futura regina Elena di Montenegro - e lì venne sepolto il maresciallo Diaz, capo di Stato Maggiore nel corso della I guerra mondiale. Lì, in conseguenza, è tradizione che si tengano anche le celebrazioni riguardanti la Repubblica Italiana – si pensi solo al funerale dei soldati italiani uccisi nell’attentato di Nāṣiriya.
Ma quella basilica, nella quale di fatto si sono incontrate in Roma fin dall’Unità d’Italia le autorità italiane e la Chiesa, dice anche dello stabilirsi di un nuovo rapporto che ha avuto necessità di decenni per maturare.
Le due parti non erano pronte ancora quando, proprio lì vicino, a Porta Pia, la storia del paese cambiò, anche se non si deve dimenticare che già allora esisteva, al di là delle apparenze, un rapporto vero: si pensi solo al fatto che le truppe del Regno ebbero l’ordine di non oltrepassare Castel Sant’Angelo e lo fecero solo quando il pontefice ne fece espressa richiesta al re, tra il 20 e il 21 settembre 1870, per tenere sotto controllo la zona del Colonnato dove sarebbero potuti sorgere tumulti, o ancora al fatto che nelle ore successive alla Presa di Roma Pio IX offrì l’Ospedale di Santo Spirito in Sassia per la cura dei soldati italiani feriti nell’attacco contro di lui.
Le due parti non erano pronte perché, da un lato, il pontefice non poteva forse comprendere subito che era la provvidenza a liberarlo dal gravoso compito di guidare uno Stato. Infatti, se era stato necessario farsi carico del potere politico nell’alto medioevo per non veder rovinare la civiltà romana, d’altro canto ora era necessario e benefico rinunciarvi.
Dall’altro, le autorità italiane non compresero subito che non era bene che il pontefice diventasse un cittadino del nuovo Stato, senza autonomia, poiché la sua voce si doveva levare per tutti i popoli e non doveva essere identificata con quella di una nazione. Ciò fu evidente quando il papa Benedetto XIV dichiarò l’inutilità della I guerra mondiale, ma il Regno d’Italia protestò, perché, considerandolo solo un cittadino italiano, riteneva che non avrebbe dovuto opporsi alle scelte nazionali, mentre il papa si rivolgeva a tutti, in quanto padre di tutti i belligeranti, invocando la pace.
Solo col tempo il pontefice capì che il vecchio Stato Pontificio, territorialmente più esteso, era un ostacolo alla propria missione e che, invece, come disse papa Pio XI nel giorno in cui fu stipulato il Concordato, era più utile storicamente solo un territorio piccolissimo: «Ci pare di vedere le cose al punto in cui erano in San Francesco benedetto: quel tanto di corpo che bastava per tenersi unita l’anima». Proprio quel lembo di terra rese possibile l’indipendenza del papa in occasione dell’occupazione nazista di Roma, nel corso della II guerra mondiale.
D’altro canto, solo col tempo lo Stato italiano comprese che la presenza del pontefice in Roma conferiva prestigio alla nazione ed era elemento prezioso per la politica internazionale assicurare l’indipendenza del Vaticano.
La Chiesa imparò il pieno rispetto della laicità e la Nazione che la laicità non è laicismo: la Chiesa assicurò il rispetto della piena indipendenza della politica democratica, lo Stato che la Chiesa è una delle realtà comunitarie della nazione che contribuisce proprio con i propri punti di vista al libero dibattito.
2/ Visitando la basilica
L’esperienza che si compie entrando in Santa Maria degli Angeli è quella di entrare in architetture originate quasi due millenni fa e ancora in piedi.
Infatti, la facciata della chiesa e il transetto conservano esattamente l’assetto che avevano quando Diocleziano fece erigere quelle murature come parti del complesso termale più grande che Roma abbia avuto e che porta appunto il suo nome.
Fu Michelangelo che volle progettarla lasciando in vista le antiche strutture romane.
L’ingresso avviene oggi tramite una delle absidi dell’antico calidarium e la grande aula del transetto è la sala dell’antico tepidarium delle terme – anche se la precisa disposizione delle diverse zone termali è discussa. La facciata era stata abbellita dal Vanvitelli nel 1749, ma si decise poi di riportare in vista le murature originarie proprio perché fosse da subito evidente che si trattava di un riutilizzo di un edificio romano antico.
Le terme giacevano da secoli in abbandono e la zona era, pur all’interno delle mura, in campagna, quando eventi concomitanti portarono al riutilizzo. Innanzitutto iniziò una nuova urbanizzazione della zona con l’edificazione di via Pia da parte di Pio IV, in secondo luogo nel 1561 proprio Pio IV affidò a Michelangelo la nuova costruzione dopo che un sacerdote siciliano, Antonio Lo Duca, ebbe una visione che lo incoraggiava a dedicare quell’antico luogo ai sette Arcangeli e i certosini accettarono di erigere e poi officiare una Certosa in quel luogo.
Anche il riutilizzo delle Terme di Diocleziano conferma, a suo modo, quanto si sa del passaggio dall’età imperiale al medioevo: quando, a motivo delle invasioni barbariche, nove decimi dell’urbe restarono disabitati, tutto venne reimpiegato per la fortificazione delle mura, per gli acquedotti, per case, per torri, per chiese, salvandosi solo i templi che vennero trasformati in chiese e talune strutture più lontane dal centro, come appunto le Terme di Diocleziano.
La chiesa venne così progettata come il luogo di culto dell’intera comunità monastica certosina che nel frattempo, costruiva il suo monastero. Per rendersi conto della bellezza del luogo pensato dai monaci bisogna oggi recarsi all’interno del Museo Nazionale Romano Terme di Diocleziano – è la sezione epigrafica del Museo - per vedere l’antico chiostro sul quale affacciavano le celle. I certosini vivevano e vivono in solitudine, coltivando ognuno il proprio orto, e tali celle sono ancora visibili chiaramente dall’esterno, lungo via Cernaia.
Come molte delle chiese di Roma la Certosa visse una duplice soppressione, la prima durante l’occupazione francese, la seconda con la Presa di Roma.
Infatti nel 1812 la Certosa venne requisita dalle truppe francesi in Roma e fu usata come caserma; l’ordine superiore del chiostro venne adibito a magazzino per il foraggio degli animali. I Certosini vi tornarono dopo il Congresso di Vienna e nel 1835 riportarono il coro nell’abside della Chiesa.
Ma, all’Unità d’Italia giunse la seconda soppressione. Nel 1870 il municipio di Roma decise un utilizzo militare del luogo e il chiostro del monastero servì a magazzino militare.
Nel 1884 la Certosa fu definitivamente soppressa, vi si installò l’Ospizio Margherita di Savoia per i Poveri Ciechi, ma alcune zone vennero anche affittate come botteghe, magazzini e osterie.
Nel Novecento, poi, essa fu trasformata in Museo e tale è tuttora il suo utilizzo, mentre la chiesa monastica divenne parrocchia.
Entrando oggi nella basilica, si attraverso innanzitutto il vestibolo, in una struttura immediatamente contigua all’antico calidarium, ristrutturato da Jacopo Del Duca, forse su disegno Michelangelo, dove sono sepolti Carlo Maratta e Salvator Rosa.
Il transetto, mantenuto nel soffitto da Michelangelo nelle sue fattezze romane, venne ristrutturato quando Benedetto XIII nel 1727 donò alla basilica diverse grandi tale già dipinte per la basilica di San Pietro che vennero sostituiti con copie in mosaico.
In particolare, nel transetto destro, a partire dalla parete di destra sono
-la Crocifissione di San Pietro, di Nicolò Ricciolini (1687-1772).
-la Caduta di Simon Mago, di Pierre Charles Trémolières (1703-39)
-il Miracolo di San Pietro (forse una Resurrezione di Tabita), di Francesco Mancini (1679-1758)
-la Predica di San Girolamo, di Girolamo Muziano (1528-92)
Nel sinistro, invece, a partire dalla parete sinistra
-la Messa di San Basilio, di Pierre Subleyras (1699-1749)
-la Caduta di Simon Mago, di Pompeo Batoni (1708-87)
-l’Immacolata, di Pietro Bianchi (1679-1740)
-la Resurrezione di Tabita, di Placido Costanzi (1702-59)
Il ripetersi dei soggetti, così come la non organicità della loro disposizione, dipende dal loro essere stati pensati per le diverse cappelle della basilica del principe degli apostoli.
Sopra la controfacciata del transetto è, invece, la Cacciata di Adamo ed Eva del Trevisani.
In fondo al transetto a destra è la Cappella Albergati, con la pala d’altare dipinta da Ercole Graziani con Un miracolo del beato Niccolò Albergati, certosino e poi vescovo di Bologna e cardinale, e, a fianco, due tele di Francesco Trevisani, Battesimo d'acqua e Battesimo di desiderio.
In fondo al transetto a sinistra è, invece, la Cappella di San Bruno, fondatore dei Certosini nell’XI secolo, decorata illusionisticamente da Carlo Maratta, con la pala d’altare che è invece di Giovanni Odazzi: rappresenta l’apparizione della Vergine che porge a San Bruno la Regola dei Certosini, mentre si vede San Pietro – a rappresentare la Chiesa, che osserva.
Originariamente alle due cappelle corrispondevano invece due porte di accesso, come è evidente dall’esterno.
Sul fondo del presbiterio è posta l’icona della Madonna degli Angeli che Antonio Lo Duca fece realizzare a Venezia nel 1543 ed è dello stile di Lorenzo Lotto. La Madonna sta allattando il Bambino Gesù, mentre intorno gli arcangeli sorreggono cartigli con i loro compiti. Michele victoriosus, Raffaele medicus, Jeudiele, remunerator, Sealtiele, orator, Gabriele, nuncius, Barachiele, adjutor, Uriele, fortis socius.
Alla memoria degli angeli venne aggiunta quella dei martiri cristiani dell’età di Diocleziano che dette inizio all’ultima grande persecuzione contro i cristiani prima di Costantino. In particolare, in Santa Maria degli Angeli e dei Martiri, se ne ricordano sette che, secondo la tradizione, vennero impiegati nella costruzione delle Terme e poi martirizzati: Ciriaco, Largo, Marcellino, Saturnino, Sisinnio, Smaragdo, Trasone.
Alle pareti del presbiterio sono, invece, quattro opere provenienti anch’esse dalla basilica Vaticana:
-Presentazione di Maria al tempio, di Giovanni Francesco Romanelli.
-Martirio di San Sebastiano, del Domenichino
-Battesimo di Gesù, di Carlo Maratta
-Morte di Anania e Saffira, del Pomarancio
Una meridiana doppia, costruita da Francesco Bianchini nel 1702, che servì a regolare gli orologi di Roma fino al 1846, si trova sul pavimento del transetto ed è studiata in tutto il mondo.
9/ Chiesa del Martirio di San Paolo. Malta
1/ Motivi di un pellegrinaggio
«Decapitarono Paolo presso il fondo delle Acque Salvie, vicino all’albero del pino». Così recita il testo apocrifo degli Atti di Pietro e Paolo, scritto fra il V ed il VII secolo. Acquae Salviae è un toponimo che ricorda la gens Salvia (il cui rappresentante più famoso è l’imperatore Marco Salvio Otone che regnò per un brevissimo periodo nell’anno 69 d.C.) che poteva avere avuto il possesso di quei terreni, oppure una sorgente d’acqua ritenuta “salvifica” in età romana, a motivo di una particolare presenza benedicente di divinità pagane.
Solo successivamente il luogo prese il nome delle “Tre fontane”, quando si volle sottolineare la triplice sorgente d’acqua miracolosa sorta al contatto con il capo dell’apostolo decapitato, nella quale, al di là dell’oggettività del fatto, è da vedere la verità che già Tertulliano aveva enunziato: «Sanguis martyrum, semen christianorum», il sangue dei martiri è il seme che dà la vita a nuovi cristiani.
I cristiani di Roma - e non solo loro - debbono la loro fede e sono debitori di quella sorgente che irriga i loro cuori abbeverandoli alla testimonianza di Pietro e Paolo.
Il martirio è l’espressione più alta della testimonianza. Il testimone è colui che non indica sé stesso, ma piuttosto il Cristo in cui crede, invitando a guardare a lui come al Signore della vita e della storia. La convinzione che il martire ha della verità e della bellezza del Cristo è così grande che egli non esita ad offrire la stessa vita come suprema attestazione della propria certezza e del proprio amore.
Il nostro tempo, proprio perché erede del cristianesimo, è particolarmente sensibile all’autenticità ed alla trasparenza di ciò che è nel cuore dell’uomo. La testimonianza del martirio è, in questa prospettiva, una delle forme più alte di comunicazione inter-personale. Il martire accetta di essere conosciuto nell’intimo, permette a tutti di avere accesso alla sua profonda convinzione di fede: l’amore di Cristo non può essere rinnegato e non c’è alcuna cosa, neanche la stessa vita, che è più importante della fedeltà al Signore in cui si è creduto.
Più volte Paolo utilizza un’espressione che sconcerta, e, insieme, conquista ed affascina: il “mio Dio”, il “mio vangelo” - così l’apostolo afferma più volte. La fede gli è così intima che, certo, è di tutta la chiesa, ma al contempo è totalmente sua, gli appartiene pienamente.
Rifiutare all’altro di conoscere la fede che si ha nel cuore è come negargli di conoscere in profondità noi stessi. È proprio per questo che è così difficile e, insieme, così bello giungere ad una intimità che condivide la fede. Paolo, nella nudità del martirio, permette ad ogni uomo di leggere nel suo cuore, consente a tutti di contemplare la sua fiducia ed il suo amore per Cristo. Ed egli è consapevole di questo. Più volte aveva ricordato ai cristiani nelle sue lettere che l’unico culto gradito a Dio è quello del cuore e della vita, quello in cui si offre il proprio corpo, la propria stessa vita, trasformando così radicalmente la concezione del culto propria dell’antichità: «Vi esorto, fratelli, a offrire i vostri corpi come sacrificio vivente, santo e gradito a Dio; è questo il vostro culto spirituale» (Rm 12,1-2), o ancora «Mi è testimone Dio, al quale rendo culto nel mio spirito annunciando il vangelo del Figlio suo» (Rm 1,9).
Nel martirio egli vive questa offerta nella sua radicalità più totale, fino all’offerta del sangue, come aveva scritto: «Se io devo essere versato sul sacrificio e sull’offerta della vostra fede, sono contento e ne godo con tutti voi. Allo stesso modo anche voi godetene e rallegratevi con me» (Fil 2,17). Questo dono di sé per continuare a parlare di Cristo diviene l’acqua che disseta la nostra vita.
È significativo che il luogo del martirio di Paolo sia un luogo nascosto: anzi proprio questa sua marginalità rispetto alla città – era un luogo senza importanza alcuna in precedenza – è il motivo che dà credibilità alla tradizione che proprio lì Paolo sia stato martirizzato, sebbene tale memoria non risalga oltre gli inizi del VII secolo, quando papa Gregorio Magno volle legare il luogo all’abbazia di San Paolo fuori le Mura.
Colui che fu notissimo al mondo, colui che visse per decenni sotto i riflettori della storia, colui che percorse l’impero per annunciare il nome di Cristo, accettò poi di morire lontano dagli occhi degli uomini, poiché ciò che conta nella vita non è la visibilità, ma l’autenticità.
2/ Visitando la chiesa
Si giunge alla chiesa di San Paolo, percorrendo un breve viale alberato, che inizia dopo il piazzale il quale sorgono la meravigliosa abbazia dei Santi Vincenzo e Anastasio – uno dei primissimi complessi della riforma cistercense, voluta dallo stesso Bernardo di Chiaravalle che vi abitò più volte -, e la chiesa di Santa Maria Scala Cœli, coeva della chiesa del Martirio di San Paolo – la chiesa della Scala Cœli, originariamente dedicata ai martiri Senone e compagni ricevette il nuovo nome, poiché vi celebrò San Bernardo di Chiaravalle e vide in estasi i defunti che dal Purgatorio salivano in Paradiso a motivo dell’eucarestia offerta per loro.
Il silenzio del viale permette di immaginare gli ultimi momenti della vita di Paolo, dinanzi allo spalancarsi dell’eternità, dopo gli innumerevoli spostamenti dell’apostolo, fino al suo naufragio a Malta e la successiva partenza per la penisola italiana, subito prima di giungere a Roma, raccogliendo l’intera sua vita.
La chiesa attuale venne interamente ricostruita in vista del Giubileo dell’anno 1600. Infatti, a partire dall’anno precedente venne abbattuta la precedente costruzione, della quale non è possibile un’indagine accurata, ma esistono solo notizie nelle fonti scritte. La primitiva chiesa doveva esistere almeno a partire dalla fine del VII secolo, poiché diverse iscrizioni funerarie recuperate risalgono a quel periodo, specificamente al periodo di papa Sergio I (687-701).
Fu il cardinale Pietro Aldobrandini a volere l’edificazione della nuova chiesa il cui progetto venne affidato a Giacomo della Porta. Secondo il gusto barocco, che andava già maturando riempiendo la città di angeli e santi anche all’esterno delle chiese, due statue di Pietro e Paolo vennero poste in facciata, ad opera di Ippolito Buzio.
L’originario impianto era, secondo lo stile del tempo, molto più sobrio dell’attuale e la chiesa è stata modificata con l’aggiunta di interventi che ne hanno turbato la purezza originaria.
Dal vestibolo si accede alla navata vera e propria che è distribuita in orizzontale per dare rilievo alle edicole con le tre sorgenti d’acqua che sarebbero sgorgate quando il capo di san Paolo decapitato rotolò a terra: il miracolo della triplice sorgente sgorgata miracolosamente dice esattamente la fecondità del martirio. L’acqua che correva presso i tre altari è oggi stata forzatamente interrotta.
Sul lato sinistro, quello più in alto, è la reliquia della colonna sulla quale Paolo avrebbe posato il capo al momento della decapitazione.
Il cardinal Aldobrandini fece anche realizzare due tele famose, oggi sostituite da copie molto rovinate, con il martirio dei due apostoli.
Nell’abside di destra quella con il Martirio di Paolo e il miracolo delle tre fonti dipinta nel 1604-1605 da Passerotto de’ Passerotti e molto rovinata, che raffigura lo sgorgare di latte dopo la decapitazione dell’apostolo, secondo un’ulteriore tradizione, e l’irrompere di una luce che tutto illumina, immagini del bene che Dio dona attraverso i martiri.
All’estremo opposto è una copia del famoso Martirio di Pietro, anch’essa del 1604-1605. Fra le prime opere del maestro in Roma, vi appare evidente il confronto con Caravaggio: entrambi dipingono non Pietro già crocifisso, ma il momento in cui egli viene issato sulla croce, qui da parte di due carnefici, mentre un terzo è pronto ad inchiodarne i piedi. Fonti antiche (Malvasia e Passeri) vogliono che il Merisi abbia cercato di sfregiare la tela del rivale e che addirittura intendesse sfidarlo a duello per avergli rubato la commissione ed aver ripreso il suo stile, mentre Reni assicurava di aver voluto imitare lo stile del Caravaggio per ammirazione. L’opera venne trasferita in Quirinale a fine settecento, presso il Palazzo allora dei Papi, per impedire che l’umidità la rovinasse, e lì venne derubata dalle truppe francesi rivoluzionarie che la portarono al Louvre, finché l’opera venne recuperata dopo il Congresso di Vienna e posta, dove tutt’oggi si trova, presso i Musei Vaticani.
Fu poi Pio XII ad aggiungere il mosaico di origine romana con le immagini delle quattro stagioni, qui trasportato dagli scavi di Ostia antica, e i due bassorilievi con il martirio Di San Paolo e quello di San Pietro nel vestibolo.
L’originaria semplicità barocca fu definitivamente modificata con l’aggiunta delle pitture novecentesche, come quella del Trasporto del corpo di San Paolo al sepolcro nella lunetta della controfacciata, quella con il Martirio di San Paolo nella parte absidale – dove si ripete la luce abbagliante con il carnefice che si copre il capo, mentre è presente il pino sotto il quale Paolo sarebbe stato martirizzato e sono rappresentate tre discepole dell’apostolo, Lucina, Basilissa e Anastasia che lo avrebbero seguito fono al luogo del martirio e i tre soldati che sarebbero stati da lui convertiti, Longino, Acesto e Megisto – e quella della calotta absidale, con la Gloria di San Paolo – rappresentata secondo le visioni di una mistica medioevale, Maria di Oigny, che vide San Paolo presentato alla Trinità da santo Stefano protomartire e le tre virtù della fede, della speranza e della carità, di cui Paolo parla già nella prima lettera ai Tessalonicesi e poi nella prima ai Corinti, al suo fianco.
Proseguendo al di fuori delle mura abbaziali, verso le case abitate dalle Piccole Sorelle di Gesù, è possibile, su richiesta, visitare, all’interno del loro complesso, la cappella che conserva l’altare in legno che Charles de Foucauld costruì per la sua cappella – il luogo è oggi in Algeria.
10/ Basilica di San Clemente. Repubblica Ceca
1/ Motivi per un pellegrinaggio
Furono i santi Cirillo e Metodio a portare in Roma le reliquie del quarto papa della storia, Clemente, morto martire, secondo la tradizione, sulle rive del Mar Nero, nell’odierna Crimea.
Ma già la vicenda dello stesso Clemente Romano mostra il legame di Roma e della basilica con l’oriente. Egli, secondo la tradizione, venne esiliato dall’imperatore Traiano, salito al trono nell’anno 98, nel Chersoneso, cioè nell’odierna Crimea, dove avrebbe trovato la morte nell’anno 99, fatto annegare dai suoi persecutori con un’ancora al collo.
Sant’Ireneo di Lione racconta che Clemente “aveva visto gli Apostoli”, “si era incontrato con loro”, e “aveva ancora nelle orecchie la loro predicazione, e davanti agli occhi la loro tradizione” (Contro gli eretici). Egli è cioè uno dei primissimi anelli della tradizione, di quell’annuncio che passa di generazione in generazione, mantenendosi vivo, e permettendo a tutti di conoscere il Cristo.
Infatti, Cristo volle che la Chiesa trasmettesse a tutti non solo la fede in lui, ma la sua stessa presenza e, difatti, ogni vescovo ha ordinato i suoi successori e ha reso possibile loro di consacrare l’eucarestia: se si leggesse anche mille volte il testo dell’ultima cena, noi non avremmo la presenza viva di Cristo nell’eucarestia, mentre quando un vescovo pronuncia nella celebrazione liturgica una sola volta le parole “Questo è il mio corpo”, ecco che Cristo è presente nel sacramento dell’altare.
Così Clemente, dopo Pietro, Lino e Cleto/Anacleto, ricevette in Roma il ministero dell’episcopato e lo trasmise dopo di lui.
Importantissima è la sua lettera, certamente autentica, scritta ai Corinti intorno all’anno 96 d.C. Tale lettera appartiene ai cosiddetti “scritti dei Padri Apostolici”. I Padri sono quegli uomini che sono padri nella fede per le generazioni successive per aver donato a tutti quattro realtà decisive: il Canone delle Scritture, il Credo che sintetizza la fede, la disposizione della Liturgia che permette di avere comunione a Cristo attraverso la celebrazione, i fondamenti della teologia che continuò poi a svilupparsi nei secoli. I Padri Apostolici sono i primissimi Padri della Chiesa vissuti nel I secolo o agli inizi del II, quando erano ancora vivi gli apostoli o i loro immediati successori
La Lettera di Clemente ai Corinzi, certamente autentica, è indirizzata alla città cui già Paolo aveva indirizzato le sue lettere, di cui due conservatesi: leggendola si vede come la comunità di Corinto fosse ancora travagliata da lotte interne che la rendevano disarmonica e Clemente si rivolge ai corinti invitandoli alla carità, in assoluta continuità con quanto già Paolo aveva proposto loro.
La lettera attesta il primo intervento del vescovo di Roma al di fuori della sua comunità locale, con uno sguardo e un amore che si spinge ben oltre l’urbe. Clemente, nella lettera, ricorda Pietro e Paolo, le “più grandi e giuste colonne” che dovettero soffrire e venire martirizzati perché oggetto dell’invidia che genera divisione.
La basilica di San Clemente conserva le reliquie di un secondo Padre Apostolico, il vescovo e martire Ignazio di Antiochia, che giunse a Roma negli anni 110-111. Dalla diocesi di cui era vescovo, nell’antica Siria, attraversò sotto scorta l’intero Mediterraneo, per essere martirizzato in un circo romano, quasi sicuramente il Colosseo. Infatti, nel suo epistolario, anch’esso autentico, è conservata la lettera che egli indirizza ai Romani nella quale scrive: “Lasciate che sia pasto delle belve per mezzo delle quali mi è possibile raggiungere Dio. Sono frumento di Dio e macinato dai denti delle fiere per diventare pane puro di Cristo”. Egli domandava così ai cristiani di Roma che non si adoperassero per differire il martirio.
Se un tempo era abitudine guardare al Colosseo quasi in esso vi fossero stati uccisi dalle fiere solo cristiani, oggi le mode storiografiche hanno sposato l’assurda tesi opposta, quasi che nessun cristiano vi sia stato martirizzato.
In realtà è evidente che nei giochi circensi del Colosseo, immediatamente vicino a San Clemente, siano stati uccisi in gran numero sia non cristiani che cristiani: la civiltà romana aveva aspetti altissimi, come la filosofia e il diritto, ma al contempo aveva elaborato aspetti maligni, come la lotta fra uomini e animali. Di quegli spettacoli è rimasto oggi solo un tenue ricordo nella “corrida” spagnola.
Nella stessa lettera di Ignazio ai Romani si trova la prima esplicita espressione del primato della Chiesa di Roma, in quanto fondata sulla successione petrina. Ignazio scrive, infatti, che Roma è la Chiesa che “presiede alla carità”, dove è chiaro che con la parola “agape”, “carità”, si intende la comunione delle Chiese fra di loro: a tale amore che unisce tutti i cristiani e i loro vescovi presiede appunto la comunità dell’urbe.
Furono Cirillo e Metodio a condurre le reliquie di san Clemente dal Chersoneso in basilica, nell’anno 867. I due erano fratelli, Metodio il più grande di sette e Costantino, che poi prese il nome monastico di Cirillo, il più piccolo. Il principe della Moravia chiese a Costantinopoli che fossero mandati evangelizzatori per la sua gente e così i due partirono in missione.
Cirillo ideò l’alfabeto glagolitico che poi si mutò in quello cirillico, che da lui prende il nome, e tradusse, mettendole per iscritto, le Scritture e i testi liturgici, i primi documenti scritti nel nuovo alfabeto. Per questo ruolo decisivo per l’apertura del mondo slavo al cristianesimo, ma ancor prima per l’ardore della testimonianza, i due sono ritenuti gli evangelizzatori dell’intero mondo slavo, fino agli Urali, e così, anche dei moravi e dei cechi.
Quando i Franchi si opposero alla loro opera, i due fratelli giunsero a Roma e si rivolsero a papa Adriano II che approvò la loro missione e la traduzione dei testi nella nuova scrittura da loro elaborata: la tradizione vuole che il pontefice facesse deporre tali traduzioni in Santa Maria Maggiore, come segno che tale opera era stata voluta dallo Spirito di Cristo. In quest’occasione recarono con loro, come dono al pontefice, le reliquie di San Clemente che da allora sono conservate nella basilica stessa.
Fu probabilmente a Roma, in Santa Prassede, che Costantino prese il nome monastico di Cirillo, mentre il papa ordinò vescovo Metodio a Roma. I due fratelli furono così riconosciuti nella loro missione sia da Costantinopoli che dalla sede del primo degli apostoli.
Cirillo si ammalò in Roma e vi morì nell’869, mentre Metodio potè tornare in Moravia e proseguire l’opera di evangelizzazione presso gli slavi. Cirillo volle essere sepolto proprio nella basilica dove erano state poste le reliquie di San Clemente e il pontefice chiese che gli fossero riservate le stesse esequie solenni che si usavano per i papi, a sottolineare ulteriormente la stima per la sua persona.
2/ Visitando la basilica
Abitualmente si visita la basilica di San Clemente a partire dalla chiesa attuale, scendendo poi alla basilica inferiore e, infine, al mitreo.
Per comprendere l’evoluzione storica e spirituale testimoniata dalla basilica vale la pena, invece, seguire il percorso inverso.
Gli scavi intrapresi, a partire dal 1857, dal padre domenicano Mullooly, che era allora superiore del convento, portarono alla scoperta non solo della basilica inferiore, ma anche di un livello ancora precedente - la presenza dei domenicani irlandesi in basilica risale al 1667, quando, a causa delle persecuzioni che i cattolici dovettero subire da parte anglicana, il papa affidò loro la basilica.
Vennero rinvenuti, negli scavi, due edifici di età romana, separati da un vicolo: un edificio di grandi dimensioni - che è stato da taluni interpretato come pertinente alla zecca imperiale che doveva trovarsi in questa zona – ed una casa privata dotata di un mitreo.
Il mitreo è una sala di culto dell’antica religione mitraica, riservata ai soli maschi, portata in Roma da legionari provenienti dall’oriente, alla fine del I secolo d.C. e diffusasi poi nell’urbe nel II secolo d.C. Ai lati della sala sono disposte panche marmoree per poter assistere al culto sdraiati, come era abitudine nei banchetti. Al centro, invece, è un altare dove avvenivano sacrifici animali – una copia è stata posizionata nella navata laterale di sinistra della chiesa inferiore per potere osservare da vicino le raffigurazioni.
Sull’altare è rappresentato il fluire del tempo, con due figure che hanno l’una una torcia accesa, ad indicare la nascita e la vita, e l’altra una torcia capovolta, ad indicare la fine dell’esistenza. Al centro è rappresentato il dio Mitra/Apollo, divinità solare, che sgozza un toro, permettendo al suo sangue di fecondare la terra e restituire vita, mentre, al contempo, uno scorpione fora i testicoli del bovino, di modo che il liquido seminale riporti vitalità al cosmo.
Il culto mitraico appartiene alle cosiddette religioni misteriche che attestano la crisi del paganesimo del tempo: le divinità ufficiali del tempo non riscaldavano più i cuori e i romani del tempo si rivolsero a nuovi culti che fossero più personali e più attenti alla salvezza dell’anima individuale.
È evidente come il cristianesimo e i culti misterici non siano dipendenti gli uni degli altri, bensì tutti cerchino quel “sole” che possa vincere le tenebre del male e della morte, rivolgendosi chi alla croce di Cristo, chi ai sacrifici animali offerti a Mitra.
Il mitreo non venne distrutto, come non vennero distrutti in generale i mitrei dell’urbe, bensì quel culto dovette essere via via abbandonato. E, difatti, il mitreo è stato ritrovato intatto dagli scavi e dovette essere interrato insieme all’abitazione privata cui apparteneva e ai locali dell’edificio più grande, quando, salito il livello del terreno, si decise l’edificazione della basilica ad un livello superiore.
La basilica inferiore paleocristiana utilizzò i muri perimetrali dell’edificio più grande, mentre l’abside fu ricavata nella casa che aveva al livello inferiore il mitreo (ma il mitreo non è sottostante la basilica, bensì esterno ad essa): fu consacrata sotto papa Siricio, dunque tra il 384 ed il 399.
Visitandola risaliamo così di un livello, rispetto allo strato precedente. Si accede ai resti dell’edificio dall’antico nartece della chiesa del IV secolo. Esso corrisponde, al livello superiore, all’atrio del quadriportico della basilica attuale.
La funzione del quadriportico, ma anche del nartece, era di segnare il trapasso fra l’esterno dell’edificio e l’aula sacra vera e propria, oltre ad offrire un riparo dalle intemperie. Tale spazio più aperto serviva anche ad accogliere i catecumeni che potevano partecipare solo alla prima parte della liturgia domenicale.
Gli affreschi in facciata sono della fine dell’XI secolo e rappresentano l’ultima opera realizzata in questa chiesa, poco prima che venisse interrata. L’affresco a destra dell’entrata principale ha due registri.
In basso è ritratta la famiglia donatrice: si vede sulla sinistra un uomo con spada, con l’iscrizione del suo nome, Beno, Benone di Rapiza, gentiluomo del tempo, con la moglie Maria Macellaria e i due figli, Clemente e Altilia.
L’affresco venne realizzato, come dice l’iscrizione, per chiedere l’intercessione di san Clemente. Infatti, nel registro superiore, si vede un miracolo a lui attribuito. Clemente – ricorda l’affresco - venne martirizzato gettandolo in mare con un’ancora legata al collo, ma qualche tempo dopo le acque si ritrassero, scoprendo la sua tomba costruita dagli angeli.
Da quel giorno – secondo la tradizione - una volta l’anno la marea defluiva e la tomba di san Clemente poteva essere visitata. In una di queste occasioni la donna raffigurata dal pittore si era recata sulla tomba per venerare il santo, ma, al sopraggiungere della marea, aveva dimenticato il suo bambino addormentato presso la tomba. Tornata l’anno dopo, al defluire delle acque, ritrovò il bambino vivo. Nell’affresco si vedono chiaramente, i pesci che nuotano intorno alla tomba che aveva miracolosamente protetto il bambino per l’intercessione di san Clemente.
Benone chiedeva insomma a San Clemente di proteggere la sua famiglia, così come il santo aveva protetto il figlio di quella donna.
Nell’affresco di sinistra è rappresentata, invece, la traslazione delle reliquie di san Clemente nella basilica da parte di Cirillo e Metodio.
Si distinguono chiaramente i due fratelli, vestiti in abiti monastici bianchi e neri, ed in mezzo a loro il papa. Al centro del dipinto è il reliquiario con il corpo del santo che viene portato in basilica - l’artista dell’XI secolo ha commesso qui un errore perché indica il papa come Nicolò, ma in realtà fu Adriano II a ricevere le reliquie dai due fratelli. Sulla destra è di nuovo raffigurato il papa che attesta l’avvenuta traslazione delle reliquie.
Quindi, all’ingresso della chiesa inferiore, si ricordava subito la traslazione del corpo di san Clemente ed, insieme, si era invitati, tramite l’affresco con Benone di Rapiza, a meditare sul fatto che la protezione di San Clemente era ancora viva.
Nella controfacciata sono resti di un affresco più antico, datato alla costruzione stessa del muro che aveva chiuso gli spazi fra le colonne del nartece con il ritratto di Leone IV con l’aureola quadrata, quindi ritratto mentre era ancora in vita – è il papa costruttore delle cosiddette Mura Leonine a protezione della basilica di San Pietro, dopo l’attacco arabo del 846. L’affresco rappresenta l’Ascensione di Gesù.
Avanzando nella navata si vede a sinistra l’affresco con le storie di sant’Alessio, anch’esso della fine dell’XI secolo, probabilmente della mano di un discepolo del pittore degli affreschi del nartece. L’affresco ritrae gli episodi romani della vita del santo che fu pellegrino ed eremita in oriente. Alessio era un giovane di nobile famiglia che partì da Roma per vivere come monaco ad Edessa in Siria. Dopo tanti anni Alessio decise di tornare nell’urbe – racconta la tradizione - per evitare la fama che ormai lo circondava in oriente.
Non si fece però volutamente riconoscere e si mise a chiedere l’elemosina sotto la scala della casa di famiglia, senza che nessuno se ne accorgesse.
L’affresco lo mostra di fronte al padre a cavallo, mentre sua madre è alla finestra. Nessuno lo riconosce, perché magro e segnato dalle tante penitenze. A destra, invece, si vede Alessio in punto di morte, disteso dentro una mandorla, segno di gloria divina. Stringe in pugno un documento che egli consegna solo all’arrivo del papa e, finalmente, vi si legge il suo nome e tutti, addolorati, lo riconoscono, comprendendone anche la santità.
Avanzando ancora nella navata, sempre a sinistra, si giunge all’affresco più famoso che racconta un episodio della vita di san Clemente, anch’esso dipinto alla fine dell’XI secolo.
Sulla sinistra dell’affresco si vede nuovamente la famiglia di Benone di Rapiza. Invece, al centro è san Clemente che sta celebrando - sull’altare di forma quadrata, stanno il messale, il pane ed il vino. A destra è una donna, la moglie di un tal Sisinnio, che è invece condotto a mano, perché diventato cieco. Le storie leggendarie di Clemente, infatti, raccontano che il santo aveva convertito la moglie di questo Sisinnio che, ingelositosi poiché la moglie si recava in un luogo di culto cristiano, iniziò a spiarla, finché decise di prelevarla di forza dalla chiesa nella quale Clemente celebrava. Un miracolo rese però cieco Sisinnio.
Un secondo prodigio è rappresentato nella fascia in basso dove si vede Clemente con le parole del suo verdetto: “Duritiam cordis v(est)ris saxa traere meruistis” (“per la durezza del vostro cuore meritaste di trainare un sasso”). E, infatti, i servi di Sisinnio, venuti per catturare Clemente, anch’essi accecati, legano una colonna, credendo di aver invece legato Clemente, e cercano di trainarla fuori.
Le iscrizioni rappresentano una delle primissime attestazione del volgare italiano, successive forse solo alle Carte di Capua. Si leggono le parole di Sisinnio che grida: “Fili dele pute, traite, Gosmari, Albertel, traite. Falite dereto colo palo, Carvoncelle” (“Avanti, figli di male femmine, tirate. Su, Gosmari e Albertello, tirate. Tu, Carvoncello, fatti sotto con la leva”). È la libertà del linguaggio medioevale attestata in una basilica!
In alto, si vede un ulteriore registro pittorico che è stato tagliato dall’edificazione della basilica superiore. Si capisce bene, però, che le figure di cui si vedono solo i piedi sono i vescovi di Roma precedenti Clemente; si leggono, infatti, i nomi di Pietro, Lino, Cleto.
A destra, invece, si trova un frammento di un affresco con la discesa agli inferi di Cristo: vi si vede Adamo preso per il polso e tirato fuori dal limbo, mentre Gesù calpesta il diavolo.
Nel 1863 l’archeologo Giovanni Battista de Rossi, fu certo di aver rinvenuto l’antica tomba di Cirillo. Negli anni tantissime chiese slave hanno sottolineato tale luogo con il posizionamento di lapidi ed iscrizioni in ringraziamento del santo e del Cristo che l’aveva chiamato. Tale memoria si trova in fondo a sinistra, subito prima dell’accesso alla zona sottostante con il mitreo.
Dalla basilica inferiore si sale infine a quella superiore, l’attuale. Vale la pena, innanzitutto, recarsi nell’ultima cappella della navata a destra, dove sono custodite oggi le reliquie di San Cirillo che, ritrovate, furono fatte lì deporre da Paolo VI nel 1963, con la dedicazione di essa ai Santi Cirillo e Metodio. La cappella venne realizzata dopo il 1880: nell’affresco di destra si vedono i due fratelli dinanzi a papa Adriano II, mentre in quello di sinistra è la traslazione del corpo di san Cirillo in San Clemente.
Se questa cappella è stata, dunque, risistemata di recente, la struttura della basilica superiore è degli anni 1118-1125, quando venne ricostruita ad una quota di terreno più in alto dell’inferiore, per l’elevarsi del suolo nei secoli.
La cattedra ricorda il cardinal titolare che ne diresse la costruzione, il cardinal Anastasio. Già dalle lastre della schola cantorum appare evidente come si procedette in quell’occasione: tutto ciò che fu possibile salvare dell’edificio inferiore venne ricollocato nel nuovo: difatti, sulle lastre di marmo della Schola, si trova il monogramma Johannes di papa Giovanni II, eletto nel 533, il primo pontefice che cambiò nome, poiché era nato con il nome di Mercurio, ma non volle mantenere tale nome pagano.
Qualcosa di analogo si può dire del capolavoro più famoso di San Clemente, il magnifico mosaico absidale. Se la sua datazione è discussa - tra il XII e il XIII secolo – ciò avviene proprio perché si vollero utilizzare i motivi paleocristiani già presenti nell’abside della basilica inferiore: insomma, pur trattandosi di un’opera medioevale, cioè nuova, si vollero mantenere i modelli iconografici paleocristiani del IV o V secolo.
Il mosaico è incentrato innanzitutto su di un asse verticale dove si vede rappresentato Cristo quattro volte, in forme diverse.
In alto è il Cristo incarnato, con la mano che esprime il gesto di parlare e il libro: entrambi i simboli indicano che lui stesso è la Parola, poiché nel cristianesimo la Parola di Dio non è innanzitutto un Libro, ma il Figlio stesso fatto uomo, superiore alla Bibbia - come ha detto papa Francesco: “La Parola precede ed eccede la Scrittura”.
Subito sotto è il monogramma detto “costantiniano” – ma in realtà precedente a Costantino – con le due lettere Chi e Rho che sono le due inziali di Christos: Gesù è l’atteso, il promesso, il Messia che viene a salvare. Ai bracci pendono le due lettere Alpha e Omega, la prima e l’ultima dell’alfabeto greco, ad esprimere il fatto che Cristo è prima di ogni creature ed è il fine a cui l’universo intero tende.
Sotto ancora è la magnifica croce con il Cristo rappresentato su di essa: Gesù è il crocifisso, colui che offre la sua vita nell’amore. La mano del Padre, al di sopra della croce, lo incorona e indica la vittoria del Figlio suo.
Nella croce sono dodici colombe – particolare proprio del mosaico di San Clemente – a rappresentare non solo i dodici apostoli, ma tutto il popolo di Dio che nasce da quella croce e dalla testimonianza della Chiesa cattolica: tutto nasce dall’amore del crocifisso.
Sotto ancora è il Cristo come agnello, morto e risorto, verso il quale guardano le dodici pecore. Ulteriore simbolo della salvezza nella Chiesa – dodici sono anche le stelle che stanno intorno al Cristo che è più in alto, con un’insistenza sulla salvezza nella chiesa nata dagli apostoli.
Ma ecco che quell’unico Cristo, quell’unica croce, quell’unico agnello immolato, oltre a dare vita alle dodici stelle, alle dodici colombe, alle dodici pecore – segni tutti che rappresentano i cristiani -, tramite di essi rinnova il mondo e dona la vita.
Il Cristo che parla, in alto, ha alla destra e alla sinistra i simboli dei quattro evangelisti: quel Cristo, insomma, è portato al mondo intero dalla predicazione del Vangelo e raggiunge i quattro punti cardinali, il nord, il sud, l’ovest e l’est.
La croce, poi, germoglia in una vite che si ramifica e fruttifica in ogni angolo. È l’iscrizione alla base del mosaico a darne la giusta interpretazione:
“Ecclesiam Christi viti similabimus isti, quam lex arentem, sed crux facit esse virentem”, che significa: “Paragoniamo la Chiesa di Cristo a questa vite, che la legge fa disseccare, ma che la croce vivifica”.
G.K. Chesterton, durante un suo viaggio a Roma, così scrisse della croce di San Clemente: “Solo un pazzo può stare di fronte a questo mosaico e dire che la nostra fede è senza vita o un credo di morte. In alto c'è una nube da cui esce la mano di Dio. Sembra impugni la croce come un'elsa e la conficchi nella terra di sotto come una spada. In realtà però è tutt’altro che una spada, perché il suo contatto non porta morte, ma vita. Una vita che si sprigiona e irrompe nell’aria, in modo che il mondo abbia sì la vita, ma l’abbia in abbondanza”.
Le volute che nascono dalla base della croce sono di acanto, ma, appunto, simboleggiano la vite. In mezzo ad esse sono rappresentati simboli che dicono la fecondità, la vitalità, la creatività che Cristo ha portato sulla terra.
Innanzitutto si vedono scene di vita quotidiana a significare che tutto il genere umano e la creazione stessa trovano vita da questa pianta: una donna dà da mangiare ai polli, alcuni pastori pascolano il gregge, altri mungono il latte, cacciatori imbracciano armi per la caccia. È rappresentata, insomma, la vita del cristiano comune, dell’uomo del tempo, che svolge ogni suo lavoro sotto il segno della croce, cioè della redenzione.
Tra le scene di vita quotidiana sono rappresentati poi i pavoni che, nell'iconografia cristiana, sono il simbolo della risurrezione, ma anche due cervi assetati che si abbeverano. All’altezza della base della croce, stanno i quattro dottori della Chiesa d'occidente ciascuno con il nome vicino: guardando da destra, Ambrogio, Gregorio, Girolamo, Agostino. In mezzo a loro stanno altre scene di vita familiare: i benefattori dell'opera, il signore con la moglie, a sinistra, ed i figli, a destra.
A destra è rappresentato un personaggio con la tonsura che dà da mangiare ad un uccello (forse il cappellano di famiglia) e dall'altra parte, sempre intento a dar da mangiare, un altro personaggio (forse un maggiordomo). All’estrema destra, invece, un uccello in gabbia, simbolo forse dell'incarnazione.
Si notano anche delle figure mitologiche: a destra si riconoscono, infatti, un demone ed una divinità su di un delfino, quasi e dire che la redenzione è arrivata ovunque!
In basso, invece, le dodici pecore che si dirigono verso l’Agnello, escono dalla porta di Betlemme, sulla quale si scorge un bambino a rappresentare il Bambino Gesù, e da Gerusalemme, la città, invece della passione e resurrezione, dove sono rappresentati la croce e un gallo, simboli degli ultimi giorni del Cristo.
Completano il mosaico a sinistra san Paolo che insegna a san Lorenzo, con la sua graticola martiriale, a seguire la croce di Cristo. Sotto di loro è il profeta Isaia con il rotolo della profezia: "Ho visto il Signore che sedeva sul trono".
A destra, invece, è san Pietro che istruisce san Clemente, dicendogli: "Respice promissum, Clemens, a me tibi Christum” (“Clemente, guarda il Cristo che ti ho promesso”). San Clemente tiene in mano un'ancora e sotto di lui si vede una barca ed attorno alcuni pesci, ulteriore allusione al martirio subito da Clemente, gettato nel Mar Nero legato ad un'ancora. Sotto di loro il profeta Geremia con un rotolo del suo segretario Baruc: "Questi è il nostro Dio e nessun altro può paragonarsi a lui", “Hic est Ds. noster et n. estimabitur alius absq. illo”.
Nella testata della navata di sinistra, è la cappella di Santa Caterina, affrescata da Masolino da Panicale su commissione del cardinale Branda Castiglioni, che fu cardinale titolare della basilica di San Clemente tra il 1411 ed il 1431.
Il cardinal Branda Castiglioni era un grande umanista e l’umanesimo fu un fenomeno tipicamente cristiano ed ebbe fra i suoi centri più attivi e propulsivi proprio Roma. Nel 1388-89 il cardinal Branda Castiglioni fu inviato a Roma dall’allora signore di Pavia, Filippo Maria Visconti, per ottenere dal papa l’approvazione della Bolla di Fondazione dell’Università di Pavia, incarico che portò a termine con successo. Partecipò al Concilio di Costanza ed accompagnò il neo eletto papa Martino V nel suo viaggio di ingresso in Roma.
Nel paese d’origine della sua famiglia, Castiglione Olona, in provincia di Como, mise a disposizione i suoi beni perché fosse realizzata una scuola ed una biblioteca di grammatica e di musica, oltre a far affrescare da Masolino la Collegiata e lo straordinario battistero che conserva integralmente gli affreschi del maestro di Panicale.
Fu sempre il cardinal Branda Castiglioni a chiamare Masolino ad affrescare la sua Cappella romana in San Clemente, tra il 1428 e il 1431, forse con la collaborazione di Masaccio con il quale lavorò anche presso la Cappella Brancacci a Firenze, in Santa Maria del Carmine. Certo è che Masaccio fu il primo a rappresentare le ombre in pittura ed anche nella Crocifissione di San Clemente, in basso a sinistra, è evidente la presenza delle ombre dei personaggi ad indicare il realismo della storia cristiana.
All’esterno della cappella Masolino ha dipinto l’Annunciazione: Dio Padre, al centro, guarda la Vergine Maria, in attesa del suo assenso. Maria, a sua volta, sembra guardare verso l’affresco che è in fondo alla cappella, la Crocifissione. Sul lato è San Cristoforo che porta il Cristo Bambino sulle spalle per permettergli, secondo la tradizione, di attraversare un fiume.
Nella volta sono i quattro evangelisti, i quattro dottori della Chiesa e i dodici apostoli, a rappresentare la successione tra Cristo e la Chiesa che cammina nel tempo.
Sulla parete destra sono affrescate le storie di sant’Ambrogio, mentre a sinistra sono le storie di santa Caterina d’Alessandria. Al tempo degli affreschi la basilica era officiata da monaci ambrosiani di regola agostiniana e questo spiega il rilievo dato alla figura di Sant’Ambrogio. D’altro canto lo studiolo di sant’Ambrogio ben si collega alla figura di santa Caterina d’Alessandria, patrona dei filosofi, e all’umanesimo del cardinal Branda Castiglioni, desideroso di essere un cristiano colto e di formare ad una fede colta.
Nella parete di sinistra, nella prima scena in alto, santa Caterina spiega quanto siano vuoti gli idoli, mentre i pagani li adorano, dispiegando anche una tromba.
Nella seconda, in basso a sinistra, la santa viene chiamata dall’imperatore a discutere con i filosofi pagani e, secondo la tradizione, li convince, convertendoli al cristianesimo. Sul lato della scena si vede, come da una finestra, Caterina che assiste al rogo dei filosofi condannati a morte dall’imperatore perché divenuti cristiani.
Nella terza scena, in alto a destra, Caterina è in prigione e riceve la visita dell’imperatrice che le domanda della fede cristiana; a destra della scena viene rappresentato il martirio dell’imperatrice che, essendosi fatta anch’essa cristiana, viene condannata a morte dal marito imperatore.
Nella quarta scena al centro in basso viene rappresentato il primo tentativo di martirizzare la santa, facendola squarciare da due ruote che girano in senso inverso. Un angelo interviene a salvare la santa.
Nell’ultima scena in basso a destra la santa viene martirizzata, tramite decapitazione, mentre sullo sfondo si vedono gli angeli che trasportano il suo corpo al monte Sinai (secondo la tradizione le sue reliquie sono venerate nel monastero di santa Caterina al monte Sinai), mentre la sua anima viene portata in cielo.
Sul lato destro della cappella si vedono, invece, le scene della vita di sant’Ambrogio. La prima scena, in alto a sinistra, rappresenta Ambrogio ancora bambino. Secondo la tradizione, le api ronzavano sulla sua bocca, segno premonitore del fatto che la sua parola sarebbe stata dolce come il miele nel convincere i cuori alla fede.
Nella seconda scena, in alto a destra, si vede un bambino che acclama Ambrogio vescovo, quando egli era praefectus urbis e ancora catecumeno. Tutti compresero, a quell’annuncio, che proprio quell’uomo doveva divenire il vescovo di Milano e Ambrogio venne così ordinato.
Nel primo riquadro in basso a sinistra è un evento romano della vita del santo - Ambrogio, pur essendo nato a Treviri, proveniva da una famiglia romana e aveva la sua residenza in un palazzo poi trasformato nel monastero di Sant’Ambrogio alla Massima, vicino all’antico Ghetto. Ambrogio esce dalla casa di un giovane che affermava di sentirsi del tutto sicuro ed essa, invece, gli crolla addosso a ricordare la transitorietà delle cose.
Nell’ultima scena a destra si vede la morte di Ambrogio, mentre nella scena centrale è il suo studio, con il leggio e molti libri. Il cardinale Branda Castiglioni voleva così significare che la vita cristiana e quella di un vescovo è anche studio ed insegnamento. Lo studiolo rappresentato è vuoto, mentre ci sono quattro diaconi che assistono Ambrogio che muore. Nella sua Vita si racconta che sentì i diaconi che parlavano di Simpliciano come suo possibile successore ed egli confermò che era vecchio, ma buono, e quindi era la persona adatta ad essere nuovo vescovo di Milano dopo di lui.
A fianco dell’ingresso della basilica sono state posti due pannelli con le sinopie preparatorie di Masolino.
In alto, lungo la navata centrale della basilica attuale, è possibile vedere quattro grandi affreschi per lato con le storie di San Clemente e di sant’Ignazio di Antiochia. È utile farne menzione non per la loro qualità pittorica, quanto perché rimandano, fra storia e leggenda, ai due grandi Padri apostolici ricordati in basilica.
Sul lato sinistro, partendo dal fondo, si vede San Clemente che porge il velo a Flavia Domitilla, moglie del console Flavio Clemente, che verrà ucciso sotto Domiziano. Il pittore ha qui voluto collegare San Clemente con un altro Clemente del tempo, il console Flavio Clemente, di cui non si sa con sicurezza se venne ucciso perché convertitosi al cristianesimo.
Il secondo affresco rappresenta San Clemente che opera un miracolo in Crimea, luogo del suo esilio.
Il terzo mostra il martirio di San Clemente, che avvenne, secondo la tradizione come si è già detto, gettandolo nel Mar Nero legato ad un’ancora.
Il quarto affresco rappresenta la traslazione delle reliquie dal Mar Nero a San Clemente.
A destra, invece, si vede la morte di San Servolo, un mendicante che era solito questuare dinanzi alla basilica di San Clemente, di cui parla San Gregorio Magno in un’omelia.
Si vede poi la condanna di Sant’Ignazio e ancora il saluto di San Policarpo, vescovo di Smirne a Sant’Ignazio, quando egli passò in catene presso di lui inviato a Roma.
Si vede, infine, il martirio di Sant’Ignazio al Colosseo.
Questi affreschi vennero realizzati durante il pontificato di Clemente XI (1700-1721).
11/ Chiesa del Gesù. Lituania
1/ Motivi per un pellegrinaggio
Sant’Ignazio di Loyola giunse a Roma - per la seconda volta - seguendo la via Cassia nel novembre del 1537, insieme a due compagni - egli amava chiamarli gli “amici del Signore”. Ignazio si era convertito nel 1521, all’età di 30 anni, dopo essere stato ferito nella battaglia di Pamplona, da una pallottola francese che cambiò in meglio la sua vita. Aveva continuato a cercare il Signore a Manresa in Catalogna, dove aveva cominciato a scrivere gli Esercizi spirituali.
Nel 1523 si era recato già una prima volta a Roma per continuare poi il suo pellegrinaggio verso la Terra Santa, ritornando poi in Spagna ed a Parigi per gli studi. A Venezia venne infine ordinato sacerdote nel 1537.
Nello stesso anno, nel suo secondo e definitivo viaggio, poco prima di raggiungere Roma, alla Storta, ebbe una visione: il pellegrino - così Ignazio amava chiamarsi - vide che «Dio Padre lo metteva con Cristo suo Figlio da non poter più in alcun modo dubitare che di fatto Dio Padre lo metteva con il suo Figlio» - l’episodio è rappresentato negli affreschi della chiesa di Sant’Ignazio, dove si ricordano le parole che Ignazio ascoltò dal Cristo in quel momento: «A Roma vi sarò propizio».
Ignazio ed i suoi compagni risiedettero in diverse abitazioni romane fino a trasferirsi nel 1542 presso Santa Maria della Strada, una chiesetta che sorgeva alla destra dell’odierna Chiesa del Gesù. Si spostarono così verso il centro della città, per essere una presenza viva nel cuore di essa.
Nel 1538 Ignazio e i compagni si offrirono al papa per la missione. Il primo incarico che egli affidò loro fu quello della catechesi dei bambini delle scuole di Roma. Successivamente si prodigò per la costituzione del Collegio Romano che diverrà poi famoso come centro di studi di alta qualità e ricevette l’incarico di seguire i catecumeni che in Roma si preparavano al Battesimo. In proposito, padre Gonçalves da Câmara, segretario di Ignazio, riferisce queste parole del fondatore: «Poiché tutto il bene della Cristianità e di tutto il mondo dipende dalla buona formazione della gioventù per la quale c’è grande necessità di virtuosi e sapienti maestri, la Compagnia si è assunta il compito meno appariscente ma non meno importante della formazione di essa» (1556).
Eletto primo Preposito generale, si ritirò in preghiera presso San Pietro in Montorio ed accettò poi definitivamente l’elezione presso la Cappella del Crocifisso in San Paolo fuori le Mura. Ammalatosi nel 1556, visse per alcuni mesi presso una residenza sul Colle Aventino per tornare poi presso Santa Maria della Strada dove morì nello stesso anno.
Ignazio scoprì nella sua ricerca personale e poi insegnò che è importante «preparare e disporre l'anima a liberarsi da tutte le affezioni disordinate e, dopo averle eliminate, a cercare e trovare la volontà di Dio nell'organizzazione della propria vita in ordine alla salvezza dell'anima». Egli era consapevole che l’uomo spesso non sa quello che vuole e si spende per realtà che non gli danno la felicità e la salvezza. Per “discernere” - termine molto importante nel linguaggio ignaziano - bisogna purificare ed ordinare il cuore dell’uomo, perché esso possa credere ed amare.
Non si tratta, però, di soffocare il cuore, quanto piuttosto di far emergere e dare peso e rilievo a ciò che veramente conta. Ignazio comprese fin dal momento della sua conversione che la fede è portatrice di gioia, di una gioia che non è effimera ed anzi ha il potere di durare:
«Mentre leggeva [in convalescenza dopo essere stato ferito a Pamplona] la vita di Cristo nostro Signore e dei santi, pensava dentro di sé e così si interrogava: “E se facessi anch’io quello che ha fatto San Francesco; e se imitassi l’esempio di San Domenico?”. Queste considerazioni duravano anche abbastanza a lungo avvicendandosi con quelle di carattere mondano. Ma tra le prime e le seconde vi era una differenza. Quando pensava alle cose del mondo, era preso da un grande piacere; poi, subito dopo quando, stanco, le abbandonava, si ritrovava triste e inaridito. Invece quando immaginava di dover condividere le austerità che aveva visto mettere in pratica dai santi, allora non solo provava piacere mentre vi pensava, ma la gioia continuava anche dopo».
Ignazio poté così insegnare che l’uomo «è creato per lodare, riverire e servire Dio nostro Signore, e così raggiungere la salvezza; le altre realtà di questo mondo sono create per l'uomo e per aiutarlo a conseguire il fine per cui è creato». Se non giunge alla lode di Dio l'uomo perde sé stesso ed ogni cosa, se non viene posta in relazione con Dio, perde la sua bellezza.
Per questo è chiesto all’uomo, agli inizi degli Esercizi spirituali (I settimana) di prendere coscienza del peccato che è questa distorsione della vita stessa: solo la coscienza del peccato rivela la misericordia di Dio.
Ma l’uomo non deve solo vedere il peccato: con la memoria e la “sensibilità” può, invece, imparare a vedere e gustare la bellezza del Cristo e della vita spirituale che con Lui nasce. A Manresa, dove approfondì i segreti della vita spirituale, Ignazio «vide con li occhi interiori» e, precisamente, nella prima «visione» vide la Trinità, il cuore dell’amore presente in Dio, fino a piangere a lungo di esso, nella seconda «visione» contemplò la creazione - «gli si rappresentò nell'intelletto, accompagnato da grande allegria spirituale, il modo con cui Dio aveva creato il mondo» -, nella terza «visione» contemplò «come nostro Signore stava nel Sacramento dell'altare», nella quarta «visione» invece «l'umanità di Cristo e la figura di Maria», nella quinta il significato di tutta l'esistenza.
Dalla contemplazione del “mistero” di Dio non può non nascere - insegna Ignazio - il desiderio di porsi al suo servizio per annunziarlo. La vocazione, per Ignazio, non è tanto l’attesa di una ipotetica chiamata, quanto piuttosto il domandarsi cosa fare per Colui che ci ha amato e che noi amiamo, come un ragazzo che, innamorato, fa di tutto per stare vicino alla sua amata e non aspetta, ma si propone.
E, certamente, ogni chiamata in senso biblico è tale per amore dei non-chiamati. La fede cristiana rigetta la teoria della doppia predestinazione, poiché sa che chi è scelto ed eletto, lo è non contro gli altri, ma anzi a loro servizio. In particolare Ignazio si convinse che l’opera educativa era uno dei servizi di carità più alti che il mondo attendeva. Come disse uno dei primi educatori missionari gesuiti, Juan Bonifacio, «formare i bambini significa rinnovare il mondo!».
Peculiare è il rapporto della Chiesa del Gesù con la Lituania. Se fu solo nel XIII secolo che venne fondata la diocesi che ebbe il nome di Lituania e già nel XIV secolo che il Granduca Gediminas scrisse a Papa Giovanni XXII dalla capitale Vilnius, informandolo dell’intenzione di accettare il cristianesimo: due secoli dopo il Vescovo di Vilnius vi invitò i Gesuiti, perché lavorassero nel paese. Furono essi a creare l’Università di Vilnius che ebbe un ruolo importantissimo nello sviluppo della nazione. Nella Chiesa del Gesù è sepolto il primo cardinale dalla Lituania e vescovo di Vilnius - più tardi vescovo di Cracovia - Jurgis Radvila (Jerzy Radziwiłł, 1556-1600), che era gesuita.
2/ Visitando la chiesa
Il Gesù è la prima chiesa che i gesuiti eressero in Roma, proprio sui luoghi dove Ignazio visse a lungo e dove morì il 31 luglio 1556. È la chiesa madre della Compagnia di Gesù ed in essa è custodito il corpo del suo fondatore, sant’Ignazio di Loyola.
Fu lo stesso Ignazio a volere la chiesa a navata unica che ebbe una lunga progettazione - anche Michelangelo si mise al servizio dei Gesuiti per il Gesù con un suo progetto del 1554, mentre era ancora vivo sant’Ignazio. Essa venne infine realizzata dopo la morte del santo fondatore e consacrata nel 1584. Vi lavorarono Jacopo Barozzi, detto il Vignola, che disegnò l’interno e, infine, Della Porta che portò a termine l’attuale facciata che comunica, secondo lo Spirito del Concilio di Trento, forza, ma anche sobrietà.
La lunga gestazione del Gesù fece sì che la chiesa avesse infine uno stile tra il rinascimentale ed il barocco, che ebbe un gran influsso sull’architettura sacra, fino ad ispirare il termine di “stile gesuitico” – anche se tale termine è oggi contestato da taluni studiosi.
Già nello stemma in facciata appare il nome di Gesù in abbreviazione con le tre lettere JHS, iniziali di Jesus Hominum Salvator, Gesù salvatore degli uomini. Il trigramma era già stato usato come simbolo, soprattutto da san Bernardino da Siena - e lo sarà ancora, si pensi all’architetto Gaudí che le utilizzò in Casa Battló a Barcellona, insieme alle abbreviazioni dei nomi di Maria e Giuseppe.
Nelle chiese gesuitiche – a partire dal Gesù - si vede la forma peculiare che Ignazio volle per il trigramma, con l’aggiunta di una croce sull’acca e dei tre chiodi della crocifissione. Jehoshua è il nome ebraico di Gesù e significa: Dio salva. Le tre lettere scelte da Ignazio sottolineano come l’uomo riceva l’amore che salva concretamente, dalla croce di Cristo, dal suo nome e per questo molte chiese gesuitiche sono dedicate proprio al nome di Gesù.
Le nicchie a sinistra e a destra vennero arricchite delle statue di sant’Ignazio e di san Francesco Saverio solo nel XVII e ripetono all’esterno la posizione delle cappelle interne dedicate ai due santi: secondo la visione del tempo esse schiacciano l’eresia.
Per volontà di Ignazio la sua compagnia si chiamò compagnia di Gesù. Il termine “compagni”, ben prima che venisse usato in senso politico in tempi moderni, significa “coloro che condividono lo stesso pane”, “cum panis”, con Gesù.
L’interno è pensato come una grande aula per la predicazione, che è sempre stata importantissima nella Compagnia di Gesù. Il magnifico soffitto della navata venne realizzato con affreschi e stucchi con il Trionfo del nome di Gesù (per una presentazione dell’intera opera, cfr. La volta della Chiesa del Gesù del Baciccio. Una presentazione iconografica. Redazione a cura di Andrea Lonardo.), da Giovan Battista Gaulli detto il Baciccia.
Chiave per la sua comprensione è la citazione di San Paolo retta dagli angeli: «Nel nome di Gesù ogni ginocchio si pieghi in cielo, in terra e sottoterra» (Fil 2,10).
Si vede, infatti, nel punto più luminoso dell’opera il nome di Gesù secondo il trigramma JHS proprio di Ignazio, e intorno angeli e santi che lo adorano. In particolare la figura di donna di spalle che è su di una nuvola sostenuta da un angelo è la Chiesa intera che adora il Signore Gesù.
Alla sua sinistra si vedono le sante, fra le quali si riconoscono Elena imperatrice, che reca il cartiglio della croce con su scritto INRI, sant’Elisabetta d’Ungheria con la corona e, un po’ più in alto, i tre re Magi, di cui uno con carnagione nera a rappresentare i cristiani d’Africa. Al di sopra della Chiesa è un frate, San Francesco. A destra, invece, la figura più grande è San Gregorio Magno, mentre più in alto si riconosce il modellino della Chiesa del Gesù, offerto dal cardinal Farnese, e, vicino a lui, san Filippo Neri, amico personale di sant’Ignazio.
Nella zona più scura invece, sono rappresentati in maniera illusionistica i sette vizi capitali e i demoni che vengono precipitati agli Inferi, uscendo dalla zona di luce del cielo aperto.
A destra si vedono l’Ira, rappresentata con un fuoco che arde, e la Superbia, con un pavone che ne è segno, mentre fra le due, poco più in basso, è l’Invidia che si strappa i cappelli e, ancora più in basso, l’Avarizia con una lupa e una borsa di denari. A destra, nel punto più basso, sono l’Eresia, con orecchie d’asino, e la Vana scienza con un libro aperto e fallace.
Guardando a sinistra si vedono prima l’Accidia che si porta le mani al capo in segno di disperazione, subito sopra la Gola con una lonza, all’estremità in basso la Simonia, con una borsa di denaro, e, più in alto, la Lussuria con una donna/animale e un uomo in forma demoniaca che le è vicino.
Tutti o si inginocchiano dinanzi al nome di Gesù o precipitano al di fuori della scena.
Gli affreschi del Baciccia sono della seconda metà del XVII secolo. Sua è anche la raffigurazione absidale con la Gloria del mistico Agnello, immagine sempre del Cristo.
Sull’altare maggiore campeggia una pala ottocentesca raffigurante la Circoncisione, di Alessandro Capalti, per ricordare il momento in cui venne messo al Bambino il nome di Gesù.
Anche la cupola di Giacomo Della Porta, impostata su di un tamburo ottagonale, venne affrescata dal Baciccia, avente per tema “Il Paradiso inneggia a Gesù”.
A sinistra dell’altare centrale è la Cappella di Sant’Ignazio. Essa venne progettata dal fratello laico gesuita Andrea Pozzo, originario di Trento, (1642-1709), grande uomo di scienza e di arte, che vinse nel 1695 il pubblico concorso per ridisegnare l’altare, in età barocca matura.
Al centro è la statua di San Ignazio. Nonostante la statua originaria di Pierre II Le Gros, venne distrutta dai francesi rivoluzionari giunti a Roma nel 1798, il suo rifacimento, eseguito nello studio di Antonio Canova, probabilmente da Adamo Tadolini agli inizi del XIX secolo, ricorda il capolavoro primitivo. L’intero altare conferisce vitalità alla raffigurazione del santo e la Cappella venne pensata come una vera e propria macchina barocca mobile, secondo il gusto del tempo: la tela che è dinanzi, come un sipario, può scendere e salire con un sistema di bilancieri, rivelando la statua di sant’Ignazio che è dietro di essa.
Il dipinto che copre la statua di sant’Ignazio è una tela attribuita a Andrea Pozzo con il santo che riceve da Cristo risorto il vessillo con il monogramma del nome di Gesù, mentre in basso stanno due angeli, l’uno che a sinistra regge il libro dei Vangeli aperto, mentre l’altro, a destra, indica quattro personaggi, simbolo dei quattro continenti allora conosciuti che si aprono alla fede.
L’insieme ci rivela quel gusto per il teatro che fu così vivo all’epoca e che spinse i gesuiti missionari a realizzare opere teatrali per le popolazioni ove giungevano.
Sotto l’altare sta l’urna di bronzo dorato, opera di Alessandro Algardi (1595-1654), che conserva il corpo del santo.
Ai lati stanno due gruppi di statue, la Religione che flagella l’Eresia, di Pierre II Le Gros (1666-1719), e la Fede che vince l’idolatria, di J.P. Théodon (1646-1713).
A destra dell’altare centrale sta, invece, la Cappella di san Francesco Saverio.
La pala d’altare raffigura san Francesco Saverio in punto di morte nell’isola di Sancian, proprio alle porte della Cina che si intravede sullo sfondo. Egli era il discepolo prediletto di Ignazio e tutto fece per portare Cristo agli estremi confini della terra, anche se non gli venne concesso di giungere fino in Cina. Famosa è una sua lettera che, raccontando delle popolazioni che non possono conoscere Cristo per mancanza di missionari, dice: “Mi sono accorto che [i nativi] sono molto intelligenti e, se ci fosse qualcuno a istruirli nella legge cristiana, non dubito che diventerebbero ottimi cristiani. Moltissimi, in questi luoghi, non si fanno ora cristiani solamente perché manca chi li faccia cristiani. Molto spesso mi viene in mente di percorrere le Università d'Europa, specialmente quella di Parigi, e di mettermi a gridare qua e là come un pazzo e scuotere coloro che hanno più scienza che carità con queste parole: Ahimè, quale gran numero di anime, per colpa vostra, viene escluso dal cielo e cacciato all'inferno! Oh! se costoro, come si occupano di lettere, così si dessero pensiero anche di questo, onde poter rendere conto a Dio della scienza e dei talenti ricevuti! In verità moltissimi di costoro, turbati da questo pensiero, dandosi alla meditazione delle cose divine, si disporrebbero ad ascoltare quanto il Signore dice al loro cuore, e, messe da parte le loro brame e gli affari umani, si metterebbero totalmente a disposizione della volontà di Dio. Griderebbero certo dal profondo del loro cuore: "Signore, eccomi; che cosa vuoi che io faccia?" (At 9, 6 volg.). Mandami dove vuoi, magari anche in India”.
La tela della Cappella è opera del grande maestro barocco romano Carlo Maratti (1625 – 1713).
Nell’arco sovrastante la cappella stanno la gloria del Santo in cielo, al centro; la scena del Crocifisso perduto dal santo in mare e riportatogli da un granchio, a sinistra e il Battesimo di una principessa indiana, a destra, tutti di Giovanni Andrea Carlone (1639 – 1697).
Sul gradino dell’altare è un reliquiario d’argento che conserva l’avambraccio destro del Santo – mentre il resto del corpo è venerato nella Chiesa di San Paolo, a Goa, in India, dove San Francesco Saverio predicò a lungo. L’avambraccio ricorda i numerosissimi battesimi amministrati dal missionario nei suoi viaggi.
Sopra la porta a sinistra dell’altare, sta un busto di un altro santo gesuita, San Roberto Bellarmino, eseguito tra il 1622 ed il 1624 da Gian Lorenzo Bernini.
c/ Donne patrone d’Europa e Dottori della Chiesa
12/ Trinità dei Monti. Santa Teresa di Lisieux
1/ Motivi per un pellegrinaggio giubilare
Teresa di Lisieux pregò più volte nella Cappella della Mater Admirabilis, all’interno del Convento della SS. Trinità dei Monti. Ciò avvenne in occasione del pellegrinaggio a Roma nel novembre 1887, all’età di 14 anni.
Con il padre, il signor Martin, e la sorella Celine partì per visitare Parigi e poi l’Italia: Milano, Venezia, Padova, Bologna, Roma (dieci giorni), Napoli, Pompei, Assisi. Scriverà più tardi Teresa: «Queste bellezze [...] profuse così largamente hanno fatto tanto bene all’anima mia! Come l’hanno innalzata verso Colui che si è compiaciuto di profondere tanti capolavori sopra una terra d’esilio destinata a durare un solo giorno!».
Un pellegrinaggio a Roma era allora un avvenimento. Teresa era adolescente e questo fu l’unico grande viaggio della sua vita. Ne riporterà impressioni, sensazioni e nuove intenzioni nella preghiera, perché le permise di conoscere ulteriormente il mondo e soprattutto sé stessa, prima di entrare per sempre in clausura: «Ah, che bel viaggio fu quello! [...] Ho capito la mia vocazione in Italia e non è stato andar troppo lontano per una conoscenza tanto utile».
Dal pellegrinaggio riportò alcune reliquie. Visitando le catacombe di San Callisto e il Colosseo, ne raccolse la terra “arrossata dal sangue dei primi cristiani” che racchiuse preziosamente in sacchetti di stoffa. Della sua visita al Colosseo scrisse: «Il cuore mi batteva molto forte nel momento in cui le mie labbra si avvicinarono alla polvere imporporata del sangue dei primi cristiani: chiesi la grazia di essere anch’io martire per Gesù e sentii in fondo al cuore che la mia preghiera era stata esaudita».
Scrisse, raccontando della visita a Santa Croce, il suo desiderio-bisogno di avere un contatto fisico con le tracce del passaggio sensibile del Figlio di Dio incarnato: «Occorreva sempre che io trovassi il modo di toccare tutto: di infilare il mio ditino in una delle aperture del reliquario che conteneva il chiodo che fu bagnato dal sangue di Gesù».
Giunse poi San Pietro per l’udienza pontificia, domenica 20 novembre, alla presenza di papa Leone XIII. Un giornale francese, L’univers, nella colonna della corrispondenza romana, ne riportò questa cronaca: «Fra i pellegrini si trovava una ragazza di quindici anni che ha chiesto al Santo Padre il permesso di entrare subito in convento per farsi religiosa. Sua Santità l’ha incoraggiata ad avere pazienza».
Era questa la finalità del viaggio: ottenere dal pontefice il permesso di entrare nel Carmelo prima dell’età canonica richiesta. Teresa era una postulante giovanissima e, secondo la testimonianza della sorella Celina, l’udienza con il papa si concluse con un diniego, poiché Leone XIII non le concesse di anticipare i tempi. Teresa però era paziente. «Io dormo, ma il mio cuore veglia» (Ct 5,2) è il versetto che le ricorderà di “abbandonarsi” totalmente alla Provvidenza, perché se Gesù sembrava non far nulla per la sua entrata nel Carmelo, il Suo cuore tuttavia non cessava di vegliare su di lei con amore.
Solo il primo gennaio dell’anno successivo arrivò la risposta positiva del vescovo e la sua entrata nel Carmelo venne fissata per il 9 aprile 1888. Teresa aveva quindici anni.
Teresa non aveva paura di parlare della sofferenza della vita: «Quando Gesù mi avrà deposto sulla riva benedetta del Carmelo, voglio donarmi tutta intera a Lui. I suoi colpi non mi faranno paura perché, anche quando le sofferenze sono più amare, si sente sempre che è la sua dolce mano che colpisce. L’ho sperimentato bene a Roma nel momento in cui tutto mi avrebbe fatto credere che la terra fosse lì per sparire sotto i miei piedi [...] La vita passa così presto che veramente vale di più avere una corona bellissima e un po’ di patire, che averne una ordinaria senza patire».
A Roma Teresa dimorò, come ricorda una lapide, in via Capo Le Case 56, nella zona che risaliva il colle alle spalle di piazza di Spagna, in quei tempi quartiere dei francesi. Nei giorni della sua permanenza in quella residenza si recava in preghiera presso la Chiesa della SS. Trinità dei Monti, all’interno dell’allora convento delle suore della Società del Sacro Cuore, nella cappella detta della Mater Admirabilis, affrescata nel 1844. È possibile recarvisi per pregare, bussando alla porta del convento.
Teresa di Lisieux è “dottore della Chiesa” perché insegna cosa è l’infanzia spirituale e come interpretare esistenzialmente l’espressione evangelica «se non diventerete come i bambini, non entrerete nel regno dei cieli».
È stupefacente come la piccola Teresa, la santa dell’“infanzia spirituale”, descriva la necessità di uscire dall’infanzia “naturale” per poter entrare veramente in un diverso tipo di abbandono. “Infanzia spirituale” non significa, nel suo messaggio, presunta innocenza dell’età infantile (come una valutazione superficiale dell’espressione potrebbe far pensare), o ancora nostalgia di un ritorno ai primi anni della vita intesi come modello tout court.
Anzi questi primi anni di vita anni sono da lei visti come età di ipersensibilità ed eccessivo attaccamento a sé stessi.
Lo mostra bene la sua descrizione della grazia del Natale – così la chiama - che ricevette nel 1886, la grazia della “conversione”. Teresa così ne scrive:
«Se il Cielo mi colmava di grazie, non era già perché io le meritassi, ero ancora tanto imperfetta! Avevo, è vero, un gran desiderio di praticare la virtù, ma lo facevo in un buffo modo, ecco un esempio: [...] dopo che Maria fu entrata nel Carmelo, mi accadeva talvolta, per far piacere al buon Dio, di rifarmi il letto, oppure, in assenza di Celina, rimettere dentro, a sera, i suoi vasi da fiori: come ho detto, era per il buon Dio solo che facevo quelle cose, perciò non avrei dovuto attendere il grazie delle creature. Ahimé! Le cose andavano ben diversamente; se per disgrazia Celina non aveva l’aspetto felice e stupito per i miei servizietti, non ero contenta, e glielo provavo con le lacrime. Ero veramente insopportabile per la mia sensibilità eccessiva. Così, se mi accadeva di dare involontariamente un po’ di dispiacere a qualcuno cui volessi bene, invece di dominarmi e non piangere, [...] piangevo come una Maddalena, e quando cominciavo a consolarmi della cosa in sé, piangevo per aver pianto [...] Non so come io mi cullassi nel pensiero caro di entrare nel Carmelo, trovandomi ancora nelle fasce dell'infanzia!».
Ma ecco l’uscita dall’infanzia donatale dal Signore: «Bisognò che il buon Dio facesse un piccolo miracolo per farmi crescere in un momento, e questo miracolo lo compì nel giorno indimenticabile di Natale; in quella notte luminosa […] Gesù, il Bambino piccolo e dolce di un’ora, trasformò la notte dell’anima mia in torrenti di luce [...]
Fu il 25 dicembre 1886 che ricevetti la grazia di uscire dall'infanzia, in una parola la grazia della mia conversione completa. Tornavamo dalla Messa di mezzanotte durante la quale avevo avuto la felicità di ricevere il Dio forte e potente. Arrivando ai Buissonnets mi rallegravo di andare a prendere le mie scarpette nel camino [N.d.T. colme di regali], quest’antica usanza ci aveva dato tante gioie nella nostra infanzia, che Celina voleva continuare a trattarmi come una piccolina, essendo io la più piccola della famiglia [...]
A Papà piaceva vedere la mia felicità, udire i miei gridi di gioia mentre tiravo fuori sorpresa su sorpresa dalle "scarpe incantate" e la gaiezza del mio Re caro [N.d.T. con l’espressione "il mio Re" Teresa designava il suo papà] aumentava molto la mia contentezza, ma Gesù, volendomi mostrare che dovevo liberarmi dai difetti della infanzia, mi tolse anche le gioie innocenti di essa; permise che Papà, stanco dalla Messa di mezzanotte, provasse un senso di noia vedendo le mie scarpe nel camino, e dicesse delle parole che mi ferirono il cuore: “Bene, per fortuna che è l’ultimo anno! [...]”. Io salivo in quel momento la scala per togliermi il cappello, Celina, conoscendo la mia sensibilità, e vedendo le lacrime nei miei occhi, ebbe voglia di piangere anche lei, perché mi amava molto, e capiva il mio dispiacere. “Oh Teresa! - disse - non discendere, ti farebbe troppa pena guardare subito nelle tue scarpe”. Ma Teresa non era più la stessa, Gesù le aveva cambiato il cuore! Reprimendo le lacrime, discesi rapidamente la scala, e comprimendo i battiti del cuore presi le scarpe, le posai dinanzi a Papà, e tirai fuori gioiosamente tutti gli oggetti, con l’aria beata di una regina. Papà rideva, era ridiventato gaio anche lui, e Celina credeva di sognare! Fortunatamente era una dolce realtà, la piccola Teresa aveva ritrovato la forza d’animo che aveva perduta a quattro anni e mezzo [N.d.T. al momento della morte della madre], e da ora in poi l’avrebbe conservata per sempre!
In quella notte di luce cominciò il terzo periodo della mia vita, più bello degli altri, più colmo di grazie del Cielo [...] Sentii che la carità mi entrava nel cuore, col bisogno di dimenticare me stessa per far piacere agli altri, e da allora fui felice!».
Se bisogna uscire da una visione infantile della vita, per Teresa, però, resta vero che bisogna essere bambini: ella sa che l’“infanzia spirituale” è l’essere figli nelle braccia del Padre. Essere bambini è fidarsi della provvidenza di Dio che mai abbandona. La fede è la totale confidenza nella misericordia che Dio ha per Teresa, desideri essa cose piccole o grandi. Teresa ebbe il desiderio di studiare teologia e anche di imparare l’ebraico, di partire per le missioni e di morire martire, ma comprese che non era in questo che consisteva la perfezione, come scrisse a suor Maria del Sacro Cuore:
«Come può chiedermi se può amare il buon Dio come me? [...] I miei desideri di martirio sono un bel nulla e non è di qui che nasce quella fiducia illimitata che sento nel cuore. A dir la verità, son proprio ricchezze spirituali che rendono ingiusti [N.d.T. Lc 16, 11], quando ci si appoggia ad esse con compiacenza e si crede che siano qualcosa di grande [...] Quello che piace a lui, è di vedermi amare la mia piccolezza e la mia povertà, è la speranza cieca che ho nella sua misericordia. Ecco il mio solo tesoro, madrina cara. Perché questo tesoro non potrebbe essere il suo?».
E nei suoi Diari scrive:
«Sono veramente lontana dall'essere una santa, solo questo ne è già la prova; invece di rallegrarmi per la mia aridità, dovrei attribuirla al mio poco fervore e fedeltà, dovrei sentirmi desolata perché dormo (da 7 anni) durante le mie orazioni e i miei ringraziamenti, ebbene, non sono desolata [...] penso che i bambini piccoli piacciono ai loro genitori quando dormono come quando sono svegli; penso che per fare delle operazioni, i medici addormentano i malati. Infine penso che “il Signore vede la nostra fragilità, e si ricorda che noi siamo solo polvere”».
Come ha scritto l’esegeta J. Jeremias: «‘Diventar di nuovo bambino’ significa imparare a dir di nuovo ‘abbà’».
Per questo Teresa, alla fine, scelse la carità e solo essa: «Considerando il corpo mistico della Chiesa, non mi ritrovavo in nessuna delle membra che san Paolo aveva descritto, o meglio, volevo vedermi in tutte. La carità mi offrì il cardine della mia vocazione. Compresi che la Chiesa ha un corpo composto di varie membra, ma che in questo corpo non può mancare il membro necessario e più nobile. Compresi che la Chiesa ha un cuore, un cuore bruciato dall'amore. Capii che solo l'amore spinge all'azione le membra della Chiesa e che, spento questo amore, gli apostoli non avrebbero più annunziato il Vangelo, i martiri non avrebbero più versato il loro sangue. Compresi e conobbi che l'amore abbraccia in sé tutte le vocazioni, che l'amore è tutto, che si estende a tutti i tempi e a tutti i luoghi, in una parola, che l'amore è eterno. Allora con somma gioia ed estasi dell'animo gridai: O Gesù, mio amore, ho trovato finalmente la mia vocazione. La mia vocazione è l'amore. Si, ho trovato il mio posto nella Chiesa, e questo posto me lo hai dato tu, o mio Dio. Nel cuore della Chiesa, mia madre, io sarò l'amore ed in tal modo sarò tutto e il mio desiderio si tradurrà in realtà».
2/ Visitando Trinità dei Monti
La cappella della Mater Admirabilis si trova non in chiesa, ma all’interno del convento.
È un’immagine della Vergine che sta filando, secondo la tradizione, il velo del Tempio, il velo del Santo dei Santi, gesto che è una prefigurazione del momento in cui compirà la sua opera più importante, “tessere” la carne del Figlio di Dio.
La dipinse nel 1844 una giovane postulante delle suore del Sacro Cuore, Pauline Perdreau, e subito l’immagine venne ritenuta miracolosa, poiché avvenivano guarigioni e conversioni a lei attribuite.
Il Convento era stato costruito dai Padri Minimi di San Francesco di Paola, perché il re di Francia Luigi XI aveva invitato presso di lui il santo che aveva poi raccontato al successore Carlo VIII di aver predetto che sul Pincio sarebbe sorto un convento dei Minimi.
I re di Francia avevano così acquistato il terreno e via via i successori, Luigi XII, Francesco I, Enrico II, Enrico III e poi gli altri avevano seguito i lavori del convento in età rinascimentale e poi contro-riformistica, finché nel 1594 la chiesa venne consacrata.
Ma i padri Minimi vi erano poi stati cacciati dall’esercito francese rivoluzionario, giunto a Roma nel 1798: tutto venne saccheggiato, la chiesa fu trasformata in deposito, asportate tutte le opere e venne addirittura staccata dal muro la Deposizione di Daniele da Volterra con l’intento di trasferirla in Francia. Quando l’Accademia di Francia venne trasferita a Villa Medici nel 1803, si iniziò a pensare ad un suo ampliamento con l’inclusione di Trinità dei Monti e diversi artisti vennero a stabilirsi nelle stanze del convento, mentre la chiesa sconsacrata servì da studi a molti di loro. Il più famoso dei pittori che vi lavorarono, come fosse un qualsiasi salone di lavoro, fu Ingres che vi dipinse, fra l’altro, Romolo vincitore d’Acrone.
Fu solo dopo il Congresso di Vienna che la chiesa venne nuovamente consacrata e l’intero complesso fu affidato alle Suore del Sacro Cuore per realizzarvi una scuola, perché esse – come dice una fonte dell’epoca -, lavorassero “per formare delle cristiane”: le suore «realizzano un desiderio [di coloro che] avvertivano che l’Italia non era riuscita ancora in questo obiettivo di amore: educare donne colte alla luce della fede cattolica. Essi speravano che le religiose di Francia avrebbero fatto all’Italia questo incomparabile dono». Fu santa Maddalena Sofia Barat, nel 1828, a dar vita alla nuova istituzione, l’Istituto del Sacro Cuore rivolto all’educazione.
Fra le postulanti del nuovo ordine figura appunto la pittrice che dipinse la Mater Admirabilis.
Per raggiungere il corridoio, poi trasformato in cappella, nella quale fu dipinta l’immagine, si attraversa il bellissimo chiostro con dipinti tutti i re di Francia in successione, proprio perché era stato patrocinato dai reali stessi. Ma vi è dipinta anche la storia di san Francesco di Paola e dei suoi Minimi che ne ebbero in origine la gestione.
Alla Cappella della Mater Admirabilis, oltre a Teresa di Lisieux, vennero in preghiera romani e pellegrini di ogni dove e, fra di essi, don Bosco e Pio IX.
La zona era già stata nel periodo patristico una zona monastica poiché la nobile vedova Proba aveva trasformato la propria casa in un “monastero” per giovani senza famiglia e per vedove: a lei sant’Agostino scrisse una memorabile lettera sulla preghiera e su che cosa sia la felicità, quando essa fuggì in Africa per le invasioni barbariche.
Il convento dei Minimi divenne al tempo un centro di grande cultura, con una biblioteca che si ingrandì fino a raggiungere i 9000 volumi, quando le devastazioni rivoluzionarie dispersero tutto il patrimonio. Andrea Pozzo dipinse con metodo del trompe-l’oeil il refettorio, mentre uno dei padri divenne botanico del re e la farmacia del convento era fra le più utilizzate di Roma. Ma il segno più evidente dell’attenzione culturale e scientifica presente fra i Minimi è data dalle due anamorfosi – letteralmente “nuova forma”, “ri-formazione” – cioè dai dipinti originati dagli studi ottici di padre Emmanuel Maignan e dal suo discepolo Nicéron. Durante il soggiorno romano di Maignan (1636-1650) il padre realizzò un dipinto della lunghezza di sei metri che, visto di lato, rappresenta San Francesco di Paola in preghiera sotto un albero, visto di fronte, invece, si legge come un paesaggio, nel quale si vedono in piccolo lo stesso santo e un suo confratello in preghiera, prima dell’attraversamento miracoloso del mare fra la Calabria e la Sicilia. Il secondo, che occupa la parete per circa venti metri, rappresenta invece San Giovanni nell’atto di scrivere l’Apocalisse, ma, da una diversa prospettiva, rappresenta invece il paesaggio dell’isola di Patmos dove essa venne scritta: venne dipinto dal Nicéron.
Vicino è anche un Astrolabio che era in grado di segnalare l’ora nelle diverse città del mondo e la posizione delle costellazioni anche di giorno, frutto degli studi astronomici e matematici della scuola dei Minimi, che ben conosceva gli studi di Galilei. Si vedono anche i danni che vennero realizzati dai francesi inviati dal Direttorio nel 1798 che, cacciati i frati, destinarono i corridoi del convento ad uso di un’infermeria che reca tuttora i disegni dei convalescenti alle pareti.
Si accede al complesso tramite la celebre Scalinata di Trinità dei Monti.
Essa venne realizzata tra il 1723 e il 1726 su progetto dell’architetto romano Francesco De Sanctis, mentre fino ad allora si saliva il Pincio su terra battuta, con evidenti disagi soprattutto in caso di pioggia.
Sebbene il progetto di realizzare un collegamento fra piazza di Spagna e la Trinità dei Monti esistesse fin dalla metà del cinquecento, esso venne più volta ritardato per la necessità di reperire fondi adeguati e perché la Francia voleva che la struttura venisse dotata di statue “francesi”, come quando propose che venisse pensata a partire da una statua equestre di Luigi XIV che l’avrebbe dominata.
Il progetto doveva anche superare una questione urbanistica: la fontana della Barcaccia non era in asse con la facciata della Chiesa - la Barcaccia venne scolpita da Pietro Bernini, con l’aiuto del figlio Gian Lorenzo e rappresenta una barca quasi sul punto di affondare, ma che in realtà mai affonda, straordinaria immagine evangelica e quasi emblema del modus vivendi dell’urbe stessa e della Chiesa.
Il terreno venne acquistato dalla Camera Apostolica negli ultimi decenni del cinquecento, ma solo nel 1660 i donativi di un francese, Stefano Gueffier, fecero sì che iniziasse la progettazione.
Furono decisivi i progetti attribuiti alla bottega di Gian Lorenzo Bernini, perché mostrarono che un andamento concavo e convesso delle pareti e l’utilizzo di rampe a tenaglia avrebbero reso splendida la scalinata.
La costruzione venne infine terminata sotto papa Innocenzo XIII e le aquile araldiche della sua casata – quella dei Conti – che figurano insieme ai gigli di Francia sui cippi alla base del monumento, dicono l’accordo che si raggiunse ottimamente.
Evidente è il ritmo ternario che De Sanctis riuscì ad imprimere alla costruzione, come richiamo alla Trinità, con le tre evidenti cesure date dalle due balaustre in alto e dalla terza che segna il passaggio dalla scalinata unica alle rampe a tenaglia più in basso. La prima parte della rampa è, appunto, unitaria, ma segnata da una divisione anch’essa in tre parti. Tutto rimanda alla discesa della Trinità in basso e, contemporaneamente, all’ascesa in Dio, in senso inverso.
La chiesa presenta in facciata due torri, cosa inusuale in Roma e conforme invece a chiese d’oltralpe, realizzata tra il 1570 e il 1585, secondo un disegno attribuito un tempo a Giacomo Della Porta.
Prima della scalinata di accesso a doppia rampa, disegnata da Domenico Fontana, sta l’obelisco detto “sallustiano”, copia romana di un originale egizio. Fu Pio VI che lì lo volle, negli anni immediatamente precedenti la rivoluzione, mentre la lapide che è fra le due rampe è del suo successore, Pio VII e ricorda la restaurazione del complesso dopo le devastazioni rivoluzionarie di cui si è parlato.
All’interno l’architettura è studiata con un’unica navata con cappelle ai lati. Fra le cappelle si segnalano, a destra:
-la prima dedicata a San Giovanni Battista (Cappella Altoviti) con dipinti intorno al 1580 relativi alla storia del Battista e, in particolare, la pala d’altare con il Battesimo di Gesù di Gian Battista Naldini.
-la seconda dedicata a San Francesco da Paola, a ricordo dei frati fondatori della chiesa. Per questa cappella Ingres fece il suo celebre Gesù che consegna le chiavi a Pietro, che riprese nel 1841, e di cui esiste nella chiesa una copia all’esterno della sacrestia della chiesa. Una suora del Sacro Cuore vi dipinse nel XVIII secolo San Francesco di Paola, si dice su di una tavola che sarebbe servita a lui da giaciglio.
-la terza dedicata all’Assunzione (Cappella della Rovere) contiene dipinti di Daniele da Volterra (1548-1560). Il pittore dipinse in particolare l’Assunzione, mentre il ciclo è completato dalla Presentazione della Vergine al Tempio, dall’Incontro alla Porta Dorata, dal Massacro degli Innocenti, dalla Fuga in Egitto e dall’Incoronazione della Vergine
A sinistra sono, invece:
-la seconda cappella, della Discesa della Croce (Cappella Bonfili), che contiene la celebre Deposizione dalla Croce di Daniele da Volterra, su cartoni cui collaborò Michelangelo, che venne staccata durante l’occupazione francese dalla cappella a fianco e poi ricollocata nella nuova posizione
-la terza cappella, dell’Immacolata Concezione (famiglia Orsini). Era la cappella dove era originariamente affrescata la Deposizione di Daniele da Volterra, distaccata per impadronirsene dai rivoluzionari. Venne ridipinta con opere dei pittori “nazareni”, con pala d’altare dell’Immacolata del tedesco Filippo Veit, mentre a sinistra è l’Annunciazione del suo allievo Giuseppe Thunner e a destra la Visitazione dello stesso o di un altro allievo.
-l’ultima cappella a sinistra è la Cappella Pucci, interamente affrescata con Storie della Vergine, uno dei cicli più famosi del Cinquecento romano, dipinto da Perin del Vaga, prima del Sacco di Roma, e poi proseguito da Taddeo Zuccari e poi da Federico Zuccari. Importantissima è la Morte della Vergine, dipinta nel 1563 da Taddeo Zuccari, cui si ispirò chiaramente Caravaggio nella sua tela, poi rifiutata, con tema analogo, in Santa Maria della Scala
Sopra l’altare maggiore la volta della crociera è in gotico tardivo, costruita nei primi anni del XVI secolo, mentre nel resto di Roma già fioriva il Rinascimento. L’altare maggiore reca una rappresentazione della Trinità, mentre le statue di San Luigi e di San Francesco di Paola che lo ornavano in origine vennero disperse nel 1807.
13/ Santa Maria della Vittoria. Santa Teresa d’Avila
1/ Motivi di un pellegrinaggio
La chiesa di Santa Maria della Vittoria permette di incontrare la comunità carmelitana che vive la stessa spiritualità che fu di Santa Teresa d’Avila e ammirare la Cappella Cornaro del Bernini che traduce visivamente l’esperienza di fede della santa spagnola.
Il complesso scultoreo che è al centro rappresenta l’Estasi di Santa Teresa d’Avila. Chi analizza il capolavoro in chiave puramente psicanalitica o erotica non comprende il cuore dell’opera stessa e della spiritualità teresiana. Chi vi vuole vedere un orgasmo mascherato da estasi cristiana o un connubio ambiguo fra i due, semplicemente non conosce il Cantico dei Cantici e l’esperienza di amore delle mistiche e delle monache.
Quel libro veterotestamentario già annunziò in maniera sconvolgente e magnifica che fra Israele e il suo Dio, così come fra l’anima e il suo Signore, vi è lo stesso amore che c’è tra la sposa e lo sposo. La rivelazione cristiana comprende ancora più in profondità tale amore personale a partire dal Cristo: egli è lo sposo che muore per amore della sua sposa, la Chiesa che lo riama di un amore che la porta a donarsi anch’essa tutta intera.
Incredibile è la frase che Bernini fa porre in cima all’opera di Santa Maria della Vittoria: «Nisi coelum creassem ob te solam crearem» («Se non avessi creato il cielo, per te sola [Teresa] lo creerei». È la rivelazione dell’amore che Teresa riceve dal suo Signore.
Ecco l’amore di Dio che solo è credibile: Dio ha creato l’universo intero e il Paradiso per coloro che egli ama: tutto è finalizzato, a partire dalla creazione e dalla storia della salvezza, all’uomo, perché possa incontrare l’amore di Dio e goderne. Se l’uomo moderno domanda alle monache e alle suore come possano vivere senza un amore umano, esse rispondono con una domanda ancora più radicale: come si può vivere senza che il cuore sia riscaldato dall’amore di Cristo?
Nella rappresentazione dell’estasi d’amore di Teresa d’Avila Bernini raffigura tre dimensioni in maniera artisticamente nuovissima, ma in totale fedeltà all’esperienza mistica.
Innanzitutto rappresenta l’estasi come un matrimonio mistico: non è più Cupido, come nell’arte classica, ma un angelo a recare il dardo d’amore del Cristo
È vero amore che, insieme, dilacera i sensi, come ogni vero amore. Teresa ne scrisse affermando: «L’anima si duole per l’assenza di Dio, ma non è lei che ne procura la pena, bensì una certa saetta che di quando in quando le penetra il cuore e le viscere così al vivo, da lasciarla come incapace di fare e di volere alcuna cosa. Benché non sia un dolore fisico ma spirituale, vi partecipa un poco anche il corpo, anzi molto. Allora tra l’anima e Dio passa come un soavissimo idillio».
In secondo luogo lo scultore rappresenta l’estasi di Teresa nel momento stesso della sua morte. La santa non è inginocchiata, come avveniva nell’iconografia fino a quel momento, ma distesa sul letto di morte, che avvenne a settant’anni. Una testimone della morte di Teresa scrisse: «Era così accesa di amore che pareva non vedesse l’ora di uscire dal corpo per andare dal suo Sposo».
L’intero progetto della Cappella venne disegnato dal Bernini e si vedono, nel pavimento, i morti che escono dalle loro tombe, per ricongiungersi al Signore - la Cappella è anche il luogo delle sepolture della famiglia Cornaro.
In terzo luogo Bernini volle collegare l’estasi alla celebrazione eucaristica, non solo ponendo il gruppo scultoreo sull’altare, ma inserendo anche il bassorilievo con l’ultima cena: l’unione fra Cristo e ogni anima si consuma non solo nell’esperienza privilegiata dell’estasi, ma ogni volta che si partecipa all’eucarestia.
Bernini studiò la disposizione architettonica di modo che la luce giungesse direttamente dall’alto, dinanzi all’Estasi, a completare il simbolo della colomba, lo Spirito Santo che discende, illumina e consacra.
I rappresentanti della famiglia Cornaro – fu il cardinale Federico a chiamare il Bernini a lavorare all’Estasi – assistono dai loro palchi, proprio perché l’esperienza intima e personalissima di Teresa ha in realtà un significato pubblico e riguarda ogni anima, chiamata alle nozze d’amore con il Cristo, tramite i sacramenti.
L'estasi della santa diventa così un evento pubblico, al quale con i nobili della casata che ne discorrono, anche i visitatori sono ammessi.
In alto, poi, gli stucchi dipinti collegano, nella concezione unitaria data dal Bernini alla Cappella, la terra al cielo, con gli angeli musicanti che gioiscono delle nozze di Teresa con il Cristo e recano i libri con i quali la santa ha reso gloria a Dio e illuminato gli uomini sul cammino da seguire per giungere a lui.
Bernini fece realizzare anche quattro bassorilievi in alto che contribuiscono alla presentazione di Teresa con le seguenti scene:
- Teresa che insieme al fratello minore decide di partire verso i Turchi per essere da loro martirizzata e rendere gloria a Dio
- Teresa con gli strumenti della penitenza che mostra inginocchiata le proprie ferite al Cristo crocifisso
- L’apparizione di Cristo a Teresa che la ringrazia per il bene che la santa ha fatto a Maria, la Madonna
- Le nozze mistiche di Cristo con Teresa: le offre in dono un chiodo della croce.
Nei quattro riquadri non sono esaltate, come pure sarebbe stato legittimo, le “opere” di Teresa - come, ad esempio, i monasteri da lei fondati o la riforma da lei guidata. Si racconta invece della sua esperienza intima e interiore di comunione con il Cristo, esperienza cui appartenne l’estasi d’amore che è rappresentata dalla scultura al centro.
2/ Visitando la chiesa
Quando i padri carmelitani affidarono a Carlo Maderno il progetto dell’attuale chiesa, costruita tra il 1608 e il 1620, negli stessi anni in cui l’architetto innalzava la navata centrale di San Pietro, la zona era periferica: si trovava sulla via Pia, voluta da papa Pio IV che dette il nome anche a Porta Pia, e si era in campagna anche se all’interno delle Mura. I carmelitani servivano in San Pietro come confessori e all’apostolato e il nuovo edificio con l’annesso convento aveva ereditato la titolazione di una piccola cappella preesistente a San Paolo apostolo – l’affresco della Cupola, del Cerrini, rappresenta il Rapimento di San Paolo in Cielo e nel coro di Santa Maria della Vittoria, dietro l’odierno altare maggiore, si trova tuttora il Rapimento di San Paolo in cielo di Gherardo delle Notti.
La facciata della chiesa è di Giovan Battista Soria, a spese del cardinal Scipione Borghese, a cui i carmelitani donarono invece la scultura dell’Ermafrodito dormiente, oggi al Louvre, rinvenuta negli scavi per le fondamenta della chiesa.
Proprio nell’anno in cui venne terminata la nuova chiesa, però, le forze cattoliche riportarono una vittoria inaspettata in Boemia nella battaglia della Montagna Bianca: quando il destino sembrava segnato per l’armata guidata da Massimiliano di Baviera, il padre carmelitano Domenico di Gesù e Maria che aveva fondato il convento sulla via Pia e che era stato inviato come cappellano al seguito delle truppe, si mise in mostra a fianco dei combattenti con al collo l’icona di una Madonna con Bambino che aveva trovato in un castello, sfregiata da esponenti dell’altro fronte protestante che avevano cavato gli occhi di Giuseppe e di Maria dal dipinto, e, contemporaneamente, raggi di luce sarebbero sgorgati da tale immagine, dando vigore ai combattenti.
Al ritorno dalla vittoria l’immagine fu intronizzata sull’altare centrale e il nome della chiesa mutato in Santa Maria della Vittoria: l’affresco absidale mostra appunto l’ingresso dell’immagine ritenuta miracolosa in Praga, mentre le spade al fianco dell’abside vennero lì poste in segno di omaggio e, in sacrestia, quattro dipinti rappresentano le diverse fasi dell’evento.
Anche l’affresco della volta della navata è debitore alle tensioni del tempo: i fratelli Orazi, a cavallo fra Seicento e Settecento, vi rappresentarono la Vergine che trionfa sugli eretici, che si vedono sconfitti con i loro libri.
Nella Cappella della SS. Trinità, è una tela del Guercino con la rappresentazione delle tre persone divine, mentre nella cappella di San Francesco d’Assisi le tre opere, con la pala centrale con la Vergine e San Francesco, sono del Domenichino.
Sempre nella cappella della SS. Trinità è la lapide del cardinale Berlingero Gessi, che fu responsabile della Fabbrica di San Pietro e che ebbe il grande merito di chiamare Caravaggio a dipingere le storie di San Matteo nella Cappella Contarelli, ulteriore prova che il Merisi ebbe fin dagli inizi dalla sua parte gli ecclesiastici del tempo.
14/ Santa Brigida. Santa Brigida di Svezia
1/ Motivi di un pellegrinaggio
Brigida, ovvero Birgitta Birgersdotter, nacque in Svezia, ma morì nel Palazzo sito in piazza Farnese nel 1373, dopo avervi vissuto per circa 19 anni.
Come al tempo della conversione dei primi cristiani in Scandinavia ad opera del monaco benedettino Oscar/Ansgario, nel IX secolo, il rapporto con Roma fu decisivo, così tale relazione continuò anche al tempo di santa Brigida che giunse in pellegrinaggio nell’urbe nel 1349, per il Giubileo del 1350.
Nel primo periodo della sua vita ella visse con il cuore tutto rivolto alla sua terra, avendo sposato Ulf, governatore di un importante distretto del regno di Svezia, dal quale ebbe otto figli. La sua casa fu una vera “chiesa domestica” e seppe avvicinare il marito sempre più alla fede ed educare la loro discendenza, al punto che più tardi anche la figlia Karin/Caterina venne canonizzata, tanto la sua vita fu di santità.
I due sposi entrarono nel Terz’ordine francescano, la forma pensata da Francesco d’Assisi per chi aveva la vocazione di vivere da cristiano laico e, quindi, mantenere il possesso dei beni e l’uso del denaro, nel dono di sé in famiglia e nel lavoro. I due fondarono anche un ospedale per sostenere viandanti e poveri.
Dopo un pellegrinaggio a Santiago la decisione di vivere la fede si fece ancora più radicale nei due che iniziarono una vita di preghiera e di penitenza, legata al monastero cistercense di Alvastra. Al momento della morte del marito, nel 1344, Brigida decise di non risposarsi, ma di vivere come vedova, offrendo al Signore, secondo quanto proposto dalle lettere di Paolo, la propria vita da quel momento in poi.
Nel 1349 Brigida abbandonò la Svezia per sempre, giungendo a Roma. Voleva che il papa approvasse il suo progetto, ispiratogli dal Signore, di fondare un nuovo ordine religioso, intitolato al Santo Salvatore, con un ramo femminile ed uno maschile, entrambi guidati però da un’unica abbadessa – questo fatto dice quale dignità abbia la donna, come madre nello Spirito, per la fede cristiana.
A Roma visse da vedova, portando in capo un velo bianco, insieme alla figlia Karin/Caterina, accompagnata da due confessori tramite i quali divenne una delle donne che più conoscevano in città la Sacra Scrittura e la teologia, ben più di gran parte del clero di allora, e si dedicò all’apostolato e alla preghiera, intervenendo pubblicamente nella vita della città e della sua chiesa.
Come Caterina, si rivolse ai pontefici, allora residenti ad Avignone, perché prendessero la ferma decisione di tornare a Roma, come voleva il Signore. Santa Caterina da Siena era più giovane di Brigida di Svezia, e morirono entrambe nell’urbe, Brigida nel 1373 e Caterina nel 1380, proprio per questo loro amore alla Chiesa di Roma.
Da Roma Brigida si recò in pellegrinaggio in moltissimi luoghi, ma soprattutto ad Assisi e in Terra Santa, suo grande desiderio.
Molti fra gli svedesi residenti a Roma, fra i pellegrini scandinavi e fra gli stessi romani, avvertirono la verità della sua testimonianza e la visitavano in continuazione, di modo che la sua abitazione divenne un cenacolo di condivisione della fede.
Brigida ottenne che la figlia desse vita a Vadstena ad un monastero che vivesse secondo la sua intuizione e Karin/Caterina fu la prima badessa del nuovo ordine, anche se la madre deve essere considerata come la vera fondatrice, sebbene non abbia mai visitato di persona la nuova fondazione.
Brigida ebbe circa 700 visioni, delle quali 600 avvenute a Roma, nel Palazzo in cui abitò e dove sorge ora la sua chiesa. In esse si manifesta come Brigida dialogasse con Dio stesso, con la Vergine e con i santi, anche se Giovanni Paolo II ha affermato che la canonizzazione non significa che tutte debbano essere accolte acriticamente, bensì che la Chiesa ha verificato “l’autenticità complessiva della sua esperienza interiore”.
Solo per fornire un esempio, il pittore Niccolò di Tommaso ha rappresentato la santa, ancora vivente, nel 1373—1375, in una tavola conservata ai Musei Vaticani, che “vede” la Madonna inginocchiata dinanzi al Bambino Gesù che ha appena partorito e che gli dice: “Mio Signore e mio Dio e mio Figlio”.
Brigida morì nel 1373, prima del ritorno definitivo di papa Gregorio XI da Avignone a Roma. Sepolta in un primo momento nella chiesa di San Lorenzo in Panisperna in Roma, le sue reliquie vennero portate a Vadstena un anno dopo dai suoi figli Birger e Karin, dove è possibile venerarle nuovamente, dopo che furono messe da parte nel corso della Riforma che pose fine a quell’esperienza monastica, conservando solo la chiesa abbaziale ed abbattendo le restanti strutture.
La rinascita del monastero di Vadstena così come del complesso romano di Brigida in età moderna si deve ad una nuova santa svedese che può essere considerata come una seconda Brigida: santa Maria Elisabetta Hesselblad, canonizzata da papa Francesco.
Convertitasi al cattolicesimo, trascorse su suo espresso desiderio le fasi più gravi della sua malattia proprio nel Palazzo di Santa Brigida. Inaspettatamente guarita, ebbe il permesso di ripristinare nel 1911 l’ordine brigidino, ma con nuove costituzioni che prevedevano una grande attenzione all’ideale ecumenico che andava maturando. Proprio nella casa di Santa Brigida la Hesselblad portò così avanti l’esperienza della preghiera ecumenica e la casa divenne il primo luogo di redazione della rivista Unitas.
2/ Visitando la chiesa
Santa Brigida abitò in Roma inizialmente in un edificio che sorgeva dove è ora il Palazzo della Cancelleria, ma presto una sua amica romana, Francesca Papazuri, le mise a disposizione il cosiddetto Palatium Magnum, oggi noto come Casa di Santa Brigida, che non possedeva ancora una sua chiesa, dove visse per ben 19 anni.
Tale palazzo medioevale si alzava di due piani, mentre l’attuale ne possiede cinque. Del palazzo antico sono state preservate le due camere dove vissero Brigida e sua figlia Karin/Caterina, entrambe trasformate in cappelle. Nel corridoio di accesso alle due stanze sono esposti il cilicio e reliquie del mantello di Brigida.
La chiesa originaria venne costruita subito prima della Riforma, nel 1513, e presto, con il palazzo annesso, divenne rifugio per i cattolici svedesi che fuggivano.
La chiesa venne riedificata dalle fondamenta a partire dal 1705 nello stato attuale, mentre contemporaneamente veniva rifatto l’intero Palazzo. La chiesa si presenta così a navata unica, di stile barocco, con l’affresco della volta dipinto da Biagio Puccini ai primi del settecento con l’Apoteosi di Santa Brigida. Anche le tele alle pareti sono di sua mano e rappresentano episodi della vita della santa e alcune delle sue visioni.
Nel presbiterio, sulla destra, è la tomba di Santa Maria Elisabetta Hesselblad, che si può venerare anche dal chiostro.
Nella cripta della chiesa si trova la Cappella di Santa Caterina in onore della figlia di Brigida. Inaugurata nel 1972, su volere di papa Paolo VI, è utilizzata dalla Chiesa svedese per le funzioni evangeliche luterane.
Santa Brigida rappresenta così anche oggi un rinnovato ponte di unione tra Roma e la Svezia, che si è rafforzato quando nel 1951 la Svezia luterana permise per la prima volta la celebrazione di messe cattoliche al di fuori delle ambasciate, quando nel 1982 si giunse a piene relazioni diplomatiche fra la Santa Sede e la Svezia e quando, nell’anno 2000, il luteranesimo cessò di essere la religione di Stato.
Anche oggi la Casa di Santa Brigida e la sua Chiesa sono come una “piccola Svezia” in Roma e la preghiera ecumenica sostiene la consapevolezza del comune Battesimo, della comune fede trinitaria, del dono comune di aver riconosciuto Cristo vero uomo e vero Dio: Battesimo, fede trinitaria e fede cristologica sono un tutt’uno e che potrebbero esistere l’uno senza le altre.
15/ Basilica di Santa Cecilia. Santa Ildegarda di Bingen
1/ Motivi di un pellegrinaggio giubilare
I luoghi più idonei per ricordare Ildegarda di Bingen a Roma sono i monasteri benedettini e Santa Cecilia in Trastevere è uno di questi.
Benedetto di Norcia, che da laico studiò a Roma abitando secondo la tradizione in una casa oggi trasformata nella chiesa di San Benedetto in Piscinula, è colui che dette vita stabile al monachesimo d’occidente: del modo di vivere insegnato dalla sua Regola Ildegarda si fece discepola.
Non solo: Ildegarda venne confermata nella sua testimonianza quando il vescovo di Roma, il papa Eugenio III, mentre presiedeva un sinodo a Treviri, lesse un testo della badessa presentatogli dall’Arcivescovo Enrico di Magonza, e la autorizzò a scrivere le sue visioni e a predicare in pubblico.
Già da questo si vede quanto siano fuorvianti le letture di coloro che interpretano la santa in chiave New Age, come libera pensatrice facente capo a sé sola. Essa fu, invece, una monaca di clausura benedettina che servì la Chiesa del suo tempo, presiedette alla sua comunità monastica e predicò il Cristo.
Già all’età di otto anni fu accolta come oblata presso la badia benedettina di Disibodenberg, e alla morte della badessa (il nome allora era quello di magistra) lo divenne lei stessa intorno al 1136.
Intorno al 1150 fondò un nuovo monastero sul colle chiamato Rupertsberg, nei pressi di Bingen, e poi uno ancora sull’altra riva del fiume e di entrambi fu badessa. Predicò in tantissime città, secondo il mandato di papa Eugenio III e dei suoi successori Adriano IV e Alessandro III, come Colonia, Treviri, Liegi, Magonza, Metz, Bamberga e Würzburg.
Già da questo si vede quanto la donna cristiana, anche nel medioevo, avesse autorevolezza nell’annunziare Cristo.
Addirittura, quando l’Imperatore Federico Barbarossa promosse lo scisma facendo eleggere in successione tre antipapi in opposizione al papa Alessandro III, Ildegarda, ispirata da Dio in visione, lo apostrofò ricordandogli che anch’egli era sottoposto al giudizio divino, scrivendogli: “Guai, guai a questa malvagia condotta degli empi che mi disprezzano! Presta ascolto, o re, se vuoi vivere! Altrimenti la mia spada ti trafiggerà!”
Come nell’odierna comunità benedettina di Santa Cecilia, così Ildegarda visse sempre con le consorelle, accompagnata dal monaco Volmar, che fu suo segretario e consigliere spirituale. Nelle miniature che accompagnano i suoi libri Ildegarda è spesso ritratta anche con Richardis di Strade, sua consorella monaca, e tutto attesta questa sua fedeltà alla vita comunitaria nella carità di Cristo in monastero.
Nel proclamarla dottore la Chiesa ha inteso sottolinearne anche il carisma dell’illuminazione teologica, dello studio, della carità intellettuale del suo insegnamento, come ha scritto papa Francesco in riferimento a lei: “Questo legame tra santità e intelligenza delle cose divine ed insieme umane rifulge in modo del tutto particolare in coloro che sono stati ornati del titolo di dottore della Chiesa”.
Ma è proprio del monachesimo benedettino aver dato vita ad una sintesi che verrà così definitiva: “Ora et labora et lege”, cioè “Prega, lavora e studia”, come una triade che illumina la vita monastica.
Nelle sue opere, nate spesso dalle visioni che la aiutavano a capire la fede cristiana, Ildegarda mostra una consapevolezza dell’unità del disegno divino che le permette di scrivere con sintesi geniali: per lei sono la creazione, l’incarnazione e il ritorno del Signore tutti insieme a mostrare come l’intera storia abbia un senso.
Una famosa miniatura mostra una delle sue visioni con l’uomo che è al centro dell’universo, abbracciato dal fuoco della Trinità e dalla paternità del Padre. Tale rappresentazione mostra come la centralità dell’uomo affermata dall’umanesimo era già presente da sempre nella teologia cristiana: il Rinascimento ancora la riconobbe perché riteneva l’uomo una creatura voluta direttamente dal Creatore e salvata dal Cristo nel dono dello Spirito: sarà l’età moderna a non credere più all’unicità e alla centralità dell’uomo quando abbandonerà l’idea di creazione e di salvezza e l’uomo sarà solo uno delle tante realtà transeunti nel fluire della natura, ridotto ad un essere senza alcuna importanza.
Il corpo stesso venne visto da Ildegarda non come un peso per l’anima, bensì come costitutivo e capace di ricordare all’uomo il fatto di essere un dono, capace di ricordare all’uomo la propria creaturalità.
Ildegarda insegna nei suoi scritti come sia la grazia di Cristo a salvare l’uomo attraverso l’opera della Chiesa e dei suoi sacramenti e come tale comunione con Dio sia realmente raggiungibile, nonostante i peccati della comunità cristiana.
Gli studi che Ildegarda compì e propose alla sua comunità monastica riguardano tutto il sapere, dalla medicina alla botanica, dalla musica, in cui vide un segno dell’armonia della creazione divina, alla letteratura, sempre cercando di collocarle nella luce propria che la teologia le conferiva.
Ildegarda morì nel 1179 nel monastero di Bingen.
2/ Visitando la basilica
La basilica di Santa Cecilia nasce, secondo la tradizione, sulla casa dove visse la santa, e già in età paleocristiana si ha notizia di un titulus e della chiesa. Fu però solo nel 1527 che papa Clemente VII vi insediò il monastero delle benedettine, dopo che già diversi ordini religiosi, fra cui i frati Umiliati vi avevano abitato.
Le reliquie della martire Cecilia sono collocate sotto l’altare e dinanzi ad esse è la statua che Stefano Maderno scolpì a 23 anni, nel 1599. A partire dal periodo controriformista in tutta la città tanti, non solo San Filippo Neri e Cesare Baronio, vollero che si riscoprissero le radici della Chiesa di Roma e le storie dei martiri e dei santi dei primi secoli.
Fu così il cardinale Paolo Emilio Sfondrati, divenuto titolare della basilica, ad organizzare scavi che portarono in quell’anno al rinvenimento del corpo della santa – corpo che era stato traslato qui nel IX secolo.
La statua mostra la Santa così come venne rinvenuta nel 1599. Sul collo si vedono i segni di tre colpi di spada, inferti dal boia senza riuscire ad ucciderla, e il gesto delle tre dita che venne interpretato come l’estrema testimonianza della fede nella Trinità.
È certo che Cecilia sia stata martire e che fosse amatissima, poiché già la ricorda l’antichissimo Canone Romano – la Preghiera eucaristica I – insieme alle altre martiri veneratissime dal popolo di Dio: «Felicita, Perpetua, Agata, Lucia, Agnese, Cecilia, Anastasia».
Nella Passio composta nel V secolo, Cecilia è descritta come una nobile romana fidanzata a Valeriano che è pagano il quale scopre dopo le nozze che la sua amata desidera vivere le nozze in castità, per amore di Dio – per cui esiste la tradizione iconografica delle “nozze mistiche” di Santa Cecilia con la versione famosa di Guido Reni.
La fede della santa converte lo sposo e anche suo fratello Tiburzio che si fanno battezzare, ma il prefetto di Roma conduce al martirio prima i due fratelli e poi anche Cecilia, perché non vogliono venerare gli idoli.
Un primo tentativo di farla morire sarebbe stato condotto tramite i fumi dei bagni termali – che la tradizione localizzerà proprio qui a Santa Cecilia -, ma solo la decapitazione la condurrà alla morte, con un’agonia di tre giorni.
Sepolta da papa Urbano, nelle catacombe di San Callisto, papa Pasquale nell’alto medioevo traslerà poi il suo corpo nella basilica.
Santa Cecilia è la patrona della musica – sempre rappresentata con l’attributo iconografico di un organo a canne o, comunque, con altri strumenti musicali. Ciò deriva dalla Passio nella quale si dice che, mentre andava alle nozze, cantantibus organis, Caecilia in corde suo soli Domino decantabat dicens: fiat cor meum immacolatum. Questo “canto” interiore è stato poi trasfigurato dalla tradizione ad esprimere un amore per la musica offerta a Dio.
L’abside rappresenta sempre nelle Chiese cristiane l’oriente, la luce che dà orientamento all’esistenza e verso cui la comunità che celebra è in cammino. In Santa Cecilia si è conservato il mosaico absidale del tempo di papa Pasquale I (817-824), nella cosiddetta età carolingia – ma tutta la basilica doveva essere stata ricoperta di mosaici.
Al centro sta il Cristo: ha un rotolo in una mano, segno che egli è la Parola stessa, mentre nell’altra mano stanno l’anulare e il pollice uniti, in segno di benedizione. Su di lui appare la mano del Padre che lo incorona. Nell’arco si vede il monogramma di Pasquale I.
Alla destra ed alla sinistra del Cristo stanno Pietro e Paolo con i loro simboli iconografici: le chiavi ed il libro. Dal lato di San Paolo, si vede Santa Cecilia che presenta a Cristo papa Pasquale I che reca nelle mani il modellino della chiesa stessa di Santa Cecilia che offre al Signore. Dal lato di San Pietro si vedono invece San Valeriano e Sant’Agata, patrona dell’antico monastero insieme a Santa Cecilia.
Le due palme a destra ed a sinistra, unitamente ai fiori ed alla vegetazione, dicono lo splendore del Paradiso e la sua fecondità. Sulla palma di sinistra si vede chiaramente la fenice, simbolo di immortalità.
Nella fascia inferiore Cristo è presente nel simbolo dell’agnello, duplicando l’immagine superiore. L’agnello è su di un monte paradisiaco da cui sgorgano i quattro fiumi della vita, ripresi da Genesi e dall’Apocalisse.
Dodici pecore, simboli degli apostoli – e dell’intera chiesa fondata su di loro –, si rivolgono verso l’agnello, uscendo dalle due città di Betlemme e Gerusalemme ed avvicinandosi.
Papa Pasquale I ha un’aureola quadrata ad indicare che egli era ancora vivente al momento della realizzazione del mosaico. Lo stesso pontefice realizzò anche il mosaico absidale di Santa Prassede e quello di Santa Maria in Domnica alla Navicella.
Il ciborio sopra l’altare ha sempre la funzione di solennizzare simbolicamente il luogo dell’evento sacrificale-eucaristico. Quello di Santa Cecilia è magnifico.
L’opera è firmata da Arnolfo di Cambio e datata all’anno 1293 e segue di una decina di anni circa il ciborio arnolfiano di San Paolo fuori le Mura ed appare evidente l’evoluzione artistica del maestro, che diviene sempre più consapevole dei suoi mezzi espressivi.
Ai quattro angoli Arnolfo ha scolpito sul lato anteriore a sinistra Santa Cecilia, che è incoronata, ed a destra San Valeriano, suo sposo. In cima alle due colonne posteriori, invece, sono papa Urbano e Tiburzio, martirizzato insieme al fratello Valeriano. Quella di Tiburzio è forse la figura più bella: emerge dall’angolo con il cavallo sul quale è in sella. Tutto il ciborio, ma soprattutto quest’ultima figura manifesta la novità espressiva di Arnolfo, ormai pienamente capace di richiamarsi al classico, in questo caso al Marco Aurelio a cavallo, e di caratterizzare in maniera modernamente realistica le figure umane. Giotto, secondo i nuovi studi, potrebbe aver appreso a Roma o ad Assisi proprio da Arnolfo e da pittori romani come il Cavallini la lezione che poi farà sua ad Assisi e a Padova.
Sulle fronti degli archi si vedono sul lato anteriore due profeti che stendono le loro profezie, quasi inchinandosi al Signore che viene, sui due lati di destra e sinistra i quattro evangelisti e sul retro due figure femminili che rappresentano le vergini sagge della parabola.
Nella navata non appare più niente delle antiche strutture che sono state inglobate nei pilastri attuali quando la basilica ricevette la sua forma attuale nel 1724 su iniziativa del cardinale Francesco Acquaviva.
Del 1725 è il grande affresco di Sebastiano Conca che adorna il soffitto con Santa Cecilia che riceve la corona di gloria per il suo martirio dal Signore Gesù, mentre è illuminata dallo Spirito Santo e riceve la benedizione di Dio Padre.
Sul lato sinistro non vi sono cappelle laterali, perché la chiesa si appoggia al chiostro monastico, sul lato destro si trovano diverse cappelle.
La più importante è la prima, la Cappella di Santa Cecilia o “del Bagno”, perché ricorda il luogo nella quale la tradizione pone il primo martirio della santa attraverso le esalazioni del calidarium. La Cappella fu voluta nel 1599, nell’ambito delle ristrutturazioni promosse dal cardinal Sfondrati. La cappella vera e propria è in relazione, tramite una grata, con gli scavi sottostanti che sarebbero appunto quelli del bagno romano del primo martirio della santa. La pala d’altare è una Decollazione di Santa Cecilia, opera giovanile di Guido Reni che è autore anche del tondo dipinto con le Nozze mistiche di Cecilia e Valeriano.
Si apre poi la Cappella dei Ponziani, così chiamata perché antica proprietà della famiglia Ponziani, dalla quale nacque Santa Francesca Romana: la si può immaginare mentre prega in basilica. I dipinti sono di Antonio Massaro da Viterbo detto il Pastura: la pala d’altare è una Madonna della Misericordia fra i Santi Stefano e Francesca Romana.
Segue poi la Cappella delle Reliquie alla quale lavorò Luigi Vanvitelli (1700-1773), che è autore del dipinto sulla parete di destra con l’Apparizione dell’angelo a Santa Cecilia e dell’affresco del soffitto con Angeli musicanti – uniche testimonianze superstiti dei dipinti del maestro, più noto come architetto, realizzate quando era ancora giovanissimo, all’età di 23 anni.
All’estremità della navata è visibile un frammento degli affreschi del XIII secolo che dovevano ornare il nartece: esso mostra l’Apparizione di Santa Cecilia a Pasquale I per indicargli il luogo della sepoltura ed il Ritrovamento del corpo della santa da parte del pontefice.
La controfacciata era ornata dal Giudizio universale di Pietro Cavallini, che fu rovinato dai lavori settecenteschi.
Il portico in facciata venne realizzato intorno al 1200, così come il campanile - la maggior parte dei campanili romanici delle chiese di Roma vennero realizzate al passaggio fra XII e XIII secolo, da maestranze esperte in materia.
Al di sopra delle colonne, è una fascia decorata a mosaico con al centro un emblema circolare con la croce dalla quale pendono l’alfa e l’omega: simbolizzano Cristo, inizio e fine di ogni cosa. Nella stessa fascia vi sono poi i clipei con i santi titolari della basilica: Santa Cecilia ripetuta due volte (forse una delle due era precedentemente Valeriano, poi restaurato male), Sant’Agata, San Tiburzio, Sant’Urbano e San Lucio, forse papa Lucio I (253-254).
La facciata venne risistemata nel settecento, al tempo del cardinale Francesco Acquaviva.
Sotto il portico, alla destra, è stato ricostruito il monumento funebre del cardinale Paolo Emilio Sfondrati. Sopra il busto del defunto si vede un bassorilievo con la scoperta del corpo di Santa Cecilia. Il monumento è dei primi del seicento ed ai disegni delle sculture lavorò Pietro Bernini, padre di Gian Lorenzo.
Il cortile è anch’esso settecentesco, così come la sua facciata esterna che è opera di Ferdinando Fuga che la realizzò nel 1742 (il Fuga è lo stesso che fece la facciata settecentesca di Santa Maria Maggiore). Forse al posto del cortile vi era in origine un quadriportico, ma certamente la sua sistemazione odierna assolve alle stesse funzioni. Al centro del cortile è collocato un cantaro romano che doveva forse essere posto davanti alla basilica già in età medioevale.
All’interno del monastero, è possibile ammirare ciò che resta del famosissimo Giudizio universale di Pietro Cavallini. L’affresco era – come è tradizione – nella controfacciata della chiesa. Fu definitivamente coperto e irrimediabilmente rovinato nel Settecento, quando si decise la ristrutturazione della chiesa secondo i gusti dell’epoca.
La fascia che è stata riportata alla luce con i restauri è quella centrale, si potrebbe dire la più importante, quella che è la chiave dell’intera composizione che comprendeva tutta l’ampiezza della parete.
Al centro è il Cristo giudice, quel Cristo dinanzi al quale il mondo intero viene riunito alla resurrezione dei morti per il Giudizio universale. Il gesto del Cristo è più composto di quello del successivo Cristo di Michelangelo nella Sistina, ma nondimeno egli è il principale attore: seduto, egli guarda alla sua destra dove saliranno gli eletti e con la sua mano, che reca evidente il segno delle piaghe offerte per la loro salvezza, li invita.
Il Giudizio universale, infatti, non vuole innanzitutto spaventare, ma anzi vuole annunziare che esiste la speranza, anche dove tutto sembra fallire. L’età moderna ha tragicamente smesso di rappresentare la parusia e il giudizio di Cristo nelle chiese non perché ha vinto la paura, ma perché ha perso la speranza! Opere come questa del Cavallini ricordano che solo se Dio farà giustizia, solo se la storia non è l’ultima parola sulla vita del mondo, allora chi è trattato ingiustamente non lo sarà in eterno!
Nell’affresco del Cavallini Gesù è rappresentato all’interno di una mandorla, cioè come pienamente appartenente all’eternità. Si noti, però, che egli è il Cristo incarnato, che mostra le sue piaghe in maniera evidente - si vedono chiaramente anche quelle dei piedi. Ha il nimbo con la croce e si vede il suo nome in abbreviazione, ancora con i caratteri greci – c’è il chi greco – che ormai sfumano verso il latino – iota eta sigma sta divenendo IHS, cioè Iesus hominum salvator.
Intorno al Cristo stanno gli straordinari angeli dalle ali variopinte: sono i “suoi” angeli, gli angeli del Cristo, come egli stesso afferma nei vangeli. Tutti lo guardano, lo adorano, lo lodano, amandolo.
Subito a fianco si trovano la Vergine a sinistra e Giovanni Battista a destra, cioè la deesis (termine greco che significa “supplica”, “intercessione”).
Nel Giudizio l’uomo ha come suoi intercessori Maria ed il Battista – e tutti i santi – che pregano per lui. È l’ininterrotta fede della chiesa che afferma che siamo salvati per grazia di Dio e per i meriti di Cristo e di tutti i santi che, amandoci, pregano per noi.
Seguono poi i 12 apostoli, con l’iscrizione del loro nome e con i simboli iconografici del loro martirio che li rappresentano: Pietro, a differenza delle abituali chiavi, ha la croce del suo martirio, Paolo ha la spada, Giovanni il calice avvelenato che secondo la tradizione gli fu offerto e così via.
Più sotto si vedono, non complete, ulteriori raffigurazioni che ci permettono di intuire ancora meglio come doveva essere l’impianto globale. Al centro, ai piedi del Cristo, gli strumenti della passione. Ai due lati, gli angeli con le loro trombe che – secondo il racconto dell’Apocalisse – chiamano i morti alla resurrezione. Più a sinistra si vedono le avanguardie delle schiere dei salvati: prima due figure isolate, poi il gruppo dei martiri, poi quello degli ecclesiastici, poi quello delle donne.
Dall’altro lato gli angeli allontanano i dannati e, sotto di essi, doveva essere certamente rappresentato l’inferno.
Nelle pareti a fianco è possibile vedere lacerti ancora più ridotti che si sono conservati degli affreschi che decoravano tutta la navata.
Sulla parete destra della chiesa erano rappresentate le storie dell’Antico Testamento, certamente quelle di Giacobbe ed Esaù. Se ne vedono solo frammenti da due scene: dopo la colonnina tortile che fa da cesura con il Giudizio universale si vede il Sogno di Giacobbe e, più oltre, Giacobbe che carpisce la primogenitura ad Esaù – si vedono ancora parte del corpo di Rebecca e le armi di Esaù.
Sono visibili anche lacerti di un’Annunciazione che ci richiama invece ad un ciclo neotestamentario con la vita del Cristo. Infine parte del grande corpo di un San Cristoforo.
Gli affreschi del Cavallini mostrano come il nuovo modo di dipingere alla fine del duecento, in maniera più aderente all’umano e alla realtà, non sia nato unicamente a Firenze, mentre nel resto d’Italia - ed a Roma in particolare -, gli stilemi sarebbero stati ancora quelli bizantini, bensì piuttosto come uno dei centri propulsivi di sviluppo fu proprio l’urbe e la committenza papale in particolare.
Il “moderno” venne sperimentato, sostenuto ed incoraggiato proprio dai committenti degli ambienti ecclesiastici del tempo e dal pontefice in prima persona – ed anche il cantiere di Giotto ad Assisi fu una committenza papale!
16/ Sant’Ivo alla Sapienza. Santa Edith Stein
1/ Motivi di un pellegrinaggio
Visitando Sant’Ivo alla Sapienza per ricordare Edith Stein, la santa carmelitana Teresa Benedetta della Croce, ha senso perché la Stein fu ricercatrice e docente universitaria e la chiesa di Sant’Ivo è l’antica cappella dell’Università di Roma La Sapienza.
Edith Stein rappresenta appieno il nostro tempo poiché non nacque cristiana e tutta la sua vita fu una ricerca condotta certamente tramite lo studio e la ragionevolezza, ma anche attraverso la totalità della sua persona, coinvolgendo pienamente anche il desiderio: già il termine “sapienza”, differente anche se vicino al termine “scienza”, indica che alla bellezza della conoscenza razionale si deve aggiungere un altro tipo di conoscenza, necessario alla vita, poiché esistono questioni decisive che non possono essere risolte in chiave puramente matematica o logica, si pensi solo alle domande se è bene far nascere uno o più figli, se è bene sposare quella determinata persona tra le infinite che abitano la faccia della terra, se la poesia è importante per la vita, se esista una speranza dinanzi alla morte, se la propria vita e quella dell’intero genere umano abbiano senso.
L’origine della filosofia è nella ricerca della sapienza, che affronta sia le questioni quantificabili, sia quelle che sfuggono ad un principio deterministico di causalità: il desiderio di capire è antico quanto l’uomo, perché egli è l’unico animale che seppellisce i morti e celebra le nascite e le nozze, perché ne cerca il senso.
La Stein nacque nel 1891 in una famiglia ebraica della città di Breslau, che era allora in territorio tedesco, e la sua vocazione alla filosofia la allontanò inizialmente dalla pratica religiosa.
Ma presto recuperò la scoperta della dimensione spirituale tramite il suo maestro Husserl. Se Kant aveva dichiarato che le tre “idee” di Dio, dell’immortalità dell’anima e della libertà sono postulati della filosofia - e quindi necessarie ad ogni pensiero -, la fenomenologia di Husserl intendeva recuperarle più profondamente, tramite l’analisi della dinamica interiore dell’uomo, e non semplicemente accettandole perché indispensabili alla morale.
La Stein rifletté a lungo sul fatto che, se si guarda all’uomo dal suo interno, ci si accorge che l’essere persona è dato proprio da questo misurarsi con la libertà, con l’eternità e con Dio, anche quando si decidesse di non diventare credenti.
Recuperò, anche filosoficamente, la vita interiore dell’anima non solo a partire da definizioni astratte, ma ancor più a partire dal fatto che ogni uomo avverte di essere un interlocutore di Dio, capace di conoscere Dio e di rispondergli: ciò era per lei evidente dall’analisi fenomenologica, cioè dalle manifestazioni della vita interiore dell’uomo.
Edith Stein giunse, infine, dalla fenomenologia del maestro Husserl a meditare l’esperienza di santa Teresa d’Avila e l’esperienza cristiana tout court.
Kafka, nato solo otto anni prima della Stein, aveva rappresentato l’uomo come qualcuno che bussa alla porta di un castello impenetrabile, carico di domande sulla vita, senza mai però riuscire ad entrarvi: per lo scrittore praghese la vita era un assurdo incomprensibile, poiché egli riteneva che la vita fosse un’attesa senza senso di una risposta che non sarebbe mai arrivata, come chi sta alla porta e bussa, ma mai uno spiraglio si possa schiudere.
Teresa d’Avila, ben prima di lui, aveva utilizzato, invece, l’immagine del castello in senso contrario a Kafka. La porta del “castello” che rappresenta l’esistenza non è impenetrabile, l’uomo non resta sempre estraneo alla verità, anzi l’anima è la proprietaria del “castello”: il problema è che l’uomo ha dimenticato la propria dignità e si è estraniato dalla sua vera dimora, vivendo all’esterno, come un povero che chiedesse l’elemosina alle porte del castello, senza mai entrarvi.
La Stein, tramite Teresa d’Avila, giunse a recuperare l’esperienza viva dell’“anima” che cerca l’infinito. L’anima è chiamata ad entrare sempre più nel “Castello interiore”, di stanza in stanza, fin nella più intima, la stanza delle nozze con il Signore del Castello, il Cristo, suo sposo: l’anima non solo non è estranea al “castello” della verità e del bene, ma anzi è “sposa” del Signore del castello, è sposa di Cristo e il castello le appartiene, è ammessa nella stanza più recondita e più bella, dove celebra l’amore – la “settima stanza”.
Per la Stein, come per Teresa d’Avila, la vita è carica di senso, ed essa vide nella fenomenologia di Husserl una via per conoscere quel cuore di ogni cuore che è proprio di ogni uomo.
Tale scoperta andò di pari passo con la critica a Martin Heidegger, anch’egli assistente di Husserl come la Stein, che scelse invece la via del nihilismo. La Stein, ben al di là dell’adesione esplicita di Heidegger al nazismo, si accorse del suo riduzionismo dinanzi all’uomo. Heidegger non coglieva la nobiltà della persona umana, di ogni essere umano: nel suo indagare sull’uomo coglieva solo la sua relazione alle cose e ai contesti storici, ma non intravedeva in lui colui che era capace di interrogarsi sulla grandezza di Dio.
La Stein riscoprì così il pensiero di Tommaso d’Aquino e giunse a riflettere sul fatto che nell’uomo esiste “oggettivamente” una ricerca dell’assoluto che non può essere mai relativizzata, pena la perdita dell’originalità dell’essere umano.
La Stein si spinse così avanti in tale itinerario da chiedere il Battesimo. Poi giunse ad entrare in clausura, fra le suore carmelitane, per vivere personalmente l’esperienza di Teresa d’Avila.
Non abbandonò, però, mai la sua coscienza di appartenere al popolo ebraico. Tale consapevolezza fu un dono per lei: avvertì che non stava ripudiando l’ebraismo delle sue origini, ma anzi stava scoprendo ancor più la grandezza dell’elezione divina.
Nell’aprile del 1933, poco dopo l’ascesa di Hitler al potere, scrisse a papa Pio XI per denunciare l’ateismo e la pericolosità del regime del Terzo Reich, preoccupata perché voleva che la Chiesa giungesse ad un’esplicita condanna del nazismo e temeva ciò non avvenisse.
Man mano che le persecuzioni anti-semite si intensificavano, le suore carmelitane compresero il pericolo che gli ebrei correvano e, fra di essi, anche gli ebrei battezzati, come la Stein ormai monaca di clausura. Per questo la fecero trasferire dal Carmelo di Colonia.
Ma l’avanzata nazista non conosceva ostacoli. Quando i vescovi di Olanda protestarono contro Hitler per il suo antisemitismo, il dittatore del Terzo Reich ordinò che anche gli ebrei convertiti di quel paese venissero condotti nei campi di concentramento e la Stein fu prelevata addirittura dalla clausura del Carmelo di Echt nei Paesi Bassi, dove le sue sorelle l’aveva fatta trasferire nella speranza di preservarla.
Come è evidente dai suoi scritti, la Stein aveva già deciso nel suo cuore, pur restando profondamente cristiana, di voler essere una cosa sola con il popolo ebraico. Per questo si preparò ad offrire la vita nella fede.
Venne portata ad Auschwitz, dove morì nelle camere a gas il giorno stesso dell’arrivo. Insieme a lei morì nelle camere a gas anche la sorella Rosa, anch’essa fattasi cristiana e monaca: era il 9 agosto 1942.
La Stein morì sapendo che solo la sofferenza offerta in comunione avrebbe potuto essere luce nella tragedia – proprio per questo aveva scelto come nome da religiosa, Teresa Benedetta “della Croce”.
2/ Visitando la chiesa
La chiesa di Sant’Ivo alla Sapienza è il capolavoro indiscusso del Borromini.
Egli fu obbligato a realizzarla nel ristretto spazio che divideva le due ali preesistenti del palazzo dell’università dello Studium Urbis di Roma.
La facciata, secondo il migliore stile barocco, utilizza linee concave e convesse per mostrare che chi si avvicina alla chiesa è come invitato ad entrarvi.
Il concetto e l’esperienza storica di università sono una creazione del medioevo cristiano che si sviluppò con istituzioni analoghe, nate indipendentemente l’una dall’altra, a partire dalle prime: Bologna, Padova, Salerno, la Sorbona di Parigi, Oxford, Cambridge, Napoli e così via. Il sorgere e il diffondersi delle università rappresentano la scelta della via della cultura come via d’amore per l’uomo e per il mondo.
Dovunque giunse il cristianesimo nacquero da allora le università e, fino in età recente, tutte furono fondate o comunque promosse dalla Chiesa. Seguire la storia delle fondazioni di nuove università è, in fondo, seguire la storia del diffondersi della fede cristiana e del suo influsso nel mondo.
A Roma lo Studium Urbis nacque alcuni decenni dopo la fondazione delle prime grandi università e precisamente nel 1303. La Bolla di fondazione venne emessa da Bonifacio VIII: il luogo originario dei diversi edifici dove abitarono i primi maestri e studenti fu nella zona di Trastevere, come ricordano alcuni documenti.
La sede venne poi trasferita nei dintorni dell’attuale Sant’Ivo, avendo come Cappella universitaria Sant’Eustachio, finché Sisto V fece costruire l’attuale palazzo con il cortile al centro che si apre tuttora dinanzi alla chiesa.
Il nome che lo Studium urbis acquisì nel tempo è quello di Sapienza, poiché si volle sottolineare, con il motto che la contraddistinse, che ogni vera sapienza è legata al rapporto con l’infinito. INITIUM SAPIENTIAE TIMOR DOMINI (Sir 1,14; “Principio della sapienza è il timore del Signore”) recita, infatti, l’iscrizione sopra il portale principale di ingresso del palazzo.
Fu solo con il regime fascista che la Sapienza venne poi trasferita nella sede attuale, inaugurata nel 1936: Mussolini volle che l’immagine della Minerva pagana, scolpita da Arturo Martini, sostituisse in qualche modo senza cancellarlo l’antico riferimento al concetto di “sapienza” veterotestamentaria e cristiana.
Borromini iniziò i lavori della Cappella della Sapienza nel 1642, dopo dieci anni che l’incarico era stato lui conferito: essi si protrassero lungo i pontificati di Urbano VIII Barberini (1623-1644), di Innocenzo X Pamphilj (1644-1655) e di Alessandro VII Chigi (1655-1667).
Dovunque si ripetono i simboli dei diversi pontefici che via via il Borromini aggiunse, le api Barberini, le colombe Pamphilj, i monti Chigi.
Ma proprio questa malleabilità nel sovrapporre simboli, rende evidente che la chiave interpretativa dell’edificio non può essere banalmente ridotto agli stemmi dei suoi committenti.
Per capire cosa ha ispirato Borromini si deve innanzitutto partire dai simboli evidenti che egli vi ha posto e che sono indubitabili.
In facciata si vede l’Agnello poggiato sul libro con i sette sigilli. È il grande simbolo dell’Apocalisse che dice che il Cristo Agnello è l’unico a poter aprire i sette sigilli della vita e della storia – il numero sette, nell’Apocalisse, indica la totalità, in questo caso l’impossibilità assoluta di penetrare in una vera comprensione della vita. La vita era, prima di Cristo, un mistero insondabile, sigillato in maniera totale, finché l’Agnello ucciso e poi vivo si è rivelato l’unico in grado di far conoscere il mistero. Il bassorilievo, insomma, sottolinea che quell’Agnello è la Sapienza.
In un tondo al di sopra dell’Agnello, sempre in facciata, Borromini rappresentò invece la colomba dello Spirito Santo. Tale simbolo è nuovamente presente all’interno del lanternino della cupola.
E anche all’esterno, nel punto più alto della cupola, sta il simbolo del fuoco, simbolo dello stesso Spirito Santo, in una corona: esso può essere letto sia in maniera discendente, come lo Spirito che dall’alto viene ad illuminare la ricerca umana, sia, al contempo, come ascendente, poiché tutta la sapienza umana tende a Dio.
Alla base del tamburo stanno poi tondi con il Chi e il Rho greci – il cosiddetto monogramma costantiniano –, le iniziali greche del titolo di Cristo attribuito a Gesù, ad indicare che quella Sapienza che viene dall’alto si è fatta carne in Gesù e in lui si è rivelata e tutto compie.
Borromini voleva pure che le sette colonne che avrebbero circondato l’altare - e che non vennero poi realizzate, ma sono disegnate in un suo schizzo - ricordassero la Sapienza divina, come recita uno dei tre versetti biblici che egli stesso volle trascrivere a fianco del progetto della pianta di Sant’Ivo: “Excidit columnas septem”, “la sapienza ha intagliato le sue sette colonne (Pr 7,1) – gli altri versetti copiati a mano dal Borromini sono “Sapientia aedificavit sibi domum”, “La sapienza ha edificato per sé una casa” (ancora Pr 7,1) e "Proposuit mensam suam", “La Sapienza ha imbandito la sua tavola” (Pr 7,2).
Si vede qui come il Borromini abbia intrecciato i diversi riferimenti veterotestamentari alla Sapienza, arricchendo il motto dello Stuidum urbis che proviene dal Siracide con altri versetti che provengono, invece, dal libro dei Proverbi.
Ciò era per lui naturale, perché tutta la tradizione cristiana aveva riferito i brani veterotestamentari relativi alla Sapienza a Cristo, secondo il procedimento della tipologia. Nell’Antico testamento è già presente Cristo in “figura”, come “pre-figurazione”, come “anticipazione”.
Insomma la Sapienza personificata nei diversi libri sapienziali è stata intesa come figura del Logos, come figura del Figlio di Dio fattosi carne.
Il motto dello Studium urbis intendeva sottolineare come non esistesse vera “sapienza” senza il rivolgersi dell’uomo a Dio. Il “timore del Signore” è, infatti, nel linguaggio della Chiesa, la fede: la somma sapienza è credere in Dio.
Nell’architettura e nei simboli del Borromini quel motto si amplia a mostrare che la fede è fede nel Cristo, vera Sapienza di Dio. Sapienza – e “inizio della sapienza” - era guardare al Cristo, creatore dell’universo, lui che solo conosce ogni cosa e le sue leggi, ogni creatura e il suo fine.
Ovviamente la tipologia che viene esplicitata dal Borromini era già cara a chi scelse nel medioevo il motto – si pensi anche al fatto che nel Siracide si dice che “pienezza di sapienza è temere il Signore” (Sir 1, 16), che il “timore del Signore è corona della sapienza” (Sir 1, 18) – e, in effetti, l’architettura del Borromini ha in cima una corona -, che “radice di sapienza è temere il Signore” (Sir 1,20).
Ma egli la rende esplicita. E la rende esplicita ben al di là dei simboli del Cristo Agnello e Sapienza, del Cristo con il suo monogramma e della colomba dello Spirito.
Borromini volle, infatti, che fosse l’insieme dell’architettura a parlare della Sapienza veterotestamentaria e cristiana. L’arte di Borromini – così come di ogni grande artista - non è banalmente didascalica, quasi che ogni particolare debba avere un significato individuabile in dettaglio.
È l’intera architettura ad esprimere l’armonia della Sapienza e la sua forza divina capaci di trasformare tutto in bellezza e in luce. È l’intera architettura a mostrare come tutto abbia inizio e compimento “dall’alto” e “in alto”, cioè nel “Cristo Sapienza”. È l’intera architettura di Sant’Ivo a rappresentare in maniera visiva la Sapienza creatrice e salvatrice del Cristo.
Tutte le diverse forme geometriche dello spazio che via via si ricompongono in Sant’Ivo giungono infine alla cupola, alla forma circolare espressione del divino. Nella chiesa non c’è un solo angolo retto e tutto è creatività senza spigoli. Tutto è avvolto dalla Sapienza divina e non c’è niente che ne resti escluso.
Il ripetersi di andamenti ternari che si abbracciano a vicenda è un rimando evocativo, non didascalico, al Padre che riempie il mondo del Figlio/Sapienza, nel dono dello Spirito Santo. Se anche, come sostengono a ragione molti, nella pianta potrebbe essere visto anche un riferimento al simbolo dell’ape, sarebbe una banalizzazione vedere tale pianta solo come un omaggio alla famiglia del papa Barberini - fra l’altro, da sempre, l’ape, nell’iconografia non cristiana e in quella cristiana, è simbolo della dolcezza della sapienza dei sapienti e qui della Sapienza somma.
Anche gli studi che vorrebbero enfatizzare la presenza dello Spirito Santo come chiave di lettura dell’architettura di Sant’Ivo non sono da opporre agli altri che sottolineano maggiormente la presenza divina: è proprio, infatti, grazie allo Spirito Santo che la Sapienza del Cristo riempie di sé l’intero cosmo.
All’interno, sull’arco della nicchia dell’altare, è il cartiglio a lettere dorate che ripete: Initium sapientiae timor Domini. Esso venne aggiunto nell’ottocento, ma ripresenta alla lettera il motto dello Studium urbis.
La chiesa di Sant’Ivo venne dedicata ai diversi patroni delle facoltà, a Leone Magno papa (per la teologia), a Pantaleone medico (per la medicina), a Luca evangelista (per l’arte), a Caterina d’Alessandria martire (per la filosofia), ma il nome scelto fu quello di sant’Ivo, patrono della facoltà di giurisprudenza.
Sant’Ivo di Kermartin è un santo bretone, nato nel 1253, il quale, dopo aver studiato teologia e diritto anche a Parigi, venne ordinato prete e difese i diritti della Chiesa contro le pretese del Re di Francia, ma soprattutto difese gli oppressi al punto da meritarsi il titolo di Avvocato e Patrono dei poveri. Morì mentre era parroco nel 1303, lo stesso anno di istituzione dell’Università della Sapienza. Venne canonizzato nel 1347.
La pala d’altare, di Pietro Berrettini da Cortona (1596-1669), lo raffigura mentre riceve le suppliche dei poveri. Nella gloria degli angeli sono raffigurati anche San Pantaleo, San Luca, Santa Caterina d’Alessandria e San Carlo Borromeo, protettori delle altre facoltà.
Nel 1741 vennero rimosse dalle nicchie le statue dei dodici apostoli, dette anche “babbuini” per la loro deformità, che erano state aggiunte dopo il Borromini.
Sull’altare, è un quadro raffigurante la Madonna in preghiera, copia dall’originale di Giovanni Battista Salvi da Sassoferrato, che dipinse molte volte questo soggetto alla metà del seicento. Tale immagine aiuta a comprendere l’invocazione Maria, mater Sapientiae, poiché a Lei, che è la Madre di Cristo Sapienza, si chiede di intercedere perché la sua sapienza discenda nelle menti degli uomini.
17/ Santa Maria sopra Minerva. Santa Caterina da Siena (e L’Europa a Roma: Finlandia)
1/ Motivi di un pellegrinaggio
Caterina da Siena giunse a Roma per l’ultima e decisiva volta nella sua vita nel novembre del 1378, convocata personalmente da papa Urbano VI. Vi soggiornò circa un anno e mezzo, e qui morì il 29 aprile del 1380, all’età di 33 anni, pronunciando le stesse ultime parole del suo Amato Sposo Crocifisso: «Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito» (Lc 23,46).
Roma e il papato vivevano una scissione interna profonda e pericolosa. L’elezione lecita e valida di papa Urbano VI nell’aprile di quell’anno aveva lasciato scontenta una fronda di cardinali francesi che, ritiratisi a Fondi, nel settembre dello stesso anno, avevano eletto un anti-papa, Clemente VII, sconfessando il pontefice e minacciando di marciare su Roma per impossessarsi militarmente del soglio. Lo stesso popolo romano era in agitazione, spossato dalle continue guerre civili, dalla povertà e dai domini stranieri. Due papi significavano anche scissione in Europa: dietro ai dissidenti francesi e a Clemente VII vi era l’appoggio di Francia, di Giovanna di Napoli, della Savoia, del Piemonte, del ducato del Monferrato, della Scozia; con il papa legittimo invece si schieravano l’imperatore Venceslao, la Baviera, il Lussemburgo, Magonza, l’Inghilterra, le Fiandre, Luigi d’Ungheria e la Polonia.
Urbano VI chiamò Caterina a Roma perché riunisse e compattasse le forze fedeli al papa, e per ricevere lui stesso, troppo impaurito, sostegno. Le cronache riportano l’impressione stessa del pontefice dopo un lungo discorso della piccola donna senese alla presenza sua e di tutto il nuovo concistoro:
«Vedete, fratelli miei, come ci rendiamo spregevoli agli occhi di Dio quando ci lasciamo impaurire. Questa povera donnetta ci fa vergogna, e io la chiamo così non per lei, ma per la debolezza del suo sesso, che avrebbe potuto spaurirla anche se noi fossimo stati pieni di ardimento: e invece è lei che fa coraggio a noi! Non è questo un argomento di confusione per noi?» (Legenda Maior, 334).
Caterina era una donna autorevole solo per la sapienza e il vigore del suo dire. Aveva svolto un ruolo decisivo con il precedente papa Gregorio XI, esortandolo impetuosamente a tornare a Roma dall’esilio avignonese («Venite, venite, venite!», aveva scritto nella Lettera 206), e ad essere «virile» nella fedeltà al Sangue del Signore Crocifisso. Sotto Urbano VI lavorò con tutta sé stessa per mantenere la Chiesa unita e per rammentare al nuovo papa il suo ufficio di «dolce Cristo in terra» - sono veramente straordinarie, per passione e veemenza, le lettere scritte ai due papi.
Dirà di sé stessa, in questa ultima fase della vita: «Voi vedreste andare una morta a santo Pietro, ed entro di nuovo a lavorare nella navicella della santa Chiesa. Ivi mi sto così, infino presso all’ora del vespro… senza alcun cibo… eziandio senza la gocciola dell’acqua, con tanti dolci tormenti corporali quanti io portassi mai… tanto che per un pelo ci sta la vita mia» (Lettera 373).
Ogni giorno lo stesso percorso per andare a pregare nella Basilica Apostolica: dall’attuale piazza Santa Chiara, vicino il Pantheon e la Basilica di Santa Maria sopra Minerva, lungo la via papalis (l’attuale via del Governo Vecchio), fino a San Pietro. Si trascinava stremata, aiutata dai commercianti della zona e amica dei poveri della strada.
«Sangue! Sangue! Sangue!» gridava spesso. Il Sangue dell’Unigenito Agnello di Dio sgozzato; il Sangue versato sulla Croce; il Sangue che ella desiderava versare come martire di Cristo. Caterina sentiva su di sé il peso di tutta la Chiesa e di tutto il peccato che la infettava. Lo portava con una forza straordinaria. Alcuni suoi discepoli la videro come lottare con invisibili (a loro) nemici che la vessavano.
Morì senza niente di suo, e con una numerosissima compagnia di figli spirituali che la piangevano. Il suo corpo, nei tre giorni in cui fu esposto prima della sepoltura, fece miracoli e grazie numerosissime. È sepolta a Roma nella Basilica di Santa Maria sopra Minerva, dove il suo padre spirituale e biografo, il beato Raimondo da Capua dell’Ordine dei predicatori, fu priore illustre per anni.
Nei pressi del Seminario francese di Santa Chiara è la casa dove abitò e morì, visitabile ora all’interno del Palazzo Santa Chiara. I muri di quella residenza sono invece stati trasferiti in Santa Maria della Minerva. Nella basilica di San Pietro è ancora visibile, anche se in una sistemazione diversa dai tempi di Caterina e completamente, il mosaico con la navicella di San Pietro realizzato da Giotto, nel portico di accesso alla Basilica, dinanzi al quale la Santa pregava – è dinanzi al portone centrale della basilica, quando si esce da essa.
Tutta la sua vita e la sua vocazione sembrano essere segnate e incluse sotto un indirizzo chiaro: l’unità e la pace della Chiesa («Pace! Pace! Pace!» scriveva a Gregorio XI, Lettera 196). All’età di 6 anni ebbe la sua prima esperienza mistica: il Cristo glorioso le apparve vestito con le vesti di Sommo Pontefice, la tiara e il pastorale e lei comprese di dover amare nel pontefice il Figlio di Dio. Alla fine della sua vita si recò ancora a Roma a lavorare per la «navicella» della Chiesa e ad evitare altri scismi.
Proprio per questo non risparmiava anche di correggere i costumi della Chiesa, perché ne risplendesse la luce: «Ohimé, non più tacere! Gridate con cento migliaia di lingue. Veggo che, per tacere, il mondo è guasto, la Sposa di Cristo è impallidita, tòltοgli è il colore, perché gli si è succhiato il sangue da dosso, cioè il sangue di Cristo» (Lettera 16). Eppure non poteva cessare di amare e servire quella Chiesa perché essa sola donava il corpo di Cristo.
Quella di Caterina è una vicenda umana e spirituale unica e straordinaria, in cui si fondono insieme tutti gli opposti paradossali della vita cristiana: ignoranza e sapienza, debolezza e forza, contemplazione e azione, umiltà e gloria. Visse nella sua casa paterna, a Siena, fino ai 20 anni, sconosciuta da tutti e insieme alla sua numerosa famiglia. Qui imparò a conoscere il suo Amato Signore che “frequentava” in intense visioni e orazioni. Si fortificò l’animo con gli insegnamenti che riceveva direttamente dal Maestro, con le continue lotte fisiche contro i demoni che la perseguitavano, con le incomprensioni e le umiliazioni dei familiari inizialmente ostili alle sue scelte già così precocemente definitive per il Signore; visse la penitenza e la mortificazione del corpo; fu generosa verso i poveri; ottenne di entrare nel Terzo Ordine domenicano. Iniziò ad avere esperienze mistiche decisive e all’età di 20 anni celebrò le sue nozze mistiche con il suo Amato.
Dopo questi anni di intensa formazione iniziò la vita pubblica: «Amare Dio e il prossimo», è questo il comandamento più importante. Così iniziò ad occuparsi dei poveri di Siena e a viaggiare per la Toscana e l’Italia centrale. Era maestra spirituale, era sapiente e forte, nonostante non avesse mai ricevuto istruzione scolastica e fosse fragile di corporatura. Iniziò una intensa attività di ambasciatrice di pace tra le città in guerra. Dettò lettere infuocate a conti, principi, re e regine.
È incredibile come Caterina predicasse e scrivesse da donna, ovunque e a tutti.
Continuò nel frattempo a vivere esperienze mistiche uniche, tra cui lo scambio del suo cuore, in un modo quasi “fisico”, con quello del Signore risorto.Raimondo da Capua racconta che il Signore Gesù le apparve con in mano un cuore umano rosso splendente, le aprì il petto, ve lo introdusse e disse: “Carissima figliola, come l’altro giorno presi il tuo cuore che tu mi offrivi, ecco che ora ti do il mio, e d’ora innanzi starà al posto che occupava il tuo”.
Nel 1378 era ormai allo stremo delle forze. Il suo corpo era ridotto alle sole ossa. Non mangiava più nulla se non l’amatissimo Corpo Eucaristico del suo Signore. Era sfinita dalla lotta interiore e dalle continue estasi, che nell’ottobre del 1378 la rapivano frequentemente, consentendole però di dettare un capolavoro di dottrina, spiritualità e mistica quale è il suo Dialogo della Divina Provvidenza: il «libro» che ella scrisse in colloquio diretto con l’Eterno Padre.
Due domande possono collocarsi al centro di tutta la sua spiritualità, domande che permangono eternamente valide perché poste e pronunciate da Dio stesso in una visione: «Sai, figliola, chi sei tu e chi sono io? Se saprai queste due cose, sarai beata!». Tra questi binari la vicenda esistenziale e spirituale di Caterina si colloca e si sviluppa, in un crescendo di passione e azione che solo una donna «pazza d’amore» per il suo Signore poteva sostenere. «Tu sei quella che non è; io, invece, Colui che sono. Se avrai nell'anima tua tale cognizione, il nemico non potrà ingannarti e sfuggirai da tutte le sue insidie; non acconsentirai mai ad alcuna cosa contraria ai miei comandamenti, e acquisterai senza difficoltà ogni grazia, ogni verità e ogni lume» (Legenda Maior, 92).
2/ Visitando la basilica
Già il titolo della basilica, Santa Maria sopra Minerva, offre una prima chiave per la sua visita. La Sapienza piena che è il Cristo, nato da Maria, non dimentica e non disprezza Minerva, la Sapienza antica.
Nell'area occupata oggi dalla basilica e dall’ex-convento sorgevano un tempo tre templi dedicati a Minerva ad Iside e a Seràpide: le diverse comunità cristiane che vi abitarono nell’alto medioevo e poi soprattutto i domenicani che vi giunsero nel 1256 compresero che quel legame fisico aveva anche una valenza simbolica.
Ne è testimonianza l’elefantino che è nella piazza antistante la basilica. Nei bestiari antichi quell’animale è simbolo di saggezza per la sua proverbiale forte memoria che lo contraddistingue, per cui impara e ricorda tutto ciò che vede.
Il Bernini che realizzò la scultura e vi elevò l’obelisco fece scolpire l’iscrizione: «Chiunque qui vede i segni della Sapienza d'Egitto scolpiti sull'obelisco, sorretto dall'elefante, la più forte delle bestie, intenda questo come prova che è necessaria una mente robusta per sostenere una solida sapienza». Il fatto dimostra che deve essere dato credito relativo, invece, alla voce diffamante che sia stato lì posto per porgere le terga al convento dei domenicani.
Il convento della Minerva fu, inizialmente, sotto la protezione del primo convento domenicano dell’urbe, quello di Santa Sabina all’Aventino, che ricorda anche l’incontro fra i due grandi riformatori Francesco d’Assisi e Domenico – i pontefici ebbero per tutti e due i santi l’identica visione: Francesco e Domenico sostenevano il Laterano, cioè la Chiesa di Roma.
Ma il convento divenne presto autonomo già alla fine del Duecento: secondo la tradizione furono i frati architetti fra Sisto e fra Ristoro, gli stessi che edificarono Santa Maria Novella a Firenze, a progettare l’edificio in stile gotico, per cui le due basiliche possono essere considerate sorelle – anche se forse furono altri frati domenicani a elaborarne in realtà il disegno.
Solo nel 1453, l’anno della caduta di Costantinopoli, venne realizzata la facciata principale con i tre portali rinascimentali.
All’interno appare subito evidente che la struttura della basilica è gotica – è un unicum per Roma dove le architetture medioevali sono state in genere nascoste dal Rinascimento e dal barocco. Si deve però rilevare che la spoglia architettura gotica non appare immediatamente a motivo degli interventi dell’architetto domenicano fra Girolamo Bianchedi che operò verso la metà del 1800 e a cui si deve lo stato attuale della Basilica.
La ridipintura del soffitto a stelle ricorda comunque il senso di elevazione in alto che tutta l’architettura gotica intendeva ispirare, per cui solo il guardare verso Dio rende pienamente sapienti, in antico e anche oggi.
Ben al di là dell’architettura, colei che invita a guardare in alto è proprio Caterina da Siena, oggi sepolta sotto l’altare centrale. Santa Caterina morì nella sua casa che era a pochi metri dalla basilica, proprio per stare vicina ai frati e, in particolare, al suo confessore e padre spirituale, il beato Raimondo da Capua che fu anche generale dell’ordine domenicano, e che più volte risiedette a Santa Maria sopra Minerva.
Non appena la santa morì le sue spoglie vennero portate in basilica, dove per tre giorni i romani vennero a venerarla. Venne sepolta prima nel cimitero riservato ai domenicani, oggi scomparso, e poi traslata per volere del beato Raimondo, in una cappella del transetto, l’attuale Cappella Capranica. Nel 1430 sant’Antonino di Firenze, un frate che proseguì la riforma promossa da Caterina e da Raimondo, divenuto priore della Minerva, fece scolpire il sarcofago che ricopre anche oggi il corpo della santa. Solo nel 1855 le reliquie e il sarcofago bianco preparato da sant’Antonino vennero trasportate sotto il nuovo altare maggiore, dove si trovano tuttora.
Nella sistemazione attuale due angeli reggono l’iscrizione che recita “Santa Caterina da Siena dell'Ordine della Penitenza di San Domenico”, cioè appartenente ai laici del terz’ordine dei domenicani.
Accessibile dalla sacrestia, solo con permesso, è, invece, la stanza in cui santa Caterina morì e che era originariamente in piazza Santa Chiara a pochi metri dalla basilica, ma che venne smontata e ricostruita dal cardinal Barberini nella nuova sede nel 1637. Le antiche mura erano già state arricchite dalle pitture di Antoniazzo Romano e della sua scuola (1482-1483) che vennero anch’esse staccate e riposizionate; sull’altare è una Crocifissione con santi, alla cui sinistra è una bellissima Annunciazione. A sinistra dell’ingresso sono Santa Caterina che dialoga con Sant’Agostino e, poco più avanti, San Girolamo e Sant’Onofrio. A destra dell’ingresso sono, invece, il Battista e, poco più avanti, Santa Lucia e Sant’Agata. Al di sopra dell’entrata è, invece, il Cristo deposto nel sepolcro.
Sul lato esterno della camera di Santa Caterina è un busto della beata Maria Cristina di Savoia, che fu regina di Napoli a fianco del re Ferdinando nella prima metà dell’Ottocento e morì di parto dando alla luce l’erede al trono a soli ventitré anni: è stata beatificata per la sua fede profonda, per la sua carità e per il suo desiderio di promuovere la formazione delle donne cristiane.
La basilica gotica conobbe grandi mutamenti in età rinascimentale. A suo modo, mostra come l’umanesimo e il rinascimento abbiano avuto non solo Firenze, ma anche Roma come centro.
Innanzitutto la basilica conserva il corpo del Beato Angelico, che morì nel convento della Minerva nel 1455 – la tomba è a sinistra dell’altare maggiore. Il pittore fu frate domenicano a Firenze, dove affrescò il proprio stesso convento di San Marco, requisito poi all’Unità d’Italia e distaccato a forza dalla chiesa che i frati tuttora officiano: meraviglioso è vedere in quel luogo come il Beato Angelico abbia affrescato le sale del chiostro, della foresteria, le celle dei confratelli e, anche se più semplicemente, quelle dei novizi, con la famosa Annunciazione che ci si trova davanti salendo al piano dove si dormiva.
Lo volle a Roma papa Eugenio IV (1431-1447), che lo aveva conosciuto quando aveva abitato a Firenze per presiedere il concilio di Ferrara-Firenze, quando gli orientali di Costantinopoli erano venuti a Roma per chiedere una crociata contro i Turchi e offrire in cambio la riunificazione. Dei lavori compiuti dal Beato Angelico a Roma durante questa prima permanenza è superstite solo la Cappella Niccolina, con le storie dei due diaconi Stefano e Lorenzo, oggi all’interno del percorso dei Musei Vaticani (ma visitabile solo con permesso).
Nel corso dell’ultima permanenza alla Minerva, invece, l’Angelico dipinse nel chiostro del convento un grande ciclo di affreschi, oggi perduti. La critica ipotizza che illustrasse le stesse storie bibliche che figurano nel primo libro illustrato con immagini stampato in Italia, le Meditationes del cardinale spagnolo Juan de Torquemada anch’egli frate domenicano, sepolto nella Cappella dell’Annunciazione per la quale commissionò l’opera di Antoniazzo Romano di cui si parlerà a breve.
Gli studiosi ipotizzano che possa essere del Beato Angelico, anche se molto ridipinto, lo stendardo – poi applicato su tela - che è nella cappella a sinistra della sua tomba, con la Madonna con Bambino che regge il mondo nel quale sono iscritti i nomi dei tre continenti allora conosciuti, l’Europa, l’Asia e l’Africa – mancano ancora le Americhe, che vennero scoperte in quegli stessi anni, e l’Australia.
Per la sua capacità di unire la vita cristiana da frate domenicano, la sua grande capacità pittorica e la teologia espressa dalle sue opere, l’Angelico è stato dichiarato patrono degli artisti ed il 18 febbraio, giorno della sua morte, in tutto il mondo gli artisti delle diverse arti invocano la sua intercessione.
Vicino alla tomba del Beato Angelico (1455), i frati fecero porre un’iscrizione che è attribuita a Lorenzo Valla e che recita: «Qui giace il venerabile pittore Fra Giovanni dell'Ordine dei Predicatori. Che io non sia lodato perché sembrai un altro Apelle, ma perché detti tutte le mie ricchezze, o Cristo, a te. Per alcuni le opere sopravvivono sulla terra, per altri in cielo. La città di Firenze dette a me, Giovanni, i natali». La lastra tombale è, invece, di Isaia da Pisa.
Lo splendore del Rinascimento è poi evidente nella Cappella Carafa, dedicata a San Tommaso d’Aquino, che è nel transetto destro, affrescata fra il 1489 e il 1493.
La commissionò il cardinale domenicano Oliviero Carafa, protettore dei domenicani, che, su consiglio di Lorenzo il Magnifico, la affidò a Filippino Lippi.
Nella volta, dove è lo stemma Carafa, sono rappresentate quattro sibille, che vogliono indicare come anche il mondo classico attendesse un salvatore.
Al centro è l’Annunciazione che ha a fianco san Tommaso d’Aquino che presenta alla Vergine Maria il cardinale Carafa. In alto, invece, è l’Assunzione della Vergine Maria circondata da una corona di angeli che le danzano intorno, ognuno uno strumento musicale diverso.
Nella parete destra è raffigurato Il trionfo di San Tommaso sull’eresia. Il santo è rappresentato in cattedra, mentre insegna, affiancato dalla Grammatica, dalla Retorica, dalla Teologia e dalla Filosofia. Ha in mano un libro che reca scritto: “Sapientiam sapientum perdam”, cioè “Distruggerò la sapienza dei sapienti”, mentre ai suoi piedi è, come un vecchio rabbioso, l’Errore debellato con un cartiglio che dice “Sapientia vincit malitiam”, cioè “La sapienza vince la malizia” - tutta la storia dei domenicani è caratterizzata dalla ricerca della verità contro l’errore.
I personaggi in primo piano rappresentano diversi eretici e di alcuni sono rimaste le iscrizioni che li connotano e cioè Mani, Eutiche, Sabellio, mentre altre sono ormai illeggibili. Di fronte, invece, stanno contemporanei degli affreschi che riconoscono la sapienza di Tommaso, fra i quali qualcuno ha voluto riconoscere Giovanni e Giulio de’ Medici, i futuri Leone X e Clemente VII.
Sul fondo si vede Roma e si riconoscono la basilica di San Giovanni e il Palazzo Lateranense con l’antica statua equestre di Marco Aurelio che a quel tempo era vicino alla basilica.
Nella lunetta in alto a sinistra è il famoso episodio del Crocifisso che si rivolge a san Tommaso dicendogli: “Hai scritto bene di me, Tommaso”. Il significato della raffigurazione in lunetta a destra è, invece, discussa.
Gli affreschi della parete sinistra dovevano rappresentare i vizi e le virtù, ma sono andati perduti per lasciar spazio alla tomba di papa Paolo IV, uno dei cinque papi sepolti in basilica.
La Cappella dell'Annunziata, la terza della navata destra, custodisce un’altra magnifica opera del Rinascimento romano, l’Annunciazione di Antoniazzo Romano.
Venne dipinta fra il 1499 e il 1500, in vista del Giubileo indetto da papa Alessandro VI e fu commissionata dalla Confraternita dell'Annunziata, fondata dal cardinal Juan de Torquemada (1388-1468), di cui si è già parlato.
La confraternita aveva lo scopo di fornire una “dote” per il matrimonio alle ragazze povere, che altrimenti avrebbero corso il rischio di diventare prostitute.
Nell’opera si vede la Vergine Maria con l'arcangelo Gabriele che le annunzia il concepimento del Figlio di Dio, mentre la Madonna è presa dal servizio di consegnare la dote ad alcune giovani vestite di bianco che le vengono presentate dal Torquemada – egli ha un semplice abito domenicano, ma il cappello cardinalizio è ai suoi piedi.
Sempre di età rinascimentale è il Cristo risorto di Michelangelo, scolpito fra il 1515 e il 1521 – taluni ritengono che un analogo Cristo presente a Bassano Romano sia una prima versione dell’opera. Sebbene l’opera sia stata chiaramente risistemata da autori successivi – e la croce sia chiaramente posticcia -, la forza espressiva del corpo e del viso rimandano al Buonarroti che esprimeva il vigore della fede cristiana nei suoi nudi potenti.
Si è già parlato di papa Eugenio IV, che fu grande amico dei domenicani: egli volle come arcivescovo di Firenze il domenicano sant’Antonino, grande umanista, e in quegli anni si strinse un legame strettissimo fra i Medici e i frati, al punto che Cosimo il Vecchio ottenne dai domenicani uno studiolo nel convento di San Marco per ritirarsi a riflettere: anch’esso fu affrescato dall’Angelico.
I domenicani divennero, di fatto, i cappellani di casa Medici e nei secoli tale rapporto perdurò: ne è prova il fatto che i due papi provenienti dalla famiglia de’ Medici vollero essere sepolti alla Minerva. Essi sono Leone X, figlio di Lorenzo il Magnifico, morto nel 1521, e Clemente VII, morto nel 1534, il pontefice del Sacco di Roma.
In presbiterio, infatti, si vedono alla parete sinistra, il monumento funebre di papa Leone X, scolpito da Antonio da Sangallo il Giovane, Bartolomeo Bandinelli e Raffaello da Montelupo, e, alla parete destra, il monumento funebre di Clemente VII, scolpito da Antonio da Sangallo il Giovane, Bartolomeo Bandinelli e Giovanni Lippi. La statua di Leone X è circondata da due profeti a destra e a sinistra nelle nicchie, mentre in alto sono i bassorilievi con il Battesimo di Gesù, l’Incontro fra Leone X e Francesco I e il Miracolo di San Giuliano. La statua di Clemente VII ha anch’essa due profeti ai lati, mentre in alto sono la Pace tra Clemente VII e Carlo V, San Benedetto incontra Totila e San Giovanni nel deserto.
Proprio Leone X proseguì il rinnovamento culturale iniziato nel pontificato di Giulio II che aveva convocato a Roma i grandi artisti del Rinascimento, da Bramante, a Michelangelo a Raffaello.
Anche lo scultore Andrea Bregno, morto nel 1503, è sepolto in basilica con lapide che è alla parete nel transetto di sinistra, e così il grande letterato il cardinale Pietro Bembo, morto nel 1547, ha in basilica una lastra tombale che ricorda la sua sepoltura.
Vicino alla tomba del Bregno è stata posta la tomba di Luigia Tincani, fondatrice delle Missionarie della Scuola, morta nel 1976: la venerabile si impegnò per una testimonianza cristiana nella cultura, nella scuola e nell’università, con particolare attenzione alle donne, ispirandosi a san Domenico e a santa Caterina da Siena: oggi l’Università LUMSA è figlia delle sue intuizioni.
Anche l’età barocca lasciò il suo segno nel complesso della Minerva e di quel periodo è la cappella del transetto sinistro, dedicata a San Domenico e voluta da papa Benedetto XIII, anch’egli già frate domenicano, che è sepolto nel monumento sulla parete destra della cappella.
Nella pala d’altare si vedono la Vergine Maria, Santa Maria Maddalena e Santa Caterina d’Alessandria donare l’immagine di san Domenico: la rappresentazione iconografica rappresenta il racconto di un miracolo testimoniato a Soriano in Calabria nel 1530, quando le tre sante offrirono ad un fratello domenicano tale immagine del fondatore.
In questa cappella prese l’abito domenicano il celebre predicatore francese Enrico Dominique Lacordaire nel 1839.
Addossato all’ultimo pilastro della navata sinistra è, invece, il monumento funebre della venerabile suor Maria Raggi, domenicana, realizzato in età giovanile da Gian Lorenzo Bernini. L’opera è famosa per i marmi scolpiti a raffigurare un drappo di tessuto che contiene l’immagine della defunta. Essa, a sua volta, è ritratta nel momento in cui esala l’ultimo respiro con una serenità che è anelito al cielo, in maniera similare a quanto il Bernini farà per le opere ben più monumentali con l’estasi di Teresa d’Avila e di Ludovica Albertoni.
Se fin dagli inizi della loro presenza a Roma, prima a Santa Sabina e poi alla Minerva, i domenicani avevano insegnato teologia, è solo nel 1575 che il già vescovo di Cuzco in Perù, mons. Solano, decise la costituzione del Collegio di San Tommaso aperto anche a persone che non appartenessero all’ordine domenicano. Tale Collegio fu arricchito dalla costituzione della Biblioteca Casanatense, nata grazie ai donativi del cardinale domenicano Girolamo Casanate nel 1701.
Il Collegio, però, insieme all’intero convento, fu confiscato due volte dall’esercito rivoluzionario francese, prima nel 1797 e poi nel 1814 da quello napoleonico, venendo utilizzato come caserma di fanteria. I domenicani poterono tornarvi dopo il Congresso di Vienna nel 1825, ma esso venne definitivamente espropriato nel 1871 dal Regno d’Italia. Solo nel 1929 i frati riebbero il possesso di poche porzioni dell’intero complesso, che divenne infine, dopo essere stato sede di diversi ministeri del Regno, della biblioteca della Camera e del Senato, mentre la Biblioteca Casanatense, anch’essa requisita, divenne una biblioteca statale.
Quando lo spazio, ormai ridotto al minimo, non permise più ai domenicani di conservare il Collegio nella cosiddetta insula dominicana, via via costruita intorno alla basilica, l’università dei padri venne infine trasferita nella sua sede attuale dell’Angelicum, all’inizio di via Nazionale, nell’antico monastero Domenicano dei SS. Domenico e Sisto.
Dal transetto destro, si accede invece alla cappella, dedicata alla Madonna del Rosario, detta anche Cappella Capranica.
In essa la comunità finlandese a Roma iniziò ad incontrarsi per la celebrazione della messa al tempo della seconda guerra mondiale, nel 1943. All’inizio si celebrava l’eucarestia cattolica, poi, dal 1985, si dette inizio a celebrazioni ecumeniche.
Da allora, ogni anno, il 19 gennaio, giorno della festa di Sant’Enrico di Uppsala, vescovo e patrono della Finlandia, i rappresentanti delle chiese luterane, cattoliche e ortodosse pregano insieme nella Cappella Capranica, dove si trova una statua in legno raffigurante Sant’Enrico, opera dello scultore finlandese Sakari Pykälä (1992).
Enrico nacque in Inghilterra e raggiunse i territori dell’odierna Finlandia per predicare il Vangelo, insieme al re di Svezia Eric IX, anch’egli santo, giuntovi invece per una crociata.
Enrico sarebbe arrivato fino al villaggio di Ylistaro, nella contrada di Kumo, dove ancora oggi sono venerati resti della casa nella quale avrebbe predicato.
Enrico fu il primo ad annunziare la fede cristiana alle genti del luogo. Venne martirizzato da un omicida cui aveva imposto una penitenza per il suo peccato. La tradizione vuole che il martirio sia avvenuto nella palude di Kjulo. Le sue reliquie sarebbero state poi traslate nel duomo di Abo, da cui le avrebbe poi prelevate lo zar Pietro I ed esse sarebbero infine andate perdute in Russia.
Nella Cappella del Rosario la pala d’altare è una Madonna del Rosario della prima metà del XVIII secolo.
Alle pareti laterali è rappresentato un ciclo con le Storie di santa Caterina da Siena (affreschi dell’ultimo quarto del XVI secolo di Giovanni De Vecchi), che permettono di visualizzare la sua storia.
A partire da sinistra, la sua vicenda è narrata in sei tappe che rappresentano anche sei dimensioni della sua vita:
1/ L’infanzia. Prima visione di santa Caterina da Siena (Cristo in abiti papali con i santi Pietro, Paolo e Giovanni Evangelista), Carità con la crocetta donata al povero, Caterina tentata dal demonio, Esperienza eremitica
2/ La vocazione. San Domenico dona l’abito a Caterina, alla presenza di altri santi; Il padre Jacopo vede una colomba sul capo di Caterina mentre prega; Santa Caterina beve al costato di Cristo; Caterina beve il latte della Madonna
3/ La vita contemplativa. Sposalizio mistico di santa Caterina
4/ L’azione politica. Caterina ad Avignone da Gregorio XI
5/ La conformazione a Cristo. Caterina riceve le Stimmate
6/ La morte. Comunione mistica e morte di santa Caterina da Siena
Nella volta sono i Misteri del Rosario (1573), di Marcello Venusti. I “misteri” della vita di Gesù, prima di divenire preghiera mariana, sono la sintesi elaborata dall’esperienza della Chiesa per raccontare la vita di Gesù a chi si prepara a ricevere l’Iniziazione cristiana. Il Catechismo della Chiesa Cattolica chiede ai catechisti di presentare la vita del Signore (CC 512 ss.) appunto secondo i “misteri”, gli episodi cioè fondamentali della vita di Gesù nel loro significato salvifico, così come la tradizione della Chiesa li ha posti in evidenza con le feste liturgiche.
In questo modo non si trasmette la fede a partire dalla lettura di uno dei quattro Vangeli, bensì a partire dagli stessi eventi principali della sua vita. I “misteri” del Rosario sintetizzano questa esegesi e questa cristologia della Chiesa.
d/ Chiese giubilari
18/ Santa Maria in Vallicella. Chiesa Nuova
1/ Il motivo della visita
Visitare la Chiesa Nuova vuol dire incontrare san Filippo Neri e la sua storia. Egli è, infatti, sepolto nella Cappella alla sinistra dell’altare maggiore.
Filippo visse di fede e alla fede portò la Roma del suo tempo. Diceva spesso «che non si cercasse altro che Christo», dicendo anche: «Chi vuol altro che Christo non sa quel che vole, e chi vuole altro che Christo non sa quel che domanda». Diceva ancora: «Vanitas vanitatum et omnia vanitas, se non Christo…» Di più diceva che era tanto utile e necessario «questo staccamento dalle cose terrene per servire a Dio, che se havesse avuto diece persone veramente staccate e che non volessero altro che Christo, gli bastava l’animo di convertir tutto il mondo».
Era giunto a Roma, all’età di 19 anni, per lavorare come precettore di due giovani la cui famiglia viveva in una residenza immediatamente a sinistra della chiesa di Sant’Eustachio.
Ancora laico fondò, presso la chiesa della SS. Trinità dei Pellegrini, l’Arciconfraternita dei Pellegrini e dei convalescenti, con la finalità di accogliere i pellegrini e servire i malati. Tanti romani si unirono a San Filippo in quest’opera.
Nel frattempo si recava da solo in pellegrinaggio alle catacombe di San Sebastiano – nel 1544 lo Spirito Santo gli dilatò il cuore mentre pregava in quel luogo – e a quelle che erano le “sette Chiese” (itinerario che egli rese famoso proponendolo poi ai romani stessi) per pregare e radicare la sua fede sulla testimonianza dei santi e dei martiri, chiedendo a Dio di rivelargli la sua missione.
Per studiare teologia si recava presso l’Università della Sapienza e presso Santa Maria sopra Minerva. Venne infine ordinato diacono nella Basilica di San Giovanni in Laterano e poi sacerdote nella chiesa di S. Tommaso in Parione.
Dal 1551, per ben trentadue anni, Filippo Neri ormai prete fu ospite della chiesa di San Girolamo della Carità. Trovava infatti congeniale accettare la vita comune del clero, vivendo insieme ad altri sacerdoti nella stessa comunità in cui abitava il suo padre spirituale, don Rosa, che già lo aveva accompagnato da laico.
Filippo divenne poi rettore della chiesa di San Giovanni Battista dei Fiorentini dove continuò il suo apostolato. Nel 1575 Gregorio XIII gli affidò l’antica chiesa di Santa Maria in Vallicella, ridotta in rovina, dove Filippo vi si trasferì nel 1583 e visse gli ultimi anni della sua vita.
Da sacerdote amava ripetere che si deve morire su tre “legni”: quello dell’altare, quello del confessionale e quello della sedia dell’oratorio, dove teneva i suoi sermoni. Questa fede era per lui fonte costante di gioia, poiché l’allegrezza manifesta la certezza della presenza di Dio: «Voleva ancora che le persone stesser alegre dicendo che non gli piaceva che stessero pensose e malinconiche, perché faceva danno allo spirito, e per questo sempre esso beato Padre, ancora nelle se gravissime infermità, era di viso gioviale et allegrissimo, et che era più facile a guidare per la via dello spirito le persone alegre che le malinconiche».
Propose una trasmissione della fede che passava da cuore a cuore – non si dimentichi che l’Oratorio filippino non era pensato per i bambini, come la vulgata televisiva immagina, bensì per i giovani e gli adulti: nel segreto della confessione e della direzione spirituale, così come nel calore del dialogo, a tu per tu egli incontrava i romani del suo tempo.
Ma al contempo egli fu veramente l’apostolo di Roma, coinvolgendo la città intera. Quando gli venne in mente di partire missionario per le Indie, colpito dalla testimonianza dei primi gesuiti, accolse la parola del suo confessore alle Tre Fontane che gli disse: «Filippo, le tue Indie sono a Roma» - parole che esprimono la consapevolezza dell’urgenza dell’annunzio di Cristo nelle terre di antica evangelizzazione. E Filippo amava ripetere: «Chi fa il bene in Roma fa bene in tutto il mondo».
In effetti, egli non si allontanò più da Roma, spendendosi interamente per la città e trasmise questo ai suoi discepoli invitandoli alla stabilitas loci che caratterizza anche oggi l’Oratorio – un sacerdote filippino resta per tutta la vita nella comunità dove è entrato. E nemmeno si preoccupò di questioni che superassero l’orizzonte della città – tranne quando lavorò per il perdono del re di Francia Enrico IV – così come mai parlò di riforma della Chiesa, poiché si preoccupò piuttosto di realizzarla.
Nell’annunzio della fede volle valorizzare ogni aspetto della vita. Possedeva molti libri e li leggeva, così come voleva che la fede venisse espressa in musica. Per obbedienza chiese al suo discepolo Cesare Baronio, che probabilmente ispirò anche Galilei – di Baronio è la frase ripetuta dallo scienziato pisano: la Sacra Scrittura insegna«come si vadia al cielo, e non come vadia il cielo» -, di studiare storia della Chiesa per utilizzarla come via di catechesi e di predicazione. Lo spingeva in questa direzione, probabilmente, anche il desiderio di ricostruire una visione positiva del cammino della Chiesa nei secoli poiché alcune correnti protestanti volevano invece distruggerla: ma, molto più, era determinante la consapevolezza, sperimentata negli anni dei pellegrinaggi solitari, che la fede si corrobora nell’incontro con la grande tradizione ecclesiale.
Dalla Chiesa nuova parte ancora oggi il pellegrinaggio alle sette chiese cui Filippo dette nuova vita a partire dal 1552, estendendo a tutti quell’itinerario che egli aveva tante volte già compiuto da solo e che aveva ereditato dalla tradizione medioevale.
2/ Visitando la chiesa
Nel cuore dell'anno giubilare 1575, papa Gregorio XIII assegnò a Filippo Neri la chiesa parrocchiale di Santa Maria in Vallicella e, al tempo stesso, erigeva in quel luogo una Congregazione di preti col nome di Oratorio. San Filippo decise di iniziare subito la ricostruzione dell'edificio, abbattendo la chiesa preesistente che era in grave stato di degrado. La Chiesa Nuova ("nuova", appunto, rispetto alla precedente) appare oggi così nelle dimensioni con cui Filippo la pensò e la volle, nonostante i numerosi interventi successivi.
Filippo vi si trasferì solo nel 1583, per obbedienza al papa, inscenando una autoironica processione di trasloco, ma già la amava così come l'aveva voluta, grande e solenne, a servizio del popolo di Roma.
L'affresco sulla volta, dipinto da Pietro da Cortona alla metà del XVII secolo, raffigura proprio il santo durante la costruzione della Chiesa Nuova: la Madonna sostiene miracolosamente le travi in procinto di crollare sull'altare della chiesa precedente, che custodisce l'immagine della Vergine in attesa di essere trasferita nella nuova.
In una cappella del transetto, a sinistra dell'altare principale, vi è il luogo più venerato della Chiesa Nuova: il sepolcro di san Filippo. La pala d'altare è una copia in mosaico del dipinto di Guido Reni che ritrae san Filippo in abiti sacerdotali che adora la Madonna della Vallicella che regge il Bambino. I padri dell'Oratorio guidano i pellegrini nelle stanze del santo, dove molti oggetti legati alla sua vita permettono di conoscerne la figura.
San Filippo Neri, ancora vivente, volle che le pale d'altare delle cappelle laterali della Chiesa di Santa Maria in Vallicella rappresentassero ognuna uno dei "misteri di Cristo" nei quali era stata presente Maria. Con l'espressione "misteri di Cristo" si intendono quegli episodi più importanti della sua vita che sono come l’alfabeto per conoscere Gesù. Li ritroviamo oggi nei “misteri” del Rosario e il Catechismo della Chiesa cattolica nn. 512-570, spiega che è tramite tali “misteri” che si debbono introdurre i principianti ad una prima conoscenza del Cristo.
Filippo e i padri del primo Oratorio decretarono che chiunque avesse deciso di acquistare una delle cappelle laterali non avrebbe potuto stabilire autonomamente il soggetto della pala d'altare, ma si sarebbe dovuto attenere alla serie stabilita dai padri della Congregazione. Il santo ebbe modo di vedere alcune delle opere già poste nelle cappelle - è noto che l'opera che preferiva era la Visitazione di Federico Barocci che venne realizzata nel 1586 – presso la quale era il suo confessionale. Anche Caravaggio, uno dei tanti che collaborarono, realizzò la Deposizione per la Cappella Vittrici.
Seguendo l'ordine iconografico, a partire dalla cappella del transetto sinistro, questo è l'elenco delle opere: -Presentazione al Tempio di Maria Bambina del Barocci (1603);
-Annunciazione del Passignano (1591);
-Visitazione del Barocci (1586);
-Natività di Durante Alberti (precedente al 1590);
-Epifania del Nebbia (1578);
-Presentazione al Tempio di Gesù (detta anche Purificazione della Vergine) del Cavalier d'Arpino (1627);
-Crocifissione del Pulzone (1586);
-Deposizione del Caravaggio (1602, l’originale venne sostituito con una copia nel 1797, dopo il furto a opera delle truppe napoleoniche, e si trova oggi presso i Musei Vaticani);
-Ascensione del Muziano (precedente al 1587);
-Pentecoste di pittore fiammingo (originale del 1607, sostituito nel 1689);
-Assunta del Ghezzi (sostituita a metà Seicento);
-Incoronazione della Vergine del Cavalier d'Arpino (1615).
Si vede qui chiaramente come la tela del Caravaggio faccia parte di un intero ciclo pensato, dai padri dell'Oratorio in pieno contesto controriformistico. Se ogni autore lavorò esclusivamente all'opera o alle opere che gli furono affidate, nondimeno doveva essere loro chiaro il lavoro d'insieme. La serie della Chiesa Nuova permette così di vedere come si regolassero i committenti e come si instaurasse un dialogo fra l'acquirente della cappella, i padri che officiavano nella Chiesa Nuova e gli artisti.
Partendo dalla cappella del transetto sinistro, con Maria Bambina, si giunge fino all'Incoronazione della Vergine nel transetto destro.
L'andamento circolare, però, non si arresta in quel punto, ma prosegue in verticale con l'abside e la cupola. Dietro l'altare l'antichissima immagine già presente nella prima chiesa della Vallicella – e oggi custodita dietro la pala di Rubens - fa salire lo sguardo verso il crocifisso che le sta sopra e questo, a sua volta, eleva al catino absidale dove è l'Assunzione della Vergine, opera di Pietro da Cortona. Dall'abside lo sguardo si innalza a sua volta verso la cupola, sempre affrescata dal maestro di Cortona, nella quale dall'Assunzione della Vergine si sale fino alla Trinità.
Bellissimo è l'oratorio barocco del Borromini, a fianco della chiesa, pensato dai padri filippini in continuità con il pensiero di san Filippo come un tutt'uno, perché dalla celebrazione si passasse senza soluzione di continuità alla vita in Oratorio. Venne purtroppo sequestrato all’Unità d’Italia e appartiene ora, separato artificialmente dalla Chiesa Nuova, allo Stato.
Nell’Oratorio avvenivano gli incontri dei padri filippini incentrati su di una educazione alla fede cristiana, attraverso la conoscenza e la meditazione delle vite dei santi alternata ad orazioni e canti. Il noto compositore Giovanni Animuccia, amico di Filippo Neri, vi eseguiva le sue Laudi.



