Gerusalemme era contesa già prima dei monoteismi. Nel suo nuovo libro Musarra vede le ragioni della travagliata storia della città nelle molte identità millenarie che l’hanno abitata più che nelle tre religioni abramitiche, di Antonio Musarra
Riprendiamo da Avvenire un testo di Antonio Musarra, pubblicato il 5/9/2025. I neretti sono nostri ed hanno l’unico scopo di facilitare la lettura on-line. Restiamo a disposizione per l’immediata rimozione se la presenza sul nostro sito non fosse gradita a qualcuno degli aventi diritto. Per ulteriori testi, cfr. le sezioni Giustizia e carità e Contro la guerra.
Il Centro culturale Gli scritti (12/10/2025)
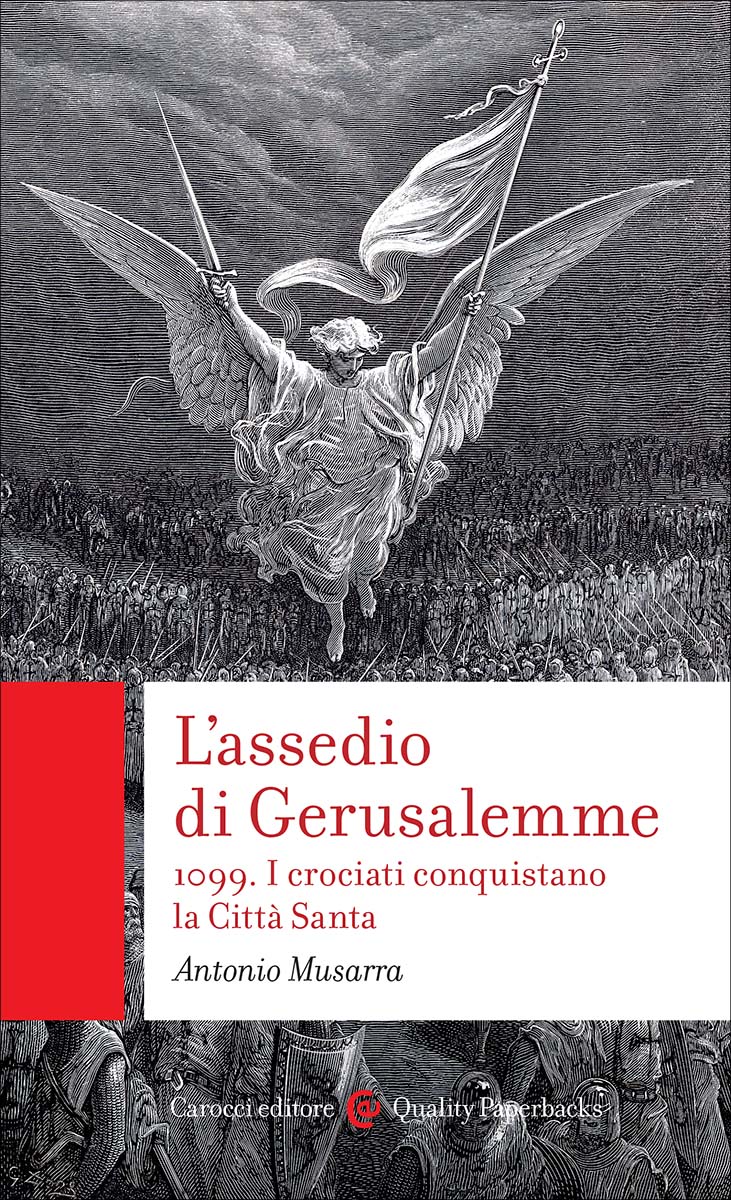
Anticipiamo ampi stralci dell’introduzione al volume di Antonio Musarra L’assedio di Gerusalemme. 1099. I crociati conquistano la Città Santa, Carocci.
Gerusalemme è stata al centro di 118 conflitti. O, almeno, questo è il dato fornito da Eric H. Cline nel suo Gerusalemme assediata.
Dall’antica Canaan allo Stato d’Israele: un numero che non fa effetto per la sua grandezza, ma per la sua desolante ripetitività. A quanto pare, la prima battaglia documentata finalizzata alla conquista del sito – null’altro che un nido di uomini, situato tra colline scoscese, oltre il deserto, al di là della Mezzaluna fertile – risale al 1350 a.C. circa.
È quanto testimonia una lettera inviata da un certo Abdi-Heba (o Abdi-Hepat), «servo di Heba», divinità hurrita, al faraone egiziano – probabilmente Amenhotep III (1391-1353 o 1388-1351 a.C.) H, ritrovata ad Amarna, in Egitto, e oggi conservata presso il Vorderasiatisches Museum di Berlino. Che l’abitato fosse popolato da elementi hurriti è, senz’altro, possibile, benché non vi siano ulteriori prove al riguardo.
La stessa identità dei Gebusei, nome con cui nella Bibbia ebraica è denominata la tribù cananea che vi abitava prima della conquista israelita, iniziata da Giosuè (Gios 11,3; 12,10) e completata da David (2Sam 5,6-10), rimane fumosa.
Certo, il documento tratteggia una situazione di conflitto. Abdi-Heba – che da altre testimonianze sappiamo essere un soldato (we’w), forse il figlio di un capo locale, inviato in Egitto per intraprendere il proprio addestramento militare – chiede aiuto per Urušalim, termine sumero-accadico che significa pressappoco “fondazione del dio Shalim”, dal semitico yry, “fondare”, “porre una pietra angolare”, accostato a Shalim, dio cananeo del crepuscolo (dunque, degli inferi), ma anche della salute e della perfezione. (...)
Il lettore si tranquillizzi. Non è mia intenzione ripercorrere, qui, la storia antica di una regione attraversata da molteplici correnti culturali e abitata da popolazioni diverse. Mentre scrivo è ancora in corso un conflitto terribile. L’ennesimo. La lotta per il controllo di Gerusalemme perdura ancora oggi. Lungi da me prendere posizione, se non per la giustizia e la pace.
La studiosa o lo studioso di storia, tuttavia, non possono evitare di chiedersi il perché. Dalla conquista davidica, 3.000 anni fa, non è passato secolo – in qualche caso, decennio – senza che si sia combattuto all’ombra delle sue mura: dall’assedio di Hazael, re di Damasco, attorno all’800, a quello di Sennacherib (Sîn-ahhe-erība), re di Assiria, nel 701; da quelli di Nabucodonosor (Nabû-kudurri-usur), re di Babilonia, tra il 598 e il 582 (compreso il più celebre, del 586), a quello di Tolomeo I, del 312; seguiti da quelli di Antioco III, del 201, di Antioco IV Epifane, del 169, di Giuda Maccabeo, tra il 164 e il 162, di Antioco VII, del 135, di Aristobulo II, del 67, di Ircano II, del 65, di Pompeo, del 63, dei Parti, del 40, di Erode, del 37.
Per non parlare, a partire dall’era volgare – o, se si vuole, dalla nascita di Gesù –, di quelli di Tito, di Adriano, dei Persiani, di Eraclio, degli Arabi, dei Fatimidi, dei Selgiuchidi, di nuovo dei Fatimidi, dei crociati, di Saladino, di Federico II, dei Kwarezmiani, dei mamelucchi, degli ottomani, degli inglesi, sino agli scontri israelo-palestinesi.
Insomma: siamo di fronte a uno dei luoghi più contesi della storia. I dati forniti da Cline sono impressionanti: la città è stata completamente distrutta almeno due volte, assediata ventitré volte, attaccata altre cinquantadue volte, e conquistata e riconquistata quarantaquattro volte.
È stata teatro di venti rivolte e innumerevoli tafferugli, ha conosciuto solo nel secolo scorso almeno cinque periodi distinti segnati da violenti attacchi terroristici, ed è passata di mano in modo del tutto pacifico appena due volte nell’arco di quattromila anni.
La denominazione di “città della pace”, che spesso le viene attribuita, risulta fuorviante – conclude lo studioso –, giacché «la sua esistenza è stata tutto fuorché pacifica».
Situata sul margine orientale dell’altopiano della Giudea, a 750-800 metri di altitudine, al limitare di un deserto roccioso, priva di acque abbondanti, benché non distante da terreni fertili, adatti all’agricoltura e alla pastorizia, Gerusalemme s’innalza solitaria su due crinali che corrono da nord a sud, attraversati da una valletta e circondati da depressioni profonde.
Nell’arco di 3.000 anni – è quanto hanno dimostrato le indagini archeologiche –, il paesaggio non è cambiato molto.
Si può dire che neanche le dimensioni del suo nucleo storico siano mutate nel tempo. La sua collocazione, invece, sì: dall’altura sud-orientale, la cosiddetta città di David, progressivamente esclusa dal circuito murario, all’attuale collocazione della Città Vecchia, cresciuta in direzione nord-ovest. (...)
La presenza di una sorgente d’acqua, quella di Gihon, e la protezione garantita dall’esistenza di gole e depressioni tutt’attorno furono, forse, le principali ragioni della scelta del sito da parte dei Cananei, i suoi primi abitanti.
Privo di consistenti risorse naturali, esso si trovava, tuttavia, a distanza notevole dalle rotte commerciali che dall’Egitto, attraverso la Siria, conducevano in Anatolia. La lontananza dal mare, inoltre, non deponeva a suo favore, visto l’incremento progressivo delle comunicazioni marittime.
Quale interesse, dunque, per Gerusalemme? Per quale motivo, nel corso dei millenni, decine di eserciti hanno cercato di conquistarla?
Non è la collocazione geografica il motivo di tanti appetiti. Non siamo di fronte a un sito adattabile a centro di scambi; tantomeno, a una base strategica dal punto di vista militare.
È possibile che la ragione di tale permanenza al cuore di tensioni continue vada ricondotta esclusivamente al legame con i tre monoteismi abramitici? In realtà, questi conflitti hanno inizio ben prima.
Insomma, che cosa ha di speciale Gerusalemme? A mio avviso, la risposta va cercata nel molteplice significato assunto dalla città nel corso dei secoli, capace di coinvolgere la dimensione identitaria, prima ancora di quella politica ed economica.
La sua stessa vicenda onomastica lo testimonia: Urušalim, Yĕrushalayim, Aelia, Ierosólyma, Ilya, Bayt al-Maqdis, Bayt al-Muqaddas, Urušalim, al-Quds, Ierusalem, Hierosolyma, e così via.
Secondo Cline, all’origine non vi sarebbe che una roccia affiorante sul Monte del Tempio, la quale avrebbe assunto «un ruolo cruciale nella storia delle lotte per il controllo di Gerusalemme. Essa ha visto sorgere e tramontare regni, nascere e crollare imperi. Un tempo si trovava entro le mura del Tempio di re Salomone e più tardi in quello di Erode. Ancora oggi questa enorme pietra ha una presenza imponente sul Monte del Tempio. Riposa, infatti, sotto il tetto dorato della Cupola della Roccia e costituisce un elemento vitale del terzo sito più sacro del mondo islamico». (...)
A ispirare la maggior parte delle battaglie condotte nel corso dei secoli attorno a Gerusalemme, insomma, non sarebbe stato altro che il desiderio di appropriarsi della Roccia posta sulla Sacra Spianata: «Where Heaven and Earth Meet», per citare un libro giustamente famoso e, al contempo, un’interessante proposta di risoluzione di un problema tutt’oggi vivo quale quello del suo controllo.
In realtà, v’è almeno un caso in cui tale tensione sembra essere venuta meno. Ed è di questo caso che tratteremo nelle pagine seguenti. Mi riferisco alla conquista crociata del 15 luglio 1099, al centro della quale era, piuttosto, il luogo che per l’universo cristiano costituiva da circa un millennio il principale polo sacrale cittadino: il Santo Sepolcro. (...)
Certo, la conquista del 1099 non è che un episodio tra i tanti, segno dei molti interessi cumulatisi sulla città nel corso del tempo. Il continuo alimentarsi di appetiti rapaci intorno al suo controllo non fa che confermare, con tragica puntualità, ciò che scriveva Montale: «La storia non è magistra / di niente che ci riguardi. Accorgersene non serve / a farla più vera e più giusta».
La speranza – se di speranza si può parlare – è che la conoscenza di fatti e lacerti di fatti inerenti a eventi tanto antichi funga da antidoto rispetto a chi, oggi, tenti di fare della sua storia un uso politico.



