Nella Chiesa e nella catechesi non manca la conoscenza della Bibbia, manca un grembo materno che faccia sì che il linguaggio biblico sia la lingua madre. Su di un importante articolo di PierAngelo Sequeri, di Andrea Lonardo
Riprendiamo sul nostro sito un articolo di Andrea Lonardo. I neretti sono nostri ed hanno l’unico scopo di facilitare la lettura on-line. Restiamo a disposizione per l’immediata rimozione se la presenza sul nostro sito non fosse gradita a qualcuno degli aventi diritto. Per ulteriori testi, cfr. le sezioni Sacra Scrittura e La Parola di Dio nella catechesi.
Il Centro culturale Gli scritti (12/10/2025)
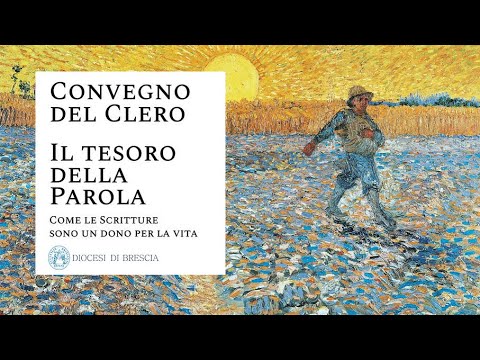
1/ Ci sono stati tanti corsi biblici negli anni, ma la Scrittura non è oggi la lingua madre della fede, questo è il problema
Perché la Parola di Dio non è conosciuta dopo tanti anni di valorizzazione della Bibbia nella catechesi ecclesiale? Perché non è la lingua “materna” della trasmissione della fede nella Chiesa oggi? Quali sono i nodi teologici irrisolti che ne hanno ostacolato di fatto l’appropriazione da parte delle nuove generazioni? Che cosa si dovrebbe fare oggi?
Sequeri ha proposto una riflessione magistrale sull’assenza della Scrittura oggi, assenza nella vita cristiana e nella trasmissione della fede. Ma non lo ha fatto alla maniera solita, inveendo contro l’ignoranza biblica.
Anzi è partito proprio dall’enfatizzazione della retorica ecclesiale su questo tema, dal fatto che, a partire dal post-Concilio, si sono tenuti tantissimi corsi biblici, dal fatto che la catechesi, grazie a tanti bravi preti e catechisti, ha posto sempre più attenzione alla Scrittura e l’ha inserita come costitutiva dell’Iniziazione cristiana.
No, la sua lettura è diversa da quella solita e abituale, quasi banale. Il problema è, invece, per lui che la Scrittura non è più la “lingua madre” della Chiesa e non lo è, in qualche modo, dall’invenzione della stampa.
Sequeri ha proposta tale riflessionein una relazione tenuta nel 2021 ad un Convegno del clero di Brescia[1] e poi riproposto su“La Rivista del Clero Italiano”[2].
Egli ha specificato come la nostra pratica della Bibbia faccia fatica a far diventare habitus, nonostante i molti corsi su di essa – “Tutti noi preti – ha affermato - abbiamo fatto corsi biblici, corsi di introduzione alla Bibbia ad una serie di gruppi e persone”.
Scherzando ha ricordato che all’inizio del suo ministero i due fuochi erano allora: “primo, la Bibbia nella parrocchia, e secondo, Vangelo e rivoluzione, Vangelo e violenza, Marxismo e cristianesimo”.
Ebbene, dopo tanto lavoro, “oggi i ragazzi non sanno se i vangeli sono quattro o no! Mia mamma, non molto praticante, lo sapeva. Ha raccontato che ad un esame di ammissione all’insegnamento, alla domanda quanti sono i vangeli, un prete si è sentito rispondere: “I vangeli sono tre”. L’esaminatore, per aiutare l’esaminando ha detto allora: “Tre, quelli sinottici?” La risposta è stata: “No, quelli cattolici!”
Così Sequeri ha iniziato ad approfondire la questione: “Ormai la catechesi dell’IC è molto ricca della Bibbia, ci sono arrivati da loro, a volte senza nemmeno l’aiuto delle diocesi. È normale la presenza della Bibbia nella catechesi. Ma, con tutto questo, la Bibbia come lingua materna è un’altra cosa”.
2/ L’importanza della “lingua materna” che presuppone un “grembo materno”
“La lingua materna” – ecco questo è il suo punto di vista, che appare correttissimo!
“La lingua materna – ha precisato - non è una lingua, è l’ingresso nel linguaggio umano – non ne uscirai mai più. È la lingua dell’orientamento. Poi certo ti arricchirai – proprio perché è la stessa lingua materna che ti raccomanda di imparare”.
“La lingua materna è così decisiva e vitale che è quella che respiri, è quella che ti mette al mondo. Per questo ha anche i suoi interdetti. Anche nei confronti dei suoi eccessi: per esempio, mia mamma ci proibiva il dialetto. Gli stessi interdetti che ti aprono a trascenderla. Ma quella lingua materna è persuasiva, proprio perché è la lingua materna. Certo essa non può funzionare senza un vocabolario, ma la lingua materna non è il vocabolario, la lingua materna non è la grammatica e la sintassi. Insomma la Bibbia come lingua materna non è l’ebraico, il greco, l’aramaico. Deve avere vocabolario, grammatica, sintassi, che passano attraverso le lingue antiche e le traduzioni. Ma è qualcosa di ben più elementare e decisivo: è l’attitudine a decifrare anche le altre lingue, la violenza, il pianto, la gioia”.
Insomma Sequeri ha sottolineato che il problema non è l’ignoranza biblica, anzi la si studia la Bibbia, ma appunto come un testo di studio, non come la lingua con cui si impara a vivere e a parlare e a capire il mondo e a stare al mondo.
“C’è voluto tanto tempo per perderla come lingua materna. Subito dopo il medioevo abbiamo iniziato a perderla. Nella scolastica tutto era molto “pettinato”, dove tutto doveva andare a posto: lì abbiamo iniziato a perdere la lingua materna”.
Respirare la Bibbia come lingua materna vuol dire avere ben chiaro che ci sono “anche gli improperi, le maledizioni, l’esultanza”.
Noi conosciamo una “lingua biblica molto filtrata, molto mediata dalla scolastica. Essa non era più spontanea. Era di rincalzo, non più materna”.
Poi “con la modernità, la Chiesa si è presa paura che l’uso individuale della Scrittura – l’invenzione della Scrittura ha reso possibile la nascita della Bibbia – allontanasse dalla fede e ha smesso di trasmetterla come lingua materna”.
Ma, si noti bene, non perché la lettura individuale fosse allora o sia oggi la soluzione. “È avvenuto come per la musica che veniva trasmessa fino all’anno 1000 senza spartiti e notazioni musicali. Certo, la Bibbia è nata nel grembo della nascita della scrittura letteraria, nasce con l’alfabeto, ma non nel senso che la si leggeva e che la lettura sia la soluzione a tutti i mali. Noi diciamo lectio divina, ma la Bibbia non la leggeva nessuno. Quando la lectio ha iniziato a coincidere con la lettura? Con il sorgere della stampa!”
Si è passati da un testo liturgico, mediatore della lingua biblica della fede, da un grembo materno, a qualcosa che “era a disposizione di chiunque individualmente”.
Ecco la grande questione posta da Sequeri: “La lingua materna ha bisogno di un grembo, non solo di parole”. Non si risolve l’insignificanza della Bibbia oggi con proposte di studio e di lettura, ma con il tornare - difficilissimo, sottolinea sempre, improbabile – a mostrare che essa parla come lingua materna solo se c’è il grembo vivo della Chiesa”.
E prosegue: “Oggi diciamo: leggere la Bibbia! È un grande vantaggio, ma anche un grande disastro. Perché tu la leggi senza un grembo materno. La Bibbia ha interdetti e indicazioni, che noi abbiamo cancellato. La Bibbia è un testo creativo e per diventare creativi, responsoriali, è per una fede che chiede che ci mettiamo del nostro. La Bibbia chiede che restituiamo la comprensione con parole nostre: tutto l’AT è intessuto di un ordinario e quotidiano colloquio con Dio fatto di secoli. Gli uomini parlano di tutto con Dio e la Bibbia non è come il catechismo, “pettinato”. La Scrittura è piena di paradossi”.
Tutto questo avviene solo in un grembo materno.
“Senza grembo la Bibbia non la puoi leggere: diviene una lingua aliena. Il cristianesimo non la parla più: tanti poi si mettono a studiarla come lingua estranea. La lingua materna è una faccenda seria: questo è il senso di quell’interdetto di leggerla, anche colpevole, quando la vietammo”. Cioè aveva senso impedire di leggerla da soli, quasi fosse un testo su cui esercitarsi, ma certo non era più la “lingua materna”[3].
“Noi siamo oggi in questa situazione: come lingua materna non ce l’abbiamo più e il grembo della comunità non è attrezzato per questo lavoro”.
Ciò che non funziona è che “noi ritualizziamo questo rapporto, ma fondamentalmente noi la Bibbia la insegniamo. La insegniamo come una lingua aliena, non è la nostra lingua materna”.
Sequeri insiste su questo: “La Scrittura non è un testo esoterico, ha bisogno di un grembo. Il problema è che la nostra gente non lo ascolta con orecchio vergine, come si fa con la voce della mamma!”
L’operazione improbabile del tornare ad avere un grembo materno che trasmetta la fede nella lingua madre delle Scritture conduce Sequeri ad alcune considerazioni che sono ancora teologiche, ma aprono la via anche a possibili conseguenze pastorali.
3/ Riconciliarsi con il carattere non sistematico, enigmatico, ironico della lingua materna
Innanzitutto egli ritiene che si debba evitare che il catechismo occupi il posto della lingua madre. La difficoltà, già evidenziata è che si sia insegnato a leggere la Bibbia, a meditare la Bibbia, ma questo non ha mai significato la felicità del trovarsi a casa, come quando si rievocano i ricordi in una casa.
Ebbene riscoprire la Bibbia come lingua madre significa riconciliarsi con il carattere non sistematico, enigmatico, ironico della lingua materna.
Bisognerebbe ad esempio, “accettare spiritosamente la provocazione di Qoelet, accettare la pretesa di tanti libri biblici che invitano a pensare a donne che salvano tutti, mentre i codardi non se la sentono. Bisognerebbe ancora non dimenticare che nella Bibbia c’è un poemetto sul libero amore. Nella lingua materna tante cose si raccontano con affetto e con ironia. I due appassionati amanti del Cantico sono due matti, sono come i ragazzi. Se si parlasse la Bibbia come lingua madre, ecco che si assorbirebbero le imprecazioni di Giobbe – se la studi diventa la teodicea e la Bibbia come lingua materna è andata. Si potrebbero interiorizzare i comandi senza alcuna motivazione o spiegazione: lo fai perché te lo dico io - anche questa è la lingua materna. Per chi parla la Bibbia come lingua madre è assurdo sentir dire che siamo la religione delle beatitudini e non dei comandamenti! Ma da dove vi è venuto questo! È una serie di scemenze: se la lingua biblica fosse la lingua materna non vi sarebbe nemmeno venuto in mente. Nella Bibbia ci sono paradossi, ci sono incongruenze. Le scritture sono un universo nel quale apprendere i passaggi contraddittori, come si apprende l’Edipo, la frustrazione, l’accudimento, ma anche l’ingiunzione senza nessuna spiegazione”.
E aggiunge:
“Prima lo si impara e meglio è! La “pettinatura” del catechismo verrebbe sanamente relativizzata dalla lingua madre, questo iper-protocollo democristiano, totalmente privo di ironia.
Dinanzi a Gen 3, che è sì il racconto dell’abisso, ma che, nella lingua materna, mantiene anche l’ironia verso la pulce, l’uomo. Dio lo prende in giro: “Ora sono diventati come me!”. Allo stesso modo come l’affermare che la “mia vittoria sul serpente” passa attraverso la donna!”.”.
Senza la lingua materna tutte le pagine bibliche diventano difficili! In questa prospettiva, invece, queste pagine misteriose generano affezione e aperture.
4/ È necessario che la Bibbia sia respirata sempre in relazione a Cristo, Parola totale
In secondo luogo, perché le Scritture parlino come lingua materna, appare necessario per Sequeri proporre con forza un nuovo cristocentrismo nel rapporto con le Scritture (nel testo egli si riferisce a tale prospettiva anche con il termine “riduzione cristologica”).
Sequeri intende sottolineare così l’unità dei due testamenti in Cristo.
Egli lascia intendere come sia i procedimenti esegetici, sia anche la lectio divina, abbiano spesso contribuito di fatto a separare la Scrittura dalla sua chiave di volta che è la persona di Cristo.
Sequeri sottolinea più volte quanto sia problematica l’identificazione della Parola di Dio con la Scrittura. La Parola di Dio non si risolve, infatti, nella Scrittura, anche se non è pensabile senza di essa.
Solo un approccio canonico alle Scritture obbliga a leggere continuamente i passi dell’AT in relazione a quelli del NT e tutti in relazione alla persona viva di Cristo, che eccede la Scrittura stessa.
Sottolineando che il “principio di compatibilità è più ampio ancora del principio di sintesi. È il principio di compatibilità fenomenologica. Ogni interpretazione che non è compatibile con Cristo non è Parola di Dio. Si tratta di avere un accesso alla chiave delle Scritture. E questo principio di compatibilità è anche fenomenologico. Il genere “vangelo” nasce quando c’erano già gli inni cristologici trinitari, segno che c’è una fenomenologia che non si può superare. Di per sé il dogma e la gnosi sono ad un capello di distanza, se non ci fosse la memoria Jesu. Ciò che nella fede non è in grado di comprendere l’evento di Gesù, che parla alla samaritana, trova il lebbroso, ecc. è dubbio! Una parola che non è in grado di farsi ospitare nell’evento di Gesù è dubbia! Si tratta – specifica - non di rimpicciolire, ma di concentrare, di cogliere il punto chiave di accesso a quell’esperienza. Che cosa ci consente di entrare in quell’esperienza? La fede nell’avvento del regno di Dio. Noi abbiamo perso nell’esperienza dell’incontro con la fede: la fede cristiana è fede nell’avvento del regno di Dio. Dio e l’uomo abitano felici insieme e questo è vero già adesso. Ecco che la parola su regno di Dio è la parola di Dio sulla creazione! Non è una parola riservata ad intra, ma è la presenza del regno che riguarda la creazione tutta intera”.
E questa parola è molto misteriosa. Afferma ancora Sequeri:
“La chiave di accesso a tutto questo è la parabola. La parabola – insieme ai miracoli - è il genere base della lingua materna che Gesù utilizza per introdurre a tutta la Scrittura. Le istruzioni di Gesù riguardano la condizione umana. Ma riguardano anche il mediatore: chi sequestra il regno di Dio va all’inferno prima. Gesù parla sempre con qualche eccesso per far capire l’ironia. La parabola è ironica: se ce non la metti l’ironia, come si fa a capire? Se non vedi che gli sconvolge la religione? Gesù dice: Io sono uno che raccoglie anche dove non ha seminato. Invece alle persone sembra andare bene la versione standard. Ma Gesù non è standard. Serve che raccontiamo parabole e che ci mettiamo un enigma: il lato eccitante della vita. Sia il debordare della misericordia, sia che si realizza la giustizia facendo misericordia enorme e gettando nell’inferno: c’è una giustizia nel risentimento che ci colpisce, quando c’è una violenza. La Bibbia non sa niente del politicamente corretto! C’è una parte umana che la Bibbia restituisce senza reticenze. C’è la verità umana del sacrificio della vita per la salvezza della comunità. L’ironia è che qualcosa va superata, ma prima le va dato spazio, per non assuefarsi al delitto: Caino è schifoso, ma voi non toccatelo (però è schifoso). È una Scrittura che non espunge nulla! Non è alla vostra portata la differenza fra il bene e il male (questo è Genesi 3, anche questo). Ripeto sempre che la prova certa dell’ispirazione è che non venga mai sottaciuta l’ottusità degli apostoli. Di modo che la Chiesa è l’unica istituzione mondiale che riconosce i propri errori. È così che la Bibbia come lingua materna ci concilia con la serietà della nostra limitatezza. Se ci si pensa con attenzione, il canone è anch’esso ispirato e si vede che la storia biblica si ripete: la storia della Chiesa è simile alla storia dell’AT: anche nella Chiesa abbiamo vissuto nel IV secolo la richiesta del regno, poi nel XV la divisione in due regni, poi il rincretinimento, poi anche noi abbiamo i profeti che ci siamo persi, poi sappiamo che questo è forse il momento della sapienza, e così via. Oggi siamo al momento di un annuncio del regno di Dio ad una società istituzionalmente non religiosa: questa situazione non c’era mai stato. Ma la Bibbia ci insegna ad essere creativi: dobbiamo essere creativi, non c’è nella Bibbia, questo compito – dice Dio a noi oggi – è un compito che non ho mai dato a nessuno”.
ANTOLOGIA DI PASSI DI PIERANGELO SEQUERI (da PierAngelo Sequeri, Interlocutori creativi della Parola. La riabilitazione delle Scritture sacre come lingua materna, in “La Rivista del Clero Italiano” CIII (2022), pp. 9-20)
A/ LA LINGUA BIBLICA COME LINGUA MATERNA
Nonostante il generoso impegno profuso nell'ultimo mezzo secolo nel ricupero delle sacre scritture all'interno della catechesi - quella dell'infanzia e quella dell'età adulta - la lingua biblica non è ridiventata la lingua materna dei credenti. La lingua materna è quella nella quale impari a pensare e a esprimerti spontaneamente: è quella mediante la quale entri nel linguaggio umano, che è universale, per non uscirne più.
La lingua materna la apprendiamo anche se non sappiamo leggere e scrivere. Essa ha certamente un vocabolario, una grammatica, una sintassi: una vocalità e, per lo più, una scrittura. Possiede anche un canone e un repertorio, del quale fanno parte le ninne-nanne e le canzoni preferite, le narrazioni genealogiche della famiglia, la memoria di eventi fondatori delle biografie, le storie di conflitti, perdite, eventi felici, gli stereotipi sapienziali e le massime proverbiali, le storie dei vicini, gli eventi della città, le immagini delle popolazioni aliene e le istruzioni sugli eventi della natura.
La continua ripresa della lingua materna fa crescere la nostra competenza del linguaggio umano, che è in grado uscire dal repertorio, di sostenere la traduzione in altri linguaggi, di ampliare la conoscenza e le affezioni che orientano il nostro transito nella realtà vissuta attraverso il linguaggio umano: sempre presente e sempre irriducibile alla lingua materna. Del canone e del repertorio della lingua materna fanno parte anche - in forma più o meno esplicita, in misura più o meno ampia - istruzioni relative ai suoi limiti inevitabili e al suo necessario superamento. Dall'interdizione del dialetto locale, in vista del corretto apprendimento della lingua nazionale, all'ingiunzione dell'apprendimento scolastico di contenuti ignoti alla storia famigliare; dalle regole della buona educazione e dell'ospitalità nei confronti dell'estraneo all'intimità della propria convivenza, all'iniziazione dell'ascolto e dell'esplorazione di alterità irriducibili al rispecchiamento della propria identità.
L'immanenza costitutiva della lingua materna è il tratto permanente della nostra immanenza al linguaggio umano. La ripresa critica di questa immanenza, che realizza e rende esplicita la nostra appropriazione del linguaggio umano, è condizione necessaria e finalità ultima della sua insostituibile mediazione. L’analogia alla quale penso è dunque quella che sussiste fra la lingua biblica che attesta la rivelazione e la Parola di Dio di cui vive la fede.
B/ IL LEGAME DELLA PAROLA DI DIO, CHE NON È LA SCRITTURA, CON LA LINGUA BIBLICA
Naturalmente, il fatto che sussista questo legame intrinseco fra la lingua biblica e la Parola di Dio è esso stesso un contenuto della nostra fede. E propriamente, questo contenuto si precisa nella convinzione che questo legame - che per noi è legame della parola di Dio con il testo biblico - sia indissolubile, inaggirabile, indispensabile. Ora e sempre.
La Parola di Dio non si risolve nel testo biblico: ma senza il testo biblico si dissolve. Questa convinzione è già interna alla storia delle Scritture sacre: è la ragione stessa che attrae la memoria e l'immaginazione teologale della rivelazione di Dio, che precedono anche linguisticamente la tradizione della Parola di Dio, nell'orbita dell'invenzione della scrittura testimoniale.
Questa stessa convinzione orienta il riconoscimento canonico delle scritture ispirate, come referente normativo di ultima istanza per l'autenticità dell'accesso alla rivelazione che definisce la fede. E ha posto le basi dell'interpretazione dell'atto stesso della scrittura memoriale secondo il modello profetico e sapienziale: questa interpretazione è stata raccolta nella teologia dell'ispirazione e del canone, della verità e dell'ermeneutica delle sacre scritture.
L'interesse dell'analogia fra la parola biblica e la lingua materna, a mio parere, offre già di per sé stessa, in termini generali, un'utile mediazione per il disinnesco di ogni opposizione pregiudiziale fra la lettera testimoniale e il senso rivelativo delle sacre scritture; come anche, simmetricamente, per la sottrazione dell'ermeneutica credente al feticismo del testo biblico. La Parola di Dio parla qui in ebraico, aramaico, greco: ma non è ebraica, aramaica o greca.
C/ IL RAPPORTO FRA BIBBIA, LITURGIA E GREMBO MATERNO
La lingua biblica, come lingua materna, si avvale per altro di un principio di sussidiarietà, emblematicamente evidenziato dalla lectio liturgica, che non coincide affatto con l'atto materiale di lettura.
Il fraintendimento è favorito dalla inconsapevole abitudine a concepire la lettura separata dall'ascolto, dovuta all'invenzione della stampa e non della scrittura: le antiche generazioni di credenti, per secoli senza alcuna dimestichezza con la lettura materiale, possedevano la lingua biblica come lingua materna in termini incomparabilmente più pregnanti delle nostre. La lettura individuale e privata, a diretto contatto coi testi, senza grembo affettivo e linguistico della tradizione e della comunità è anche irrimediabilmente esposta a uno stato confusivo e arbitrario: è la verità della reticenza moderna della pastorale ecclesiastica, per altri versi imperdonabile.
Non tanto per la mancanza di controllo dogmatico e disciplinare: ma soprattutto per il difetto di rapporto con il grembo testimoniale e con l'orientamento affettivo della comunità di fede. L'interesse pastorale di questo approccio mi pare intuitivo. E d'altra parte, suggerisce già in partenza che non si tratta semplicemente di trovare espedienti didattici e metodi ermeneutici per tradurre la scrittura biblica nella Parola di Dio: come se si trattasse di una scrittura che, semplicemente, la trascrive.
Dunque, si tratta di ricuperare il grembo materno dell'iniziazione linguistica alla Parola di Dio attestata nel canone ispirato delle Scritture sacre. Questa iniziazione non può essere risolta nell'approccio analitico dei testi e nell'intelligenza lineare dei significati. Le stesse Scritture sacre, del resto, resistono felicemente a questo approccio, quando non sia preceduto e contenuto dalla consuetudine nell'abitare nella intrigante con-fusione dei generi e delle contraddizioni dei singoli scritti, che non sono nati per comporre un singolo testo: anche se non è privo di significato il fatto che la loro collazione sia donata alla comunità e alle generazioni come un unico corpo.
Biblia, infatti, è 'biblioteca: ma alla fine anche libro. Per venire a capo di questo ricupero, in termini non estrinseci o arbitrari, è necessario individuare un modello di accesso ispirato, a sua volta, dalle sacre scritture medesime. Una lingua materna, intesa come habitat vitale e non semplicemente come instrumentum intellettuale, fa proprio questo.
D/ IL CRISTOCENTRISMO E LA BIBBIA
Il ricupero di cui parlo - per essere franchi - ha consistenti indici di improbabilità: e la positiva esuberanza del lavoro dell’esegesi scritturistica e della teologia esistenziale nei confronti della lectio divina non sono soltanto un sussidio prezioso, ma anche un filtro problematico. Lo spazio nel quale devo illustrare la mia prospettiva, piena di insidie, è molto limitato. Devo pertanto dichiarare il carattere sintetico e allusivo di questo approccio.
Tuttavia, i suoi elementi fondamentali non mancano di appoggi significativi già disponibili, nell'ambito della teoria esegetica e teologica.
Il primo passo poggia su un dato che, di fatto, è saldamente acquisito alla teologia biblica e dogmatica: il cristocentrismo, come chiave di lettura dell'unità dei due Testamenti e come principio di sintesi della verità della Rivelazione, pur diversamente argomentato nei suoi fondamenti e nelle sue articolazioni, è un criterio unificante sostanzialmente condiviso del sapere della fede.
Per mio conto, ho enfatizzato la traduzione di questo criterio in termini di compatibilità cristologica, che esige - storicamente e dogmaticamente - il riferimento normativo alla fenomenologia evangelica di Gesù. È già un modo di indicare il testo biblico, in primis la scrittura evangelica, come termine insuperabile di omologazione del significato teologico: ossia, della rivelazione di Dio e della retta fede, in qualsiasi contenuto. In pratica, ciò significa che il senso teologico deve passare obbligatoriamente al vaglio e alla verifica della parola e dell'azione del Signore attestate apostolicamente. Il significato teologico che non è in grado di sopportare questa ‘prova’ è sostanzialmente ‘incerto’ nel suo riferimento alla Parola di Dio.
Ora, la riduzione fenomenologica dell'evento fondatore (possiamo indicare così l'evento della manifestazione di Dio nel quale si riconosce la fede suscitata da Gesù) appare definito dalle parole e dalle azioni che Gesù riconduce all'evidenza simbolica del «regno di Dio», nel contesto definito dalle sue relazioni con i discepoli (che non hanno alcun titolo speciale di elezione se non la chiamata e l'accoglienza di Gesù), la folla (alla quale non è imposta alcuna discriminante di competenza e di appartenenza religiosa-sociale), l'‘antagonista’ (che appare come difensore e custode della religiosità osservante). Queste parole e queste azioni sono emblematicamente riassunte (e in certo modo sovrapposte) a quelli che noi chiamiamo parabole e miracoli.
Il «regno di Dio», che si manifesta in Gesù e con Gesù, ma accade direttamente nella vita quotidiana e mondana della creatura, è la verità di Dio e il tema della fede. (E già a questo punto appare chiaro che coloro che sono stati iniziati alla lingua materna della scrittura evangelica non parlerebbero così disinvoltamente di ‘costruire’ il regno di Dio come tema della fede e progetto della missione).
Il «regno di Dio», annunciato e attivato nel quadro della manifestazione di Gesù, presenta una singolare aderenza con la lingua materna nel contesto come lingua materna delle scritture bibliche dell'Antico Testamento.
E/ L’ORIZZONTE AMPIO E NON RISTRETTO DEL LINGUAGGIO BIBLICO
Il tema della creazione come principio dell'alleanza con la creatura, che iscrive la parola e l'azione di Dio nel solco del suo riscatto e del suo compimento, è il tema centrale e unificante di tutta l'estetica e di tutta la drammatica di quella che chiamiamo, semplificando molto, storia della salvezza.
Questa storia diviene accessibile nella storia della costituzione etnica e della elezione testimoniale del popolo ebraico. Ma non è semplicemente la storia del popolo ebraico: è la storia dell'uomo e della donna, che nella vicenda del popolo di Dio istruisce tutti i popoli sui modi e sui tempi del passaggio di Dio attraverso la condizione umana.
I momenti qualificanti di questo processo, che include l'esemplare attestazione dei passaggi obbligati e delle contraddizioni inevitabili della testimonianza, sono sigillati nel ‘canone’ ebraico della storia testimoniale della fede che viene costantemente suscitata e risuscitata da Dio. La rivelazione di Dio nella creazione, scaturita dalla ripresa della drammatica contraddizione fra lo splendore dell’insediamento storico-mondano del popolo della testimonianza e la devastante esperienza della fine dei 'regni' e dell'esilio babilonese, si ricongiunge con la fede ebraica nella conclusiva esperienza sapienziale della rivelazione di Dio, che riprende nella sua totalità e universalità il tema del fondamento e della destinazione creaturale dell'alleanza.
Il passaggio intermedio è marcato dalla straordinaria pressione esercitata dall'enigmatico protagonismo profetico della testimonianza della parola di Dio: dove all'appello alla genuina ispirazione religiosa dell'alleanza, che deve qualificare la fede, è collegata la critica serrata dell'automatismo dell'istituzione religiosa, che da sé stessa non è assolutamente in grado di assicurarla.
La predicazione del regno in parabole fronteggia e riassume l'intera logica di questo archetipo della recezione religiosa e umana della rivelazione / relazione con Dio: archetipo e modello istruttivo, perché destinato a ripetersi. E a essere sempre nuovamente decifrato e ripreso: perché non dice linearmente e letteralmente la rivelazione, bensì dialetticamente e criticamente.
La predicazione in parabole, anzitutto, restituisce il regno di Dio (l'azione e la destinazione dell'atto creatore) alla sua ‘potenza’ e al suo ‘enigma’. Non è un prodotto della religione, non è una figura dell'istituzione. La sua custodia storica è la grazia di una responsabilità testimoniale: il suo sequestro religioso e la sua sostituzione mondana espongono gravemente al giudizio di Dio.
Le parabole dunque vanno restituite al loro enigma salutare (insieme con i miracoli). Non sono semplicemente versioni naturali di misteriosi significati soprannaturali. La loro decifrazione deve essere voluta: la decisione ottiene l'effetto che vuole essere cercato. L'esito può essere semplicemente innocuo, oppure incomprensibile, oppure minaccioso. Oppure, rinviare alla emozione indicibile del «regno di Dio» che riscatta ogni perdutezza, presuntivamente definitiva.
Il giudizio è riservato ai mediatori religiosi che si sono sostituiti alla rivelazione: padroni della fede altrui, invece che servitori. Ma anche agli ingrati che ne ripetono il gesto, strangolando il fratello per pochi soldi, dopo aver ricevuto il condono di molti. Disprezzando la veste bella del pranzo di ringraziamento, dopo essere stati invitati al posto d'onore.
La religione possiede in sé una irresistibile inclinazione mondana, che va ogni volta stanata e contrastata: senza l'esplicitazione di questa dialettica, la religione perfetta finisce per coprire un'incredulità irriconoscibile. Lo spirito della profezia e quello dell'ironia sono il sale di questa costante presa di distanza dagli automatismi della religione. (Tra il sacerdote, il levita e il samaritano, chi è il prossimo? Volete andarvene anche voi?)
Nelle parabole, infine, come nei miracoli, la rivelazione di Dio, che chiede ormai di essere adorato «in spirito e verità», aderisce strettamente all'immanenza della vita quotidiana: il regno di Dio non si annuncia nell'innovazione dottrinale di speciali pratiche religiose, né si lascia attrarre dall'epica di avvenimenti mondani particolarmente trionfali o particolarmente sconvolgenti. Non è così l'avvento e l'evento del Figlio dell'Uomo, non è così la crocifissione e la risurrezione di Gesù di Nazaret.
L'apertura sapienziale della religione alla creazione, in dialettica con la critica profetica della mondanità religiosa, pone un sigillo sul compimento della rivelazione del Figlio fatto uomo, una volta e per sempre.
F/ L’AUTOCRITICA È INTRINSECA AL LINGUAGGIO BIBLICO
Il fondamentalismo religioso non ama l'ironia evangelica, che ribadisce la trascendenza di Dio solo post-eventum, applicando alle parole e ai gesti, alla lettera e alla storia, alla regola e alla libertà della testimonianza, l'automatismo salvifico della lettera. Non esiste rivelazione di Dio in presa diretta, ma solo nella ripresa critica: il passaggio all'atto di scrittura sancisce proprio l'insuperabilità teorica della ripresa teologale.
La parola di Dio si dà sempre in parole nostre e poi nell’autocritica delle parole nostre: niente analogia, senza dialettica.
Le scritture bibliche attestano in ogni pagina questo dispositivo, in una duplice forma, insuperabilmente emozionante.
La prima la possiamo riconoscere nella pacata e quasi implacabile oggettivazione della confessione della inadeguatezza del testimone: che, lungi dall'essere espunta dall'integrità canonica del testo ispirato (e quindi riconosciuto come rivelatore e normativo), entra a far parte dell'attestazione della parola di Dio.
Non è solo la confessione dei peccati che allontanano e corrompono la fede: è l'attestazione della differenza costitutiva che va incorporata nella fede come parte integrante della testimonianza. La Parola di Dio trascende anche le parole migliori che l'annunciano: se questo annuncio è rimosso, anche la rivelazione finirà per evaporare. Insomma, la regola d'oro della testimonianza ha due stichi: «Gesù è il Signore. E non sono io».
Il secondo è essenziale al primo. Se non viene ribadito ogni volta che viene enunciato il primo, la sua rivelazione si perderà. Ovvero, anche inconsapevolmente, la sua mediazione diventerà sostituzione: la mia parola prevarrà e la testimonianza sarà auto-referenziale.
Su questo fronte, la predicazione e la teologia non mostrano la dimestichezza necessaria con la lingua materna della rivelazione. Il catechismo - anche il migliore - è diventato privo dell'ironia biblica.
Una teoria coerente dell'ironia rivelatrice della Parola di Dio deve sottrarla all'ossessione dogmatica e morale del fondamentalismo religioso, che rimuove l'atto rivelatore della ripresa critica e assorbe ingenuamente una visione lineare della Parola che satura allo stesso modo tutto il Testo.
L’ingenuità della religione è inevitabile: in ogni epoca, in ogni cultura, in ogni cristianesimo. La Bibbia, appunto, offre una rivelazione radicale della sua origine (Genesi) e dispone di un referente normativo di questa insuperabile vulnerabilità. L'eredità del ‘sospetto’ di Adamo avvolge i protocolli universali del ‘sacro’: impossibile neutralizzarne l'effetto senza la ripresa del canone biblico. La pretesa di dominare la differenza del bene e del male, della vita e della morte. Che appare l'ambizione suprema della religione osservante, è contaminata dalla presunzione religiosa di Adamo, che - mentre ne diffida - approfitta della confidenza con Dio. L’ironia di Dio in Gen 3, che ridicolizza le nostre troppo devote liturgie del dramma del peccato, è semplicemente strepitosa.
Il sacro giustifica la consacrazione e il sacrificio. Impossibile sottrarsi all'ingiunzione: bisogna investire sull'assolutamente inviolabile e simmetricamente sulla necessità del sacrificabile, per proteggere la vita e la comunità. L'esperienza mostra che non siamo all'altezza di una giustizia incontrovertibile delle nostre scelte: neppure quelle religiose. La Bibbia registra implacabilmente la storia della nostra ambivalenza e registra il linguaggio umano della sua recezione. «Dio non lo vuole». «Dio lo vuole».
Non dovremmo essere più leali e meno ipocriti nel cercare di sottrarci a questa ambivalenza? Nella contraddizione esiste sempre anche una verità che finisce per essere dimenticata. Il nostro - giusto - ripudio della guerra attinge certamente alla lezione dell'esperienza e alla provocazione della parola evangelica di Gesù, che chiude con l'alleanza della religione e della spada. Ma non abbiamo detto noi stessi, per secoli «Dio lo vuole», quando cercavamo di motivare l'onore della difesa della patria e la nobiltà della vita messa in gioco per questo?
Nelle nostre società continua a essere rispettata la legittimazione di una forza pubblica di interdizione del crimine: che prevede anche l'uccisione dell'aggressore omicida che non può essere fermato in altro modo. Nelle società del benessere, l'ottimizzazione della cura di sé ha raggiunto un tale grado di ingiunzione, da rendere quasi impensabile l'esercizio della forza per la tutela della vita e il sacrificio rischioso per il bene della comunità.
Possiamo comprenderlo come un puro e semplice progresso? Nelle società del diritto e dei diritti - lo ammettono tutti, ormai - la tutela e il sostegno dell'ingiusto aggressore è di gran lunga superiore al riconoscimento e alla cura della vittima innocente. Il Dio che punisce i malvagi, soprattutto nella forma dell'ingiustificabile avvilimento dell'uomo sull'uomo, perde ogni senso. Ne viene automaticamente un incremento della reciprocità fraterna?
La Bibbia registra l'uso della nostra lingua materna e l'inevitabile approdo della nostra religione: entrambe umane, così umane. Troppo umane, certo. Ma anche abitate da verità elementari: che non è giusto dissolvere insieme con la scoperta di una giustizia e di una misericordia di Dio che aprono strade impensate e impensabili per le ordinarie affezioni del sacro.
Le parabole trattengono questa misteriosa verità. La sofferenza dell'Epulone 'risarcisce' l'avvilimento di Lazzaro. Il tono di Abramo è pacato, paterno. La parola del comandamento - «Non ucciderai», «Non deprederai» - è un interdetto insuperabile e un ammonimento sufficiente. Il grado zero dell'ingiustizia è sempre evitabile. E nondimeno non lo è.
Nella lingua materna della Bibbia ci sono re santificati che peccano ignobilmente, donne improbabili che salvano il popolo al posto di soldati codardi, vecchi saggi smaliziati per i quali tutto è vanità e giovani spensierati per i quali tutto è eros, samaritani perfettamente in grado di realizzare la legge della prossimità di Dio e custodi della legge che la contrattano con i loro sacrosanti privilegi.
La parola di Dio si iscrive nell'attestazione di questi paradossi, impedendoci per sempre di rimuoverli e imponendoci di abitarli: proprio in sé stessa, questa rivelazione, è parte della lingua materna che ci salva dall'ipocrisia religiosa. Enigmatica, certo: non fa sistema con alcuna possibile ideologia dell'ordine mondano o celeste.
G/ L’OCCASIONE (KAIROS) CHE OFFRE QUESTO TEMPO, COME NESSUN ALTRO, E CHE È DA COGLIERE
Il regno di Dio è misterioso e inafferrabile: chiede un atto di destrezza e di forza, non senza rischio. Ma fino a che non cesseremo di meditarla - anche senza comprenderla, come le parabole - attraverso la sua insonne ripresa nelle condizioni date e nel kairos assegnato, c'è speranza di approdare alla parola illuminatrice e misteriosa di Dio che ci salva dalla simulazione e dalla disperazione.
Per quanto riguarda l'intelligenza del kairos, l'archetipo del canone ebraico rimane indispensabile e illuminante, per tutta la storia del cristianesimo. Gesù l'ha inteso - esplicitamente e implicitamente - in questo modo. Indipendentemente dalle citazioni occasionali, la sostanza è nella duplice dichiarazione di indissolubilità dell'inedito evangelico della Parola divina con l'attestazione originaria della sua storia rivelatrice. «Sono venuto per compiere, non per abolire: e neppure uno iota cadrà». «Amerai Dio con tutte le tue forze e il prossimo come te stesso: questa è tutta la legge e i profeti».
Una nuova dimestichezza con la lingua materna delle Scritture sacre renderebbe più facilmente abitabile la condizione storica assegnata alla testimonianza e alla missione della fede.
Diciamolo in breve. Il cristianesimo ha vissuto l'epica dei suoi Padri fondatori (Apostoli e Martiri). Ha vissuto l'epoca dell'insediamento nella forma istituzionale della nazione e dei regni. Ha conosciuto l'esperienza - fatale e inevitabile - della mondanizzazione politica e della divisione religiosa. Ora vive sulla soglia della dispersione e dell'esilio nelle società liquide delle nazioni che essa stessa ha formato: non senza patire la pressione all'esculturazione di culture e religioni di nuovo abitate da fermenti ostili.
Non dovevamo aspettarcelo, quando fra '800 e '900 profeti che giudicavamo improbabili ci ammonivano del prezzo che sarebbe stato pagato dalla nostra mondanità spirituale?
In ogni modo si apre ora, per noi, il kairos di una elaborazione e appropriazione sapienziale (culturale) dell'annuncio del regno di Dio nel contesto della società secolare. Non è il kairos della ricostruzione del tempio che custodisce e conferma la sopravvivenza dei devoti: è il momento della illuminazione del tempo della promessa del riscatto che riaccende la creatura avvilita.
L'inedito di questo kairos che Dio ha destinato precisamente a noi, di cui dovremmo andare orgogliosi invece di lagnarci continuamente, è un'epoca nella quale il vangelo si rivolge a una società istituzionalmente non-religiosa.
Congiuntura sino a questo momento mai apparsa sulla faccia della terra. L'appello è a una creatività che, sostanzialmente, non ha precedenti. E nondimeno, la critica religiosa della religione umana e la critica sapienziale della sapienza umana, che apprendiamo dalla pervasiva ironia della Parola biblica di Dio, sono una risorsa strepitosa e altrettanto inedita nel concerto delle religioni storiche.
Riconoscere questa ironia nelle pieghe del testo chiede naturalmente dimestichezza con la lettera: purché lo spirito non sia impigrito da una lettura così ‘pettinata’ da riuscire a non farci leggere quello che realmente «sta scritto».
Una lingua biblica che diventa lingua materna, non si scandalizza pateticamente delle ambiguità del sacro in cui dobbiamo vivere, né si lascia abbattere dall'esaurimento delle formule devote delle quali non possiamo più vivere.
Il suo tema - il tema della fede della testimonianza - è di nuovo la creazione di Dio: la salvezza della comunità credente dei pochi è appesa all'avvento e al riscatto della creazione per i molti.
La fede non è preoccupata di marcare la separazione delle sorti della comunità dal destino dell'umanità: esiste un solo mondo e una sola storia per tutti, nella quale il regno di Dio si fa e nella quale noi abitiamo.
Le Scritture sacre parlano di questo. Siamo noi che parliamo d'altro.
Non sembri troppo banale questa considerazione conclusiva: non dobbiamo forse ricominciare dall'ABC, restituendo anzitutto al corpo scritturale della Parola dignità di venerazione e incanto di lettura? Nella nostra pratica corrente, la devozione per il corpo scritturale della Parola ha quasi abolito la sua differenza simbolica rispetto alle nostre parole e ai nostri scritti.
[1] La relazione è stata tenuta il 13 settembre 2021. Il Convegno aveva per titolo Il dono della Parola. Come le Scritture sono un dono per la vita; vedi l’intervento integrale al link su YouTube https://www.youtube.com/watch?v=kC1rl2I0IzE.
[2] PierAngelo Sequeri, Interlocutori creativi della Parola. La riabilitazione delle Scritture sacre come lingua materna, in “La Rivista del Clero Italiano” CIII (2022), pp. 9-20.
[3] Sequeri sottolinea anche nella relazione che si dimentica che “il Concilio di Trento ha costituito un primato dogmatico cattolico esclusivo della Scrittura. È Trento a precisare: Nessun’altra parola sarà ispirata come quella di questi scritti. Certo saranno ispirati anche i discorsi dei papi, dei dogmi, ma niente come questo! – dice Trento – ma qui si tratta di un’ispirazione “singolare”: quella delle Scritture non la può battere nessun’altra parola, mai. Essa è norma normans. Anche il dogma è norma, ma è norma proxima, traduzione della Parola vicina a noi. La terza cosa che si dimentica di Trento è che esso dice che La Chiesa riceve queste Scritture come ispirate, non perché avendole guardate ha visto che sono coerenti con la fede, ma sono loro che dicono a te se la tua fede è retta! La Chiesa non riconosce la Parola di Dio in questo modo, cioè avendo visto che queste cose andavano bene, allora le dichiara ispirate e nemmeno perché essendo state scritte da chi le ha scritte, allora la Chiesa ha deciso che vanno bene. No, la Chiesa non ha questa istanza, bensì riconosace di essere sotto le Scritture e il loro primato e ruolo non sono eliminabili. Questa mediazione è sovrana, non può essere persa. È il modo fondamentale ed è tutto il resto che deve aver cura di controllare di essere allineato”. Anche se bisogna anche qui aggiungere che il “mondo protestante di allora era fondamentalista e pensava ad una dettatura di Dio, mentre la lingua biblica non è il suo vocabolario e la sua sintassi. I biblisti si sono liberati da questo, se sia ispirato l’ebraico, ad esempio. Se ne sono liberati meno i teologi fondamentali!”.



