Andalusia: dal mito alla storia. Appunti per un accostamento realistico a al-Andalus, di Andrea Lonardo
- Tag usati: andalusia, islam, scritti_andrea_lonardo
- Segnala questo articolo:
Mettiamo a disposizione sul nostro sito un articolo di Andrea Lonardo. Restiamo a disposizione per l’immediata rimozione se la sua presenza sul nostro sito non fosse gradita a qualcuno degli aventi diritto. Per approfondimenti, cfr. la sotto-sezione Alto medioevo nella sezione Storia e filosofia.
Il Centro culturale Gli scritti (10/1/2016)
N.B. Non si è provveduto ad uniformare la traslitterazione dei termini arabi, ma li si è lasciati così come i diversi autori citati li avevano traslitterati.
Indice
- Premessa prima a mo’ di introduzione
- Premessa seconda a mo’ di introduzione
- 1/ L’origine del termine Andalusia e la sua estensione cronologico-geografica
- 2/L’invasione della penisola iberica come jihad, come guerra santa
- 3/ Al-Andalus sempre in espansione: una jihad che tendeva a sempre nuove conquiste
- 4/ La trasformazione in moschee di alcuni luoghi cristiani più significativi (la Catedral-Mezquita-Catedral di Cordova e le altre antiche chiese del luogo, Elvira/Albaicín e le antiche chiese di Siviglia e Malaga)
- 5/ Una guerra santa che fa differenza fra musulmani e non musulmani: il saccheggio e la cattura di schiavi
- 6/ Periodizzazione della storia di al-Andalus
- 6.1/ Waliato (711-756)
- 6.2/ Emirato (756-929)
- 6.3/ Califfato (929-1031)
- 6.4/ I periodo di Taifas (1031 – 1090)
- 6.5/ Dominazione degli Almoravidi (ca.1056 – 1147)
- 6.6/ II periodo di regni di Taifas tra il 1144 ed il 1172
- 6.7/ Dominazione degli Almohadi (1121 - 1269)
- 6.8/ III periodo di Taifas (1228-1266) e Nàsridi (1232 – 1492)
- 7/ Al-Andalus fu una società arabo-islamica e non multi-etnica
- 8/ I dhimmis, sottoposti a tassazione specifica a sottolineare lo statuto di concessione da parte dell’Islam per la permanenza di non musulmani all’interno della società
- 9/ La possibilità di ascendere in carriera per motivi di competenza
- 10/ Al-Andalus e la questione del rapporto fra ragione e rivelazione (e, quindi, della legittimità o meno della violenza o della libertà religiosa)
- 11/ Le traduzioni in arabo, latino, ebraico
- 12/ L’assenza di un libero associazionismo popolare
- 13/ La schiavitù come fenomeno abituale in al-Andalus
- 14/ I mozarabi
- 15/ Gli episodi di esplicita persecuzione dei cristiani in al-Andalus e i muladiès
- 16/ La suddivisione degli spazi nell’Alhambra di Granada e il ruolo della donna in al-Andalus
- 17/ Le lotte intestine che indebolirono al-Andalus lungo tutta la sua storia ed, in particolare, le tensioni fra arabi e berberi
- 18/ La fine del regno nasride di Granada
- 19/ Quale interpretazione dare di al-Andalus? Riflessioni conclusive
- Note al testo
Premessa prima a mo’ di introduzione
Se non ci fosse stata la Reconquista e la penisola iberica fosse rimasta musulmana non avremmo avuto Pablo Picasso, Antoní Gaudi, José Luis Rodríguez Zapatero, il flamenco, il jamón serrano e neanche la sangría - solo per fornire qualche elemento figurativo, politico o alimentare che ognuno può approvare o disapprovare: solo un’immagine, insomma, per dire che parlare della storia dell’Andalusia non è discutere di qualcosa senza effetti.
È francamente buffo incontrare persone incoerenti che difendono con animosità determinate figure libertine della Spagna e, allo stesso tempo, difendono l’Andalusia musulmana disprezzando i protagonisti della Reconquista: sono persone che sputano nel piatto in cui mangiano.
Già solo questo accenno mostra come la storia della penisola iberica è qualcosa di estremamente complesso e non riducibile a facili clichés: come prima premessa era importante ricordare subito che i fatti cui si farà riferimento non sono stati indolori né senza conseguenze per la vita di un popolo.
Premessa seconda a mo’ di introduzione
Non appena si decide di iniziare un approfondimento della storia dell’Hispania musulmana, ci si accorge immediatamente, come per l’alto medioevo italiano, che gli studi seri sono pochissimi e pochissimo divulgati. Se si digita, per esempio, su un motore di ricerca “storici arabi” si è indirizzati agli storici arabi delle crociate, ma non si trova quasi niente che aiuti a comprendere quale fosse la prospettiva sull’Hispania musulmana degli storici musulmani del tempo - ovviamente in prima battuta, se non si ha già un bagaglio culturale che determini ulteriormente la ricerca.
Una visione politicamente corretta domina, dai testi per bambini a quelli scolastici a quelli turistici: il cliché del bel mondo andaluso dove musulmani, ebrei e cristiani vivevano in pace, anzi in un rispetto reciproco mai conosciuto prima, domina la scena[1].
Ma è questa la vera storia dell’Andalusia musulmana? Lo studio che segue vuole indicare alcune piste di approfondimento. Sarà possibile solo abbozzarle per indicare la prospettiva giusta per affrontare con senso storico la questione.
1/ L’origine del termine Andalusia e la sua estensione cronologico-geografica
Già il termine Andalusia ricorda che si tratta di una terra che apparteneva ad altri e che venne conquistata. All’antica etimologia che pretendeva la derivazione da Vandalusia (cioè terra dei vandali) gli studiosi moderni ne preferiscono un’altra che ricorda sempre il periodo barbarico: il termine deriverebbe dal termine goto Landahlauts (lotti terrieri), i feudi, cioè, dell’Hispania visigotica. Gli arabi, invadendola, ne avrebbero arabizzato il nome in bilād al-landahlautsiyya (paese dei feudi gotici) che si semplificò in bilād al-andalusiyya ed, infine, in al-Andalus[2].
Se oggi l'Andalusia è una delle diciassette comunità autonome della Spagna, composta da otto province (Almería, Cadice, Cordova, Granada, Huelva, Jaén, Málaga ed il capoluogo Siviglia), per comprendere l’azione dei saraceni nella penisola bisogna, invece, ricordare che l’al-Andalus - così sarà chiamata in questo studio, proprio per distinguerla dalla regione odierna dell’Andalusia - dei musulmani arrivò ad occupare quasi l’intera penisola, comprendendo, ad esempio, Barcellona, le Baleari, Toledo, Madrid, Porto ed addirittura parte dell’odierna Francia meridionale (la zona detta allora Settimania comprendente le odierne Narbona e Carcassonne). La stessa Galizia fu a rischio di divenire parte di al-Andalus: infatti Santiago di Campostela venne almeno una volta saccheggiata dai musulmani andalusi, tanto la loro azione di conquista era decisa.

Al-Andalus nel 732 pochi anni dopo
gli inizi dell'invasione nel 711

L'antica Settimania che appartenne ad al-Andalus
La fondazione stessa di Madrid ha origini musulmane, poiché gli andalusi islamici eressero in quel luogo un palazzo-forte, un alcázar, che venne chiamato Magrit in arabo, poi allargatosi nel tempo fino a diventare città e poi recentemente capitale. Si vedono oggi i resti della muraglia della Magrit araba nei pressi della Cattedrale de la Almudena. Magrit venne, infatti, fondata come fortificazione a difesa di Toledo che era allora la capitale di al-Andalus, prima che la città guida venisse nuovamente spostata a sud, precisamente a Cordova, a motivo della Reconquista.
Insomma, l’avanzata islamica di al-Andalus si spinse fino a lambire gli odierni Paesi baschi, le Asturie, la Galizia, l’estremo nord del Portogallo e la zona meridionale delle Gallie con incursioni che colpirono più e più volte le popolazioni di questi luoghi.
Da tutti i punti di vista sembra opportuno intendere per Andalusia/al-Andalus piuttosto che una regione un periodo di dominio arabo-islamico sulla penisola iberica, se si desidera comprendere qualcosa degli avvenimenti storici, poiché Barcellona, Tudela in Navarra, Madrid o Lisbona furono andalusì tanto quanto Cordova o Siviglia.
D’altro canto non si deve dimenticare che l’al-Andalus iberica fu all’inizio e poi più volte nella storia una sola cosa con il Maghreb islamizzato, anche se continui furono i conflitti fra arabi, maghrebini e berberi nella storia di al-Andalus, come si vedrà a suo luogo.
2/L’invasione della penisola iberica come jihad, come guerra santa
L’invasione dell’Hispania visigota viene giustificata nelle fonti arabe come una jihad, una guerra santa. Ibn al-Kardabūs, ad esempio, scrive, trattando dei primissimi anni della conquista, vivente ancora Ṭāriq: «Mūsà avanzò finché giunse fino a Toledo, la sconfisse, conquistò diciotto città, saccheggiò, prese prigionieri e si ritirò. Vi rimase circa tre anni facendo la guerra santa (yuŷāidu)»[3]. Ibn al-Kardabūs, che visse a Tawzat/Tozeur nella II metà del XII secolo trasmette il sentire delle popolazioni di al-Andalus ed il linguaggio dell’epoca: la conquista di Toledo ed i successivi saccheggi, depredazioni e cattura di prigionieri erano “guerra santa”, jihad.
Egli ricorda le parole attribuite a Ṭāriq che si rivolge ai suoi soldati: «Per Allah! Se mi aiutaste io giungerei con voi fino alle porte di Roma o di Costantinopoli e le conquisterei con il beneplacito di Allah, però penso che voi siate già stanchi […], torniamo indietro»[4]. È evidente da testi come questo l’ideale di una guerra santa che giungesse fino alle due capitali cristiane d’occidente e d’oriente, come ricorda anche un hadith dello stesso Maometto[5].
Nella sua storia Ibn al-Kardabūs ovviamente amplia in maniera leggendaria la forza con cui l’invasore si impose al regno cristiano-visigoto, come quando racconta che per spaventare gli avversari gli arabi invasori fecero credere alle spie del nemico di essere cannibali e di mangiare gli sconfitti[6].
La violenza[7] impregna la trama del racconto di Ibn al-Kardabūs, come quando egli racconta delle parole di Ṭāriq appena sbarcato nella penisola iberica che dice ai suoi al momento di salire verso il nord alla conquista di Cordoba: «Combattete o morite»[8], che riecheggiano le parole di Khalid ibn al-Walid, generale di Maometto, che affermava, per spiegare le prime vittorie militari del califfato nel VII secolo: «Porto uomini che desiderano la morte come voi desiderate la vita», intendendo dire che le armate musulmane erano pronte alla morte per la fede, mentre gli avversari erano troppo attaccati alla vita in questa terra per poter vincere.
Il termine jihad si trova anche – ma gli esempi si potrebbero moltiplicare – in Ibn ‘Idárí[9], che riferisce di un episodio avvenuto l’anno 863, durante il regno di Muhammad I. L’emiro, in vista di un’azione militare contro la Galizia, dispensò gli abitanti di Cordoba dall’essere obbligati a servire sotto le armi e stabilì, invece, quanti soldati dovessero fornire le altre città[10]. Agli abitanti di Cordoba «lasciò libera scelta a loro arbitrio per i volontari che desideravano partire per la guerra santa (jihad)».
Gli storici arabi del tempo sono consapevoli che l’invasione progressiva della penisola iberica è una guerra di pura conquista, senza alcun intento difensivo. Qualificarla come jihad vuol dire per loro porla come una guerra a servizio dell’espansione dell’Islam, compiuta come dovere di fede perché le nuove terre occupate potessero essere convertite all’Islam – l’obbligo antico del jihad può essere paragonato, mutatis mutandis, al dovere cristiano di predicare il Vangelo.
3/ Al-Andalus sempre in espansione: una jihad che tendeva a sempre nuove conquiste
Proprio per il suo specifico statuto di jihad l’invasione tendeva ad allargarsi. La punta avanzata dell’invasione fu la baia dell’odierna Saint-Tropez dove gli arabi musulmani di Andalusia crearono una testa di ponte nel luogo dove ora sorge il Fort Freinet de La Garde-Freinet, allora noto come Fraxinetum.
Solo per dare qualche riferimento alla penisola italiana si può ricordare che le truppe piratesche di al-Andalus da Fraxinetum si impossessarono di Susa e dell’abbazia della Novalesa nel 906[11]. Da lì risalirono fino al Gran San Bernardo compiendo devastazioni. Attaccarono Genova[12] e poi Acqui nel 934-935 (si potrebbe dire che le Repubbliche Marinare di Genova, Pisa ed Amalfi crebbero proprio quando ebbero la forza di opporsi all’invadenza dei Mori che da al-Andalus e dal nord Africa, legate dalla stessa dominazione, cercavano di avere il controllo su tutto il Tirreno). Più volte le avanguardie di al-Andalus attaccarono l’abbazia di San Fruttuoso che fungeva anche da luogo di rifugio e difesa contro i Mori per chi viaggiava in mare. Le fonti latine ed arabe sono nella sostanza concordi nel riferire i fatti. Liutprando racconta[13]: «I Saraceni stanziati a Frassineto, radunato un numeroso esercito, giunsero sino ad Acqui, che dista cinquanta miglia da Pavia, sotto la guida di un feroce capo di nome Sagitto […] per grazia di Dio, attaccata battaglia, quel disgraziato morì con tutti i suoi» e in quello stesso anno una flotta araba giunta dall’Africa sbarcò a Genova «posta sul mar Tirreno a ottocento stadi da Pavia»: i Mori entrarono in città, trucidarono la popolazione e ripartirono carichi di bottino.
Il saccheggio delle zone costiere e le azioni nell’interno fu arrestato solo dopo che per diversi decenni anche il passo del Gran San Berardo fu nelle mani dei saraceni di quell’avamposto. Una crociata pose fine all’insediamento musulmano di Fort Freinet quando gli andalusi islamici giunsero a rapire l’abate di Cluny, San Maiolo, appunto al passo del Gran San Bernardo[14]. Il fatto destò tanto scalpore che si decise un intervento comune che rigettasse a mare gli arabi.
Anche le azioni contro Roma alla metà del IX secolo, con i due attacchi musulmani che portarono alla devastazione delle basiliche di San Pietro e San Paolo situate fuori le mura che difesero invece la città dalla furia degli invasori, sono da situare in questo stesso contesto di jihad che dal Maghreb e da al-Andalus proseguiva nel tentativo di nuove conquiste: le mura dette di Passetto di Castello, sorte sulle Mura leonine erette da papa Leone IV negli anni 847-855 a difesa degli attacchi arabi, sono mute testimoni del pericolo che dal mare poteva venire in quegli anni[15].
Le incursioni non si rivolgevano, però, solo verso la Provenza e di lì verso i passi alpini e verso le coste della penisola italiana, ma le truppe andaluse spingevano costantemente verso il nord della penisola iberica e verso l’est, nella Gallia al di là dei Pirenei.
Le continue incursioni degli andalusi islamici verso il nord della penisola fecero sì che si creasse una no man’s land al di sopra di Toledo, tanto era rischioso che insediamenti umani si stabilissero troppo vicino alle città islamiche andaluse, perché da un momento all’altro una razzia avrebbe potuto devastare eventuali abitati, con saccheggi e razzie di persone da vendere come schiavi. L’esodo da queste regioni si diresse alle origini dell’invasione araba verso il regno delle Asturie; l’afflusso dei profughi fece molto presto di Oviedo “la città dei vescovi” ed artisti in fuga lavorarono agli ultimi monumenti dell’arte asturiana: a Tunon alla fine del IX secolo, a Valdedios all’inizio del X. Fu, in particolare, il re Alfonso I delle Asturie (739-757) che facilitò lo spopolamento delle regioni del bacino del Duero, creando una no man’s land fra sé e gli invasori, verso la fine dell’VIII secolo[16].
Anche da questo punto di vista, quindi, l’immagine di al-Andalus non è di una realtà statica, così come talvolta la si presenta. Piuttosto appare una società in continua espansione che si sarebbe ulteriormente allargata se non fossero intervenuti fattori esterni e contrari.
4/ La trasformazione in moschee di alcuni luoghi cristiani più significativi (la Catedral-Mezquita-Catedral di Cordova e le altre antiche chiese del luogo, Elvira/Albaicín e le antiche chiese di Siviglia e Malaga)
La storia materiale di alcuni edifici di al-Andalus permette di aggiungere ulteriori tasselli alla comprensione delle modalità di conquista araba dell’Hiberia cristiano-visigotica.
4.1 Cordoba e la sua Cattedrale-Moschea-Cattedrale
Il primo e più importante edificio che già da solo dice quasi tutto dell’evoluzione che dovettero subire le diverse chiese delle città conquistate è la cattedrale di San Vincenzo/San Vicente (martire sotto Diocleziano e originario di Saragozza) di Cordoba, la famosa Cattedrale-Moschea-Cattedrale (anche se il primo termine viene spesso dimenticato e nelle guide l’edificio è designato solo come Mezquita-Catedral).
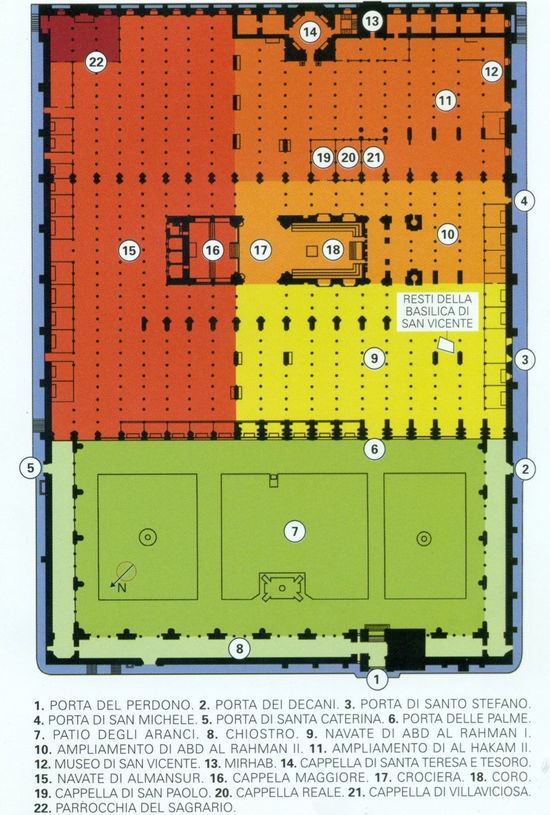
La pianta della Cattedrale-Moschea-Cattedrale di Cordoba
con l'indicazione del punto in cui è possibile vedere gli
scavi dell'antico complesso della cattedrale di San Vincenzo
Entrando nella Cattedrale-Moschea-Cattedrale, nella zona più antica eretta da ‘Abd al-Rahmān I, è possibile rendersi conto che gli archi della moschea sono costruiti su di un riempimento che nasconde delle strutture paleo-cristiane: si vede, infatti, in basso, in una zona esplorata dagli scavi e tuttora visibile grazie ad un’apertura a vetrata, un pavimento a mosaico che secondo alcuni sarebbe il pavimento stesso della primitiva cattedrale paleo-cristiana di San Vincenzo precedente alla moschea, secondo altri sarebbe comunque pertinente ad un locale annesso alla cattedrale stessa.

Gli scavi all'interno della moschea del tempo di ‘Abd al-Rahman
I che mostrano il livello dei pavimenti paleo-cristiani
Nel corso degli scavi che portarono alla scoperta del sottostate complesso della cattedrale, dell’episcopio e degli annessi locali, venne anche recuperato il materiale che è ora nel Museo di San Clemente, sempre nella Cattedrale-Moschea-Cattedrale, nell’angolo in fondo a destra rispetto all’ingresso. Sono lì esposti materiali con croci ed iscrizioni cristiane che appartenevano alla cattedrale distrutta per fare posto alla successiva moschea.



Il Museo di San Clemente allestito all'interno
della Cattedrale-Moschea-Cattedrale di Cordoba
che espone i resti romani, paleo-cristiani
e visigoto-cristiani degli scavi
Gran parte del materiale dell’antica chiesa è stato utilizzato nella moschea di ‘Abd al-Rahmān I: si vede chiaramente il materiale della cattedrale riutilizzato - “di riporto” è il termine tecnico – ed in particolare le colonne, i basamenti ed i capitelli che dovevano essere in gran parte pertinenti all’antica chiesa dei cristiani.
Al dato archeologico si affiancano le fonti letterarie che sono di prezioso aiuto per conoscere la storia antica dell’edificio.
Due storici arabi lontani dagli anni dell’invasione Ibn ‘Iḏārī (XIII secolo) e al-Maqqarī (XVII secolo) riferiscono ciò che avvenne. Entrambi dipendono da una fonte precedente scomparsa e precisamente al-Rāzī, anch’egli non contemporaneo dei fatti, ma a dire degli storici moderni ben informato. I due storici concordano nel dire che non appena Cordoba fu conquistata (quindi poco dopo il 711) «i musulmani divisero la grande chiesa che era nel centro città con i non-arabi di Cordoba. I musulmani edificarono una moschea per il raduno della popolazione nella loro metà; l’altra parte restò nelle mani dei cristiani»[17].
Quello che la maggior parte dei commentatori moderni trascurano di ricordare è che il testo prosegue con affermazioni significative: afferma, infatti, che contestualmente tutte le altre chiese cristiane vennero distrutte.
Il testo trasmesso da Ibn ‘Iḏārī dice, infatti, che «le altre chiese furono demolite», mentre quello di al-Maqqarī precisa: «le altre chiese di Cordoba, la capitale, furono demolite (wa-hudimat ‘alay-him sā’iru al-kanā’is bi-hadrat Qurtuba)»[18].
Questo “particolare” offre la giusta prospettiva per comprendere cosa raccontano i due storici arabi che ricordano che i conquistatori vollero così rifarsi a quanto era avvenuto a Damasco dove gli Omayyadi eressero la loro moschea principale a fianco della chiesa dei cristiani. I conquistatori intesero instaurare immediatamente, già nel 711, una relazione di dominio sui cristiani tale che venissero distrutte tutte le loro chiese, in maniera da mostrare immediatamente chi deteneva il potere, conservandone però una sola e questa solo parzialmente, poiché una metà venne presa dagli invasori, di modo che i cristiani non fossero impediti nel culto, ma lo celebrassero nella sola chiesa rimasta in piedi ed ormai vicina alla moschea principale, in maniera da essere chiaramente riconoscibili e, se necessario, controllati.
La drammaticità di ciò che si verificò immediatamente, non appena i conquistatori musulmani giunsero a Cordoba, è confermato da un passaggio successivo dei due storici arabi.
Essi ricordano che, al tempo del primo emiro, ‘Abd al-Rahmān I, si pose la questione dell’allargamento della moschea. L’emiro allora «chiamò i non-arabi di Cordoba e chiese loro di vendere quella parte della chiesa che ancora era loro. Egli li pagò, rispettando il patto di sottomissione che avevano fatto [nel 711] e permise loro di ricostruire le chiese che erano state demolite al tempo della conquista di Cordoba fuori della città. Così essi lasciarono la struttura e l’emiro la prese ed estese la moschea in essa. ‘Abd al-Rahman, [chiamato] al-Dakhil, iniziò la demolizione della chiesa e la costruzione della moschea nell’anno 169 [785/6]; la sua costruzione terminò […] nell’anno 170 [786/7] - il periodo di un anno intero»[19]
Si comprende facilmente quanto poco fu “libera” la vendita della restante metà della cattedrale di San Vincenzo da parte di una popolazione sottomessa, ma bisogna riconoscere che il gesto di offrire del denaro da parte dell’emiro fu benevolo. Il dato, però, più significativo è la contestuale concessione ai cristiani di ricostruire le chiese distrutte nel 711, ma – si noti bene – fra di esse solo quelle che erano all’esterno della città, cioè della medina cinta da mura. Ovviamente le chiese più importanti di Cordoba prima del 711 erano all’interno delle mura. L’emiro non concesse di ricostruire queste, bensì solo quelle all’esterno della medina.
In effetti, nei testi letterari che trattano della Cordoba nel periodo califfale, si ha notizia di quattro chiese: «in ognuna delle quattro grandi estensioni della città si incontra una chiesa o un monastero, a differenza della città vecchia (al-madīna al-‘atīqa, secondo l’espressione utilizzata da Ibn Baškuwāl, o al-qasaba al-‘atīqa, secondo quella di Ibn al-Ḫatīb), o ancora semplicemente qasabat Qurtuba, cioè circondata da un muro, dove non vi è alcun luogo di culto cristiano certo» dopo l’invasione[20]. Le fonti parlano, invece, di altre chiese e monasteri nelle campagne o nella Sierra, ancora più lontane dal centro abitato.
Recentemente è stato sottoposto ad analisi un carteggio estremamente interessante che aiuta a comprendere la situazione dei dhimmis – si vedrà dopo che con questo termine si designano le popolazioni non islamiche sottomesse. Esso tratta di una discussione tenutasi a Cordoba nell’XI secolo per decretare la distruzione di una nuova sinagoga appena costruita dagli ebrei cordovesi subito fuori la Porta degli Ebrei[21]. L’argomentazione prodotta dai giuristi musulmani del tempo per emettere il decreto di distruzione dell’edificio ricorda che «non è secondo la Legge islamica che dei ḏhimmīs, ebrei e cristiani, “ristrutturino” chiese o sinagoghe nelle città dei musulmani e in mezzo ad essi (walaysa fī šarā’i‘ al-islām ihdāṯ ahl al-ḏimma min al-yahūd wa-l-nasārā kanā’is wa-lā šūnūġāt fī madā’in al-muslimīn wa-bayna zahrānayhim)».
Ad un certo punto interviene lo stesso cadi di Cordoba del tempo Abū l-Asbaġ ‘Īsā Ibn Sahl che dice: «Ibn Habīb, nella parte concernente la jihad della sua opera al-Wādi riporta ciò che aveva detto Ibn al-Māğišūn [un maestro del IX secolo], riprendendolo da Mālik [Ibn Anas], che affermava che il Profeta aveva detto: “Non fate sorgere presso di voi niente dei giudei, né dei cristiani (Lā tarfa‘unna fī-kum yahūdiyya wa-lā nasrāniyya)”».
Prima di emettere la sentenza si ricorda poi che Ibn al-Māğišūn aveva detto: «Non costruite chiese né in dār al-Islām, né nel suo santuario, né nel suo territorio, a meno che i ḏhimmīs non siano separati dal dār al-islām e dal suo santuario e non si trovino in mezzo ad essi dei musulmani. Poiché non è interdetto loro di costruire presso di loro, né di introdurre vino tra di loro, né di procurarsi carne di maiale. Ma se essi si trovano in mezzo ai musulmani, tutto questo deve essere loro vietato».
A questo punto il tribunale di Cordoba, dopo che le autorità musulmane del passato sono state evocate con il loro insegnamento che proibisce il restauro di chiese vicino alle abitazioni musulmane, può emettere la fatwā che ordina la demolizione della sinagoga rinnovata.
Si vede che quella descritta da una fatwā di tal genere è la situazione delle chiese cristiane di Cordoba. Una volta che l’ultima chiesa all’interno della cinta muraria, è cioè la metà restante della cattedrale di San Vincenzo, viene demolita, le chiese restanti sono tutte nella periferia della città. Molénat, che ha studiato il documento, ricorda che dalle fonti emerge che a Cordoba, dopo la distruzione totale della cattedrale, per far posto alla moschea, sono documentate solo quattro chiese, tutte nella periferia della città, fuori dalle mura: i quartieri nei quali erano situate tali chiese portavano il nome delle chiese riedificate e non toponimi islamici, segno che tali quartieri erano abitati evidentemente solo da cristiani.
Il permesso accordato dal primo califfo ‘Abd al-Rahmān I di ricostruire le chiese extra-murarie si può comprendere allora come concessione in cambio dell’acquisto della parte rimasta cristiana dell’antica cattedrale, unitamente ad un indennizzo in forma di denaro.
La storia della distruzione della cattedrale di Cordoba unitamente alla distruzione di tutte le altre chiese ed il permesso di erigere nuovamente quelle già distrutte, ma solo all’esterno della Medina[22], aiuta a comprendere quale fosse la condizione dei dhimmis: i cristiani potevano sì continuare ad esistere, potevano sì avere dei luoghi di culto, ma tutto ciò avveniva entro una cornice ben precisa dettata dal diritto musulmano e dalla loro condizione di “protetti”.
4.2/ Illiberis/Elvira che divenne Albaicìn


La vicenda che portò la cattedrale di San Vincenzo a Cordoba a divenire la Mezquita Aljama (la moschea maggiore) della capitale di al-Andalus può essere assunta ad immagine di ciò che avvenne in tutte le altre città dell’Andalusia musulmana.
Si pensi a ciò che dovette avvenire all’antica Illiberis/Elvira che giace sotto l’attuale quartiere di Albaicìn a Granada. I testi turistici moderni insistono sul fatto che l’antica medina araba venne poi abitata e ricostruita dai cristiani dopo la Reconquista, ma si dimenticano di ricordare che quel quartiere era l’antica città iberica e poi visigotica che ebbe in età paleo-cristiana una storia così importante da ospitare il Sinodo/Concilio di Elvira.
L’importante concilio che vi si celebrò vide riuniti i vescovi delle cinque province romane nella quale era divisa allora l’Hiberia. Stranamente ci è pervenuto, negli atti del concilio stesso, il giorno di inizio del concilio stesso, il 15 maggio, ma non l’anno preciso. La data deve essere posta certamente negli anni intorno alla persecuzione di Diocleziano, ma gli studiosi sono divisi se si sia tenuto negli anni 306-314, subito dopo la persecuzione, o immediatamente prima di essa. P. de Luis propende per gli anni 300-303[23].
Gli atti del Concilio si soffermano a più riprese a dare indicazioni ai vescovi, ai sacerdoti ed ai fedeli, perché la fede sia vissuta senza sincretismi con il paganesimo del tempo. Fra i firmatari del Concilio troviamo il vescovo di Cordoba, Ossio, che diverrà poi uno dei principali consiglieri di Costantino imperatore nelle questioni ecclesiali (famosa è la sua presenza al Concilio di Nicea). Il canone più famoso del Concilio di Elvira è il 33 che, pur nella diversità di interpretazioni che ha suscitato, mostra chiaramente la crescente valorizzazione del celibato ecclesiastico, poiché chiede a vescovi, sacerdoti e diaconi, pur se sposati prima dell’ordinazione, di vivere in continenza (il testo è discusso per l’esatta interpretazione dell’espressione “per tutti i chierici che sono impegnati nel servizio dell'altare”).
Ebbene delle chiese di Elvira e della cattedrale che venne sicuramente costruita nella città dopo la svolta costantiniana non resta traccia. Gli edifici cristiani dovettero essere distrutti, similmente a ciò che avvenne a Cordoba, dai conquistatori musulmani non appena arrivarono in città. Gli scavi archeologici hanno finora restituito un pluteo di una chiesa visigota che si può ammirare nel locale Museo archeologico di Granada ed il basamento di un fonte battesimale emerso durante lavori nel quartiere di Albaicìn[24].

Pluteo di arte-cristiano-visigota appartenente ad una chiesa scomparsa
sotto la medina araba di Albaicìn oggi nel Museo archeologico di Granada
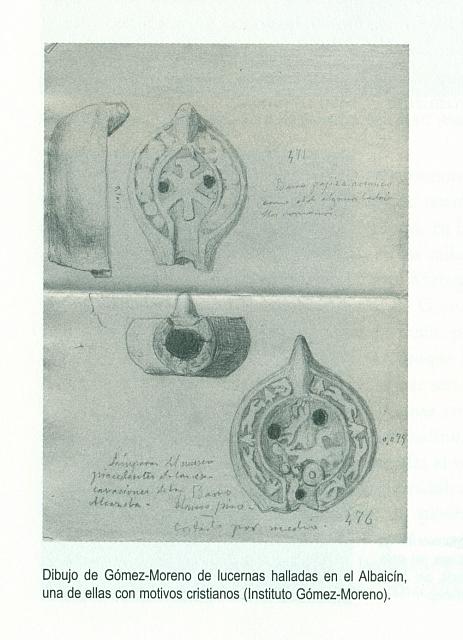
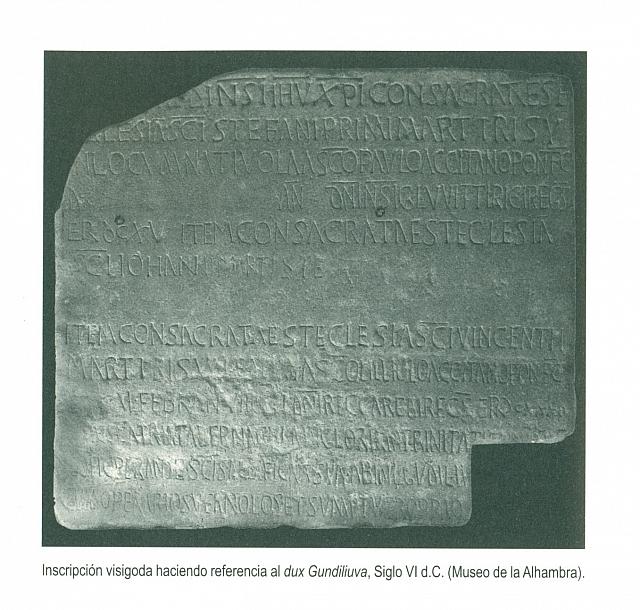
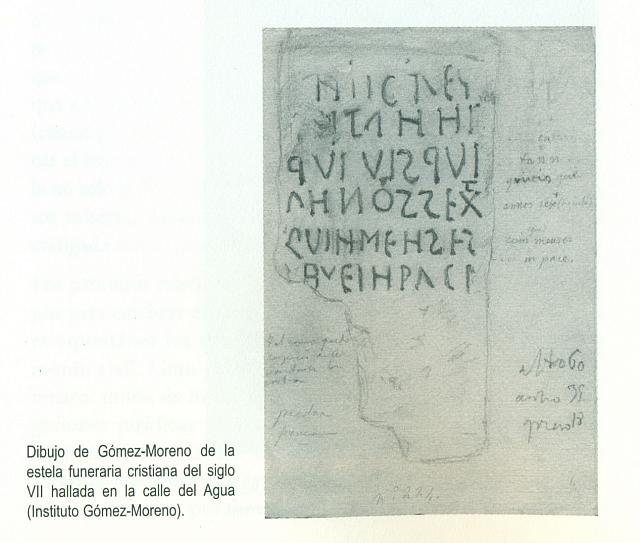
Dell’Elvira cristiana resta ormai solo la localizzazione: la collina di Albaicìn.
4.3/ Siviglia paleo-cristiana e visigota e Siviglia andalusa
Un discorso analogo deve essere fatto per Siviglia.
Alcuni studiosi hanno proposto che la primitiva Moschea Aljama sia stata costruita sopra l’antica Chiesa di Santa Gerusalemme che fu, fra l’altro, sede del I e del II concilio Sivigliano, tenutisi rispettivamente nel 590 e nel 611, e che fosse situata dove sorge ora la plaza del Salvador.
Invece il luogo dove sorse la Mezquita con il minareto divenuto poi il campanile della Torre della Giralda – anche qui la Mezquita venne poi trasformata in cattedrale - era probabilmente il sito della basilica dedicata in Siviglia a San Vincenzo e dei suoi edifici di pertinenza. Alcuni resti della basilica cristiana sono stati, infatti, recuperati negli scavi del Patio de Banderas, a fianco della cattedrale, nella zona dei Reales Alcazares, dove è stato ritrovato l’antico battistero ed un’epigrafe funeraria metrica dedicata al vescovo Honorato[25].
L’unico resto oggi visibile ai turisti dell’antico complesso paleo-cristiano e poi cristiano-visigoto è la vasca posta al centro del patio de los Naranjos[26].
Ibn al-Qutiyya, storico arabo di origine visigota del X secolo, ricorda alcuni dati storici in linea con quanto fin qui esposto relativi ad un altro luogo di culto cristiano di Siviglia: egli riferisce che la chiesa di Santa Rufina venne scelta come dimora del governatore Abd al-Aziz, immediatamente dopo l’invasione: egli aveva sposato una donna gota, la vedova del re Rodrigo (688-711). Il particolare è noto perché il governatore Abd al-Aziz - riferisce Ibn al-Qutiyya - venne assassinato proprio nella Masûd Rubina, una moschea che era stata la Kanisa (chiesa) Rubina (Rufina); il governatore venne ucciso per intrighi di palazzo[27].
4.4/ Le sinagoghe più note oggi visitabili in Andalusia sono tutte state erette dopo la Reconquista, sotto re cristiani
Un dato che meriterebbe ben altra analisi e che qui interessa solo ricordare è quello relativo alla datazione delle sinagoghe andaluse tuttora visitabili.
Ogni visitatore viene abitualmente ben edotto del fatto che tristemente tali sinagoghe vennero trasformate in chiese dopo la cacciata degli ebrei nel 1492. Ma quasi nessuno viene avvertito del fatto che le stesse vennero erette dopo la Reconquista, sotto re cristiani.
La sinagoga di Cordoba fu costruita – o almeno ricostruita nella sua veste attuale - negli anni 1314-1315[28], dopo che la città era tornata cristiana nel 1236.

Sinagoga di Cordoba eretta solo dopo la Reconquista
A Toledo la Sinagoga de Santa María la Blanca (così chiamata dal nome della chiesa in cui fu purtroppo convertita poi la sinagoga) fu eretta, secondo la tradizione, su commissione del tesoriere reale di Alfonso VIII, Yosef ibn Sosán, agli inizi del XIII secolo[29] – la città era stata strappata ai musulmani dal re Alfonso VI di Castiglia nel 1085.

Sinagoga di Santa Maria la Blanca eretta solo dopo la Reconquista
La Sinagoga del Tránsito, invece, sempre a Toledo, venne costruita sotto gli auspici di Samuel ha-Levi Abulafia, tesoriere di Pietro di Castiglia, intorno al 1356.
Come si vedrà, sarà proprio la Toledo cristiana della Reconquista a specializzarsi in traduzioni di testi dall’arabo e dall’ebraico al latino a partire dal momento in cui l’arcivescovo Raimondo di Toledo (1126-1151) organizzò un vero e proprio collegio di traduttori.
Lo splendore di quegli edifici racconta degli anni della Hispania cristiana e non degli anni di dominio musulmano nei quali tale ricercatezza per edifici ebrei doveva essere difficile da raggiungere. Purtroppo poi tale rispetto si mutò poi nell’odiosa decisione di espulsione presa nel 1492.
5/ Una guerra santa che fa differenza fra musulmani e non musulmani: il saccheggio e la cattura di schiavi
Le fonti arabe precisano anche ulteriori caratteristiche dell’invasione dell’Hispania visigotica, così come delle successive azioni militari che si produssero fino alla resa di Granada: esse implicavano il saccheggio, la presa in schiavitù di bambini, giovani e donne, talvolta addirittura l’uccisione di civili che non si convertivano all’Islam.

Le campagne militari di Almanzor
Per esempio, Una descripción anónima de al-Andalus[30] (un testo scritto in arabo nel XIV secolo) fornisce questo elenco di razzie relative a Muhammad ibn Abī ‘Āmir, cioè al-Manṣūr bi-llāh, noto nei testi latini come Almanzor (regnò dal 978 al 1002)[31]:
Prigionieri nelle razzie (algazúas) di Almanzor:
- 1ª spedizione contro al-Hamma (Baños), dove prese 2000 prigioniere
- 2ª spedizione contro Cuella dove prese prigionieri i suoi abitanti
- 5ª spedizione contro Ledesma dove prese 3000 prigioniere
- 6ª spedizione contro Zamora dove prese 3000 prigioniere
- 7ª spedizione contro Sepúlveda dove fece gran bottino, grande mattanza e devastazioni
- 11ª spedizione contro Qalbilîs dove uccise tutti gli uomini e deportò le donne e i bambini
- 13ª spedizione contro Calatayud dove fece prigionieri i suoi abitanti
- 14ª spedizione contro Zamora dove prese prigionieri e bottino
- 15ª spedizione contro Trancoso, dove prese prigionieri i suoi abitanti
- 16ª spedizione contro Qastiliya, Munt Baliq, Gerona e il suo territorio dove costrinse il re al patto di dargli in sposa sua figlia
- 17ª spedizione contro Toro e i dintorni di León dove prese 1000 prigioniere
- 18ª spedizione contro Simancas dove prese prigionieri i suoi abitanti e ritornò con 17.000 prigioniere
- 20ª spedizione contro Sacramenia dove fece prigionieri i suoi abitanti
- 21ª spedizione contro Zamora dove patteggiò con gli abitanti una grande somma
- 22ª spedizione contro Sepúlveda dove fece bottino e prigionieri in numero incalcolabile
- 23ª spedizione contro Barcelona dove prese 70.000 prigionieri fra donne e bambini
- 28ª spedizione contro Coimbra dove fece prigionieri i suoi abitanti
- 29ª spedizione contro Burbîl dove prese prigionieri
- 30ª spedizione contro Zamora dove prese ricchezze e risorse e 40.000 prigioniere
- 31ª spedizione contro Astorga dove prese bottio e prigionieri
- 33ª spedizione contro Toro dove fece gran mattanza e gran numero di prigionieri
- 36ª spedizione contro Bûn.s, Nájera e Alcocero dove prese 5.000 prigioniere
- 39ª spedizione contro San Esteban con gran mattanza e la cattura di molti abitanti
- 40ª spedizione contro Al-Agâr dove uccise e prese prigionieri i nemici
- 42ª spedizione contro Astorga e León dove catturò molti abitanti e ne uccise altrettanti
- 43ª spedizione contro Qastîliya con immenso bottino e la cattura di García, figlio del re Fernando
- 45ª spedizione contro San Román con gran mattanza e molti prigionieri
- 46ª spedizione contro Galicia e Aguilar dove uccise 20.000 cristiani e ne fece prigionieri 50.000
- 50ª spedizione contro Pallars con molti prigionieri
- 51ª spedizione contro Pamplona dove prese una moltitudine di prigionieri
- 53ª spedizione contro Montemayor dove uccise 10.000 nemici e ne fece prigionieri altrettanti
- 54ª spedizione contro Pamplona dove prese 18.000 prigioniere
- 55ª spedizione contro Bâb.s dove prese gran numero di prigionieri
- 56ª spedizione contro B.t.ryûs dove fece bottino e prigionieri con grande mattanza.
È qui evidente che i prigionieri ed, in particolare, le prigioniere, vengono prelevati per diventare schiavi e concubine e/o per essere successivamente liberati con riscatto.
Il costume di obbligare gli sconfitti in guerra alla conversione o alla morte conobbe alti e bassi nella storia di al-Andalus. Solo per fornire un esempio, si può leggere Ibn Hayyan[32] (storico musulmano di Cordoba, 987–1075) che, in riferimento all’anno 891 (15 maggio), narrando della spedizione dell’emiro Abd Allah I partito alla ri-conquista di Bolúy (Aguilar), racconta:
«Fece portare i prigionieri e disse che tutti quelli che erano musulmani erano salvi, dopo aver giurato che lo erano. In quanto ai cristiani, quelli che non fossero passati all’Islam sarebbero stati uccisi a fil di spada. I cristiani (nasaraniya), che erano circa mille, preferirono tutti la morte all’apostasia e solo uno vacillò al momento di essere giustiziato e salvò la sua vita facendo professione di fede musulmana».
6/ Periodizzazione della storia di al-Andalus
L’Andalusia islamica conobbe una serie di dinastie che si succedettero nel tempo, poiché la rivalità fra diversi gruppi contrassegnò tutta la storia di al-Andalus. La lotta intestina fu, come si vedrà, una delle cause dell’indebolimento e poi dell’estinzione del dominio islamico sul superstite Regno nasride di Granada.
La storia di al-Andalus può essere così periodizzata[33].
6.1/ Waliato (711-756)
Nell’anno 710 il Governatore del nord Africa inviò l’ufficiale Tarif con un gruppo di ricognizione, occupando con successo il promontorio sud della penisola che ricevette il nome con il quale si conosce oggi la città di Tarifa; il Governatore, quindi, organizzò un esercito di circa 8.000 uomini al comando del suo luogotenente Tariq. Partendo da Tangeri, nel 711, attraversò lo stretto e sbarcò in una roccaforte che d’allora si chiamò Yabal Tariq (la montagna di Tariq), oggi Gibilterra.
La conquista fu una rapida vittoria, con battaglie solo contro alcune città, mentre altre si arresero senza combattere. Al-Andalus divenne così una provincia dell’enorme impero Omayyade, con la capitale in Siviglia. Questo periodo è noto con il nome di Waliato (da wali o governatore). Si succedettero 21 governatori, nominati o, piuttosto, direttamente dipendenti da Damasco o dai Governatori di Qayrawan. Non mancarono intrighi e cospirazioni per il potere. In questo primo periodo, mentre continuò la conquista della penisola iberica vennero poste le basi del nuovo stato.
Nell’anno 716 la capitale fu spostata da Siviglia a Cordoba, nel centro dell’attuale Andalusia, per la sua maggiore importanza strategica. Gli Omayyadi continuarono l’avanzata verso nord, entrando in Gallia (l’odierna Francia), dove nel 732 furono sconfitti dalle truppe di Carlo Martello nella famosa battaglia di Poitiers (detta anche battaglia di Tours).
Nella penisola iberica la maggior parte degli otto milioni di abitanti del regno di Toledo non abbandonarono le loro case all’arrivo degli invasori, ma rimasero sul posto, nelle loro città o campagne. Come prima i romani, gli arabi non intesero abusare inizialmente delle loro conquiste (anche se questo deve essere affermato con cautela: si è già visto cosa avvenne alle chiese di Cordoba al momento stesso della conquista). A loro modo, applicarono il criterio virgiliano: “parcere subiectis et debellare superbos”. Chi si affrettò a fare atto di sottomissione, come gli abitanti di Mérida, ebbe effettivamente non solo salva la vita, ma conservò anche le libertà e i possedimenti, mediante il pagamento di tasse di cui si parlerà più avanti.
Malgrado le successive affermazioni dei cronisti cristiani e arabi, gli esordi della conquista araba in Spagna non furono né più idilliaci né più disastrosi del periodo precedente che conobbe una situazione di insicurezza con distruzioni causate dagli interminabili disordini delle invasioni del VII secolo, di cui la Cronaca di Idazio fornisce un quadro desolante.
Lotte senza fine, ribellioni e regolamenti di conti tra arabi, berberi, yemeniti e quaisiti non lasciarono ai primi invasori islamici il tempo di porsi molti problemi sulla condizione dei nuovi sudditi in Iberia, né soprattutto di pensare con determinazione alla diffusione della fede islamica fra la popolazione della penisola. Proprio a causa di questo disordine endemico, il primo mezzo secolo dell’Islam nella penisola iberica permise agli antichi sudditi del regno visigotico di mantenere le proprie strutture.
6.2/ Emirato (756-929)
Una rivolta in Damasco guidata dagli Abbasidi annientò nel 749 la dinastia Omayyade che venne sostituita dalla nuova dinastia Abbaside, essendo stati assassinati il califfo e la sua famiglia. Solo il principe ‘Abd al-Raḥmān riuscì a fuggire, iniziando un avventuroso pellegrinaggio attraverso il nord Africa fino a sbarcare nell’anno 755 ad Almunecar nella Cora (provincia) granadina di Elvira.
L’Andalusia continuò ad essere una provincia dell’Impero islamico, finché ʿAbd al-Raḥmān si proclamò Emiro in Cordova e dichiarò lo stato indipendente.
Durante quasi due secoli l’Emirato consolidò un paese prospero con un grande sviluppo dell’economia e dell’agricoltura.
Con ‘Abd al-Raḥmān (emiro dal 756 al 788), l’Islam in Spagna divenne una salda monarchia, la cui autorità si andò affermando di pari passo con l’intolleranza. ‘Abd al-Raḥmān I soffocò le rivolte di Mérida e Béja, Toledo e Saragozza. Egli organizzò l’amministrazione islamica della Iberia araba e distrusse numerosi edifici cristiani al passaggio della sua armata. Espropriò la seconda metà della chiesa di San Vincenzo di Cordova, che non era ancora stata trasformata in moschea, e fece quindi costruire, lungo il Cortile degli aranci, la prima parte dell’attuale moschea.
La Mezquita Aljama di Cordoba, come si è già visto, venne ri-edificata proprio da ʿAbd al-Raḥmān I con colonne, capitelli e materiali della cattedrale di San Vincenzo che sorgeva sullo stesso luogo e che venne da lui definitivamente distrutta. Il I ampliamento della moschea venne realizzato, invece, da ʿAbd al-Raḥmān II (emiro dall’822 all’852).
‘Abd al-Raḥmān I favorì i matrimoni misti nei quali i figli di padre musulmano dovevano essere allevati nell’Islam. A partire dalla seconda metà dell’VIII secolo si verificarono fra gli abitanti del sud della penisola iberica conversioni in massa, spontanee o forzate, alla religione dei dominatori, che generò il fenomeno dei cosiddetti muladìes (dall’arabo mowlad: gli “adottati”), coloro che rinnegarono il cristianesimo, di cui si tornerà a parlare poi.
Alle endemiche guerre civili si aggiunse l’accresciuto pericolo di una riconquista cristiana. Questa veniva incoraggiata dagli interventi carolingi nel bacino dell’Ebro e in Catalogna e dalle relazioni intercorse fra Carlo Magno e Alfonso II il Casto, la cui pressione per la riconquista si esercitò già in Galizia e fino all’Ebro: il re di Oviedo saccheggiò Lisbona nel 798, un anno prima della rivolta dei Guasconi di Navarra, e tre anni prima della riconquista cristiana di Barcellona nell’801.
In un clima teso, i cristiani mozarabi – cioè, come si vedrà, coloro che restarono cristiani ma si arabizzarono a motivo dei nuovi dominatori - non riuscirono a mantenere gli edifici di culto nei centri cittadini, ma vennero spinti ad abitare nelle periferie dalla corte e dalla popolazione araba. Disponevano di uno statuto particolare[34]; le loro questioni giudiziarie erano decise non da un cadì, ma da un censor o iudex; i carichi fiscali venivano gestiti per l’emiro da un exceptor che raccoglieva i tributi (jarach); infine il “conte di Cordova” trattava direttamente con il califfo, ma non è dato di sapere, se non istituendo una probabile analogia, se simili istituzioni siano esistite nelle altre città del califfato. La gerarchia ecclesiastica mantenne la sua posizione in numerose città: nel IX secolo si riunirono a Cordova diversi concili, sotto la tutela del califfo - in ciò successore degli imperatori cristiani e dei re visigoti. Ma le defezioni si fecero numerose. La fede cristiana si indebolì di fronte alle lusinghe materiali, ed anche intellettuali, della nuova e brillante civiltà islamica dell’Andalusia.
Una minoranza di cristiani si ribellò nella stessa capitale, e di questo piccolo gruppo si fece appassionato interprete, alla metà del IX secolo, il letterato laico Paolo Àlvaro noto anche come Àlvaro di Cordova. A volergli prestar fede, i cristiani nelle funzioni pubbliche “si astengono dal proclamare il Cristo Dio, accontentandosi di parole evasive” davanti ai musulmani, senza fare il segno della croce, né pregare. Adottano il lusso del vestiario e i profumi dei loro dominatori arabi e si preoccupano soprattutto di arricchire la propria famiglia. Un ottantenne, di nome Romanus, denunciato dall’abate Samson, arriva perfino ad adottare la poligamia e, “non curandosi dei precetti del Vangelo, colleziona concubine per soddisfare la sua lussuria”. Mentre dunque i costumi si arabizzano, l’ignoranza dottrinale indebolisce la fede: “Qual è oggi il laico colto, fra noi fedeli?” - si domanda Alvaro con amarezza - “Chi presta attenzione ai libri delle Sacre Scritture, o agli scritti latini di qualsiasi dei nostri dottori? Perfino i chierici devono essere richiamati al significato del loro costume clericale, per evitare che, ignorando il senso spirituale del loro abito, non possano assumere le sembianze degli empi, e imitare i costumi degli infedeli, in cui non vi è alcuna saggezza”.

Al-Andalus al termine dell'emirato (910 ca.)
In reazione a questa arabizzazione si levò il movimento spirituale dei martiri volontari di Cordoba alla metà del IX secolo di cui si parlerà più avanti.
6.3/ Califfato (929-1031)
‘Abd al-Raḥmān III, nel 929, si proclamò califfo, riprendendo il titolo che portavano i suoi antenati - ʿAbd al-Raḥmān I non si era auto-proclamato califfo, ma solamente emiro, dopo che gli abbasidi avevano ucciso il califfo omayyade ed avevano assunto per la propria dinastia il titolo di califfo, spostandone la sede da Damasco a Baghdad.
Assumendo il titolo di califfo ‘Abd al-Raḥmān III si propose, quindi, oltre che come sovrano di al-Andalus, anche come guida religiosa di tutto il mondo islamico – come è noto potere religioso e potere politico non sono mai stati distinti chiaramente nell’Islam a differenza di quanto è avvenuto nel mondo cristiano. In realtà, la proclamazione di ‘Abd al-Raḥmān III a califfo non unificò le diverse correnti e nazioni islamiche del tempo, ma anzi si vennero ad avere tre califfi in lotta l’uno contro l’altro. Infatti, al califfo abbaside di Baghdad che aveva cancellato quello omayyade si era aggiunto nel frattempo il califfato fatimide d’Egitto.
Gli storici ritengono anzi che ‘Abd al-Raḥmān III si sia proclamato califfo proprio in funzione anti-fatimida e, difatti, uno degli obiettivi della sua politica fu quello di limitare l’espansionismo degli arabi d’Egitto guidati dai fatimidi.
Quando ‘Abd al-Raḥmān III succedette nel 912 a suo nonno ‘Abd Allah, il futuro della famiglia omayyade in al-Ándalus non si prospettava particolarmente brillante. I primi anni del suo governo furono dedicati al contenimento e alla risoluzione delle ribellioni che erano state sul punto di porre fine al potere della sua dinastia. Una serie di energiche campagne militari e di abili accordi fecero sì che, in poco tempo, ‘Abd al-Raḥmān III riuscisse a recuperare il terreno perduto e si convertisse non solo nel principe più potente della penisola iberica, ma anche nel primo califfo di Al-Andalus. La sua personalità rappresentò senza dubbio un beneficio fondamentale in questo momento cruciale della storia andalusì ma l’apparente facilità con cui ‘Abd al-Raḥmān III riuscì a ricondurre all’ordine la situazione si spiega meglio se si tiene in considerazione che i fattori di coesione sociale stavano raggiungendo il punto critico, oltre il quale inclinarono definitivamente la bilancia del potere a suo favore.
Durante il suo regno l’Andalusia raggiunse la sua massima espansione, occupando tre quarti della penisola iberica e dominando importanti luoghi dell’Africa del nord.
«Nel X secolo, sotto l’egida dei califfi omayyadi ‘Abd al-Raḥmān III (912-961) e al-Ḥakam II, suo figlio e successore (961-976), al-Andalus, una società islamica, si trasforma nel potere regionale più importante del Mediterraneo occidentale. I segnali esterni di tale potere abbondano tanto nei testi scritti quanto nei testi materiali sopravvissuti al passare del tempo: nella nuova città fondata vicino a Cordova da ‘Abd al-Raḥmān III, Madīnat al-Zahra‘, i cui resti danno ancora un’idea del suo passato splendore, il califfo riceve le ambasciate dei re cristiani e dei signori magrebini. Il programma urbanistico di Madīnat al-Zahra‘ situava sul piano superiore delle tre terrazze su cui si estendeva la città la residenza del califfo, che aveva adottato il titolo califfale di al-Nāṣir li-dīn Allāh (“il vincitore per la religione di Dio”). Da quel luogo il califfo prendeva possesso simbolico dei livelli inferiori in cui erano collocati i servizi amministrativi, le zone commerciali e artigianali, la moschea e le aree residenziali della città»[35].

Gli scavi di Madinat-al-Zahra
Nel periodo califfale la Moschea di Cordova venne ulteriormente ingrandita. La III parte venne eretta da al-Ḥakam II (califfo dal 961 al 976) già nel periodo califfale. L’ultimo e più grande ampliamento fu quello di Almanzor (978-1002). Almanzor condusse diverse campagne contro gli stati confinanti, giungendo fino a saccheggiare Santiago di Campostela. Le porte della basilica di San Giacomo vennero asportate per divenire le porte della moschea di Cordoba e le campane di Santiago di Campostela vennero utilizzate come bracieri della stessa moschea.
6.4/ I periodo di Taifas (1031 – 1090)
Con la morte di Almanzor (si è già detto che con questo nome si indica correntemente Muhammad ibn Abī ‘Āmir, cioè al-Manṣūr bi-llāh, che fu prima visir del califfo Hisam II e poi califfo a sua volta), iniziò un periodo d’instabilità politica che sfociò in una guerra civile (fitna) e la caduta del Califfato Omayyade dell’Andalusia, con il suo rapido smembramento in una ventina di piccoli sultanati indipendenti e rivali tra loro, conosciuti come i Regni di Taifas (dall’arabo “taifa”: fazione o partito, con plurale spagnolo).
Della situazione approfittarono i regni cristiani del nord che conquistarono importanti territori, arrivando ad imporre il vassallaggio a diversi sultani.
6.5/ Dominazione degli Almoravidi (ca.1056 – 1147)
Davanti al pericolo, i musulmani di al-Andalus chiesero soccorso alla forte dinastia Almoràvide del nord Africa che riuscì a frenare l’avanzata cristiana e a unificare l’Andalusia sotto il proprio comando, sebbene i possedimenti comprendessero ormai a stento la metà della Penisola.
Almoravidi[36] è il nome di una dinastia berbera originaria della zona compresa fra l'Atlante, il Senegal e l'Oceano Atlantico. Nel sec. IX erano stati convertiti alla religione musulmana, che però seguivano molto tiepidamente e con scarsa conoscenza dei suoi dogmi e dei suoi riti. Secondo la tradizione, nell'anno 1036 uno dei loro capi, recandosi in pellegrinaggio alla Mecca, si persuase che il suo popolo era lontano dalla conoscenza delle prescrizioni religiose e che era necessario condurlo alla vera osservanza. Il luogo originario dove si radunarono i fedeli che intendevano portare tutti a questa piena osservanza fu un'isola del Senegal dove si costruì un ribāṭ, un edificio fortificato a scopo insieme di ritiro spirituale e di punto di partenza per la guerra contro gli infedeli. Per questo i fedeli vennero detti al-murābiṭūn, cioè gli abitanti del ribāṭ, da cui deriva il termine Almoravidi. Ne scaturì, attraverso il concetto profondamente sentito della guerra santa, un ente politico. Ad un certo momento ‛Abd Allāh ibn Yāsīn, il leader del ribāṭ, passò dalle pratiche ascetiche alla guerra, con l'intento di imporre la vera fede a tutti coloro che non intendevano accettarla con la persuasione. Iniziò così verso la metà del sec. XI una serie di fortunate azioni militari, che in breve portarono alla conquista di vasti territori, alla sottomissione di varie genti e quindi alla creazione di uno stato. Insomma, in breve venne conquistato tutto il Maghreb. Per avere una propria capitale, ‛Abd Allāh ibn Yāsīn nell'anno 1062 fondò la città di Marrākush (oggi in Marocco). Le lotte che si combattevano in Spagna fra il re di Castiglia e di León, Alfonso VI, e i principi musulmani, e l'attrazione che quella regione ha sempre esercitato sui marocchini, sospinsero gli Almoravidi in al-Andalus.
Infatti, Yūsuf ibn Tāshufīn, dopo una serie di lotte interne, prese il comando degli Almoravidi e, sollecitato da un'ambasceria di alcuni principi di al-Andalus, nel 1086 passò in Spagna e, sconfitto Alfonso nella grande battaglia di Zallāqah, si rese padrone di tutta la zona occupata dai musulmani, spossessandone gli emiri che imprudentemente lo avevano chiamato in loro soccorso. Alla metà del XII secolo l'impero almoravide era allora giunto al suo apogeo, e costituiva la maggiore potenza politica dell'Africa settentrionale.
Sorti con l'affermazione del più rigido islām, gli Almoravidi imposero dappertutto una stretta osservanza delle prescrizioni religiose, bandendo il lusso, l'uso del vino, gli strumenti musicali. I faqīh, dotti in teologia e diritto canonico, avevano larga parte nell'amministrazione dello stato al tempo di ‛Alī, e questo intervento ebbe conseguenze funeste per la cultura che fioriva rigogliosa col favore dei sovrani dei piccoli regni successori del califfato di Còrdova. Lo zelo ortodosso degli Almoravidi perseguitò sistematicamente ogni manifestazione della cultura mondana (numerosissimi furono i libri di scienze "profane" arsi pubblicamente), e nelle scienze religiose essi si attennero a quei sistemi, teologici e giuridici, i quali nell'interpretazione del Corano e della legge religiosa si fondavano esclusivamente sul senso letterale e sull'autorità della tradizione, bandendo l'esegesi razionalistica e allegoristica e, in genere, ogni intrusione della speculazione filosofica nel campo della fede. Alla tendenza di reazione ortodossa che distingue gli Almoravidi corrispose altresì il riconoscimento formale da essi prestato all'autorità del califfo 'abbāside di Baghdad, sicché si deve respingere la notizia, riferita da alcuni storici, che Yūsuf ibn Tāshufīn abbia assunto il titolo califfale: i suoi successori portarono invece il titolo di amīr al-muslimīn (capo del musulmani), con una distinzione voluta da quello di amīr al-mu'minīn (capo dei credenti), di pertinenza del solo califfo.
6.6/ II periodo di regni di Taifas tra il 1144 ed il 1172
Gli Almoràvidi in appena un secolo imposero una rigida amministrazione e un forte predominio sugli andalusi, generando un inevitabile malcontento e una sommossa locale, e finirono per essere sconfitti, generando quello che è stato chiamato il secondo periodo di Taifas, con regni nuovamente indipendenti in lotta fra di loro.
6.7/ Dominazione degli Almohadi (1121 - 1269)
Un’altra dinastia nordafricana, originaria delle montagne di Atlas, gli Almohadi[37] aveva già rovesciato il potere dei decadenti Almoràvidi in nord Africa e, passato il mare, invase l’Andalusia riuscendo a debellare i diversi regni di Taifas che si erano creati e unificando di nuovo la regione, estendendone ancora una volta le frontiere al nord. Gli Almohadi, che si credevano instauratori di un nuovo ordine nel mondo, governarono quasi un secolo e mezzo, apportando nuove idee, soprattutto in campo estetico e unificando come non mai al-Andalus con il Nord d’Africa.
Anche il nome di Almohàdi appartiene ad una dinastia berbera - si vede già solo da questo la costante dipendenza di al-Andalus dal Maghreb - che dominò dalla seconda metà del sec. XII fino alla prima metà del secolo successivo. La dinastia ebbe origine da un movimento religioso nato presso una tribù dell'Alto Atlante per opera di Muhammad ibn Tūmart, che vide nella forma assunta dall'Islam nel nord Africa del tempo gravi imperfezioni da emendare. Dopo aver studiato a Cordoba, tornò nella sua regione d’origine ed iniziò a contrastare gli Almoravidi. Presto Ibn Tūmart assunse il titolo di Mahdī (“ben guidato [da Dio]”, figura presente nell’escatologia islamica come precursore del ritorno di Gesù che, secondo la fede musulmana, non sarebbe morto in croce - la morte per crocifissione sarebbe un’invenzione dei cristiani, perché Dio salverebbe i suoi profeti giusti sottraendoli alla sofferenza - ma sarebbe vivo in cielo, essendo stato assunto in spirito e carne sollevato dal Monte degli Ulivi, dal luogo dove ora sorge la Moschea dell’Ascensione[38]).
I suoi seguaci amavano chiamarsi al-Muwaḥḥidūn (da cui Almohadi) cioè "i professanti l'unità di Dio", "i monoteisti", poiché accusavano gli altri musulmani loro compatrioti di essere "politeisti" a causa delle loro superstizioni e dei loro usi riprovevoli dal punto di vista dell'islamismo puro. Oltre che censurare i costumi e richiamare all'esatta osservanza delle prescrizioni religiose, Ibn Tūmart difese un complesso di idee riguardanti la teologia e il diritto, che si contrapponevano a quelle dominanti nel Maghreb, dove gli Almoravidi avevano imposto la scuola mālikita che respingeva la teologia speculativa e l'interpretazione allegorica o razionalistica dei passi antropomorfici del Corano.
Il Mahdī proclamò la necessità del ritorno allo studio del Corano e degli ḥadīth, quali fonti della religione, del rituale e del diritto, senza ritenersi vincolati in modo ferreo dal tardo svolgimento del sistema mālikita adottato dagli Almoravidi. Circa i passi coranici di cui si discuteva se dovessero essere interpretati allegoricamente o letteralmente, come quelli circa alcuni attributi di Dio, sosteneva che l'interpretazione letterale, l’unica accettata dai mālikiti, portava necessariamente all'antropomorfismo e quindi all'idolatria; difendeva, quindi, l'interpretazione allegorica e riteneva che tutto il popolo dovesse partecipare allo studio coranico. Da tali dottrine deduceva che i sovrani almoravidi erano fuori della retta via della fede e che contro di essi doveva essere proclamata la guerra santa.
Alla morte del Mahdī, nel 1128, salì al potere Abd al-Mu'min che assunse il titolo di khalīfah (successore) del Mahdī e l'epiteto, proprio dei califfi, di amīr al-mū' minīn (capo dei credenti), proponendosi così come unico rappresentante legittimo dell'ortodossia e dichiarando eretici e usurpatori i califfi Abbāsidi di Baghdād.
In breve tempo sconfisse gli Almoravidi sia in nord Africa che in Andalusia. L'impero così fondato ebbe ancora periodi di splendore dopo la morte di ‛Abd al-Mu'min (1163), coi due primi successori, cioè il figlio Abū Ya‛qūb Yūsuf (1163-1184) e il nipote Abū Yūsuf Ya‛qūb, detto al-Manṣūr (1184-1198), i quali, come il loro capostipite, s'intitolarono califfi.
Oltre che guerreggiare la loro guerra santa gli Almohadi protessero gli studî e le arti, costruendo molti splendidi edifici in Spagna e al Marocco.
A partire dal 1212, con la sconfitta nella battaglia a Las Navas di Tolosa di fronte alle truppe di Aragona, Castiglia e Navarra, gli Almohadi andarono indebolendosi fino alla loro scomparsa dalla penisola iberica. I regni cristiani avanzarono nelle loro conquiste e al-Andalus si ridusse a piccoli sultanati insediati in alcune città.
Nel Maghreb occidentale, invece, la caduta dell’impero almohade dette inizio al dominio merīnida.
6.8/ III periodo di Taifas (1228-1266) e Nàsridi (1232 – 1492)
Della frammentazione del potere Almohade prodottasi intorno all’anno 1228, in quella che è stata chiamata la seconda Fitna o Guerra Civile, i Nàsridi ricavarono il maggior profitto, rimanendo gli unici eredi dell’Islam dell’antico al-Andalus.
Il capostipite della nuova dinastia fu Muhammad I (Muhammad Ibn Yusuf Ibn Ahmad Ibn Nasr al-Ahmar), membro di una famiglia discendente di una tribù araba che governava nella città di Arjona, a nord di Jaen, che creò uno stato che si estendeva su tutta la costa mediterranea da Tarifa fin oltre Almerìa e all’interno, al nord fino a poco più della città di Jaen.
Egli, nel 1232, si alleò con Ferdinando III di Castiglia che avrebbe conquistato Cordoba nel 1236. Muhammad I, in particolare, promise il suo aiuto a Ferdinando III nella conquista di Siviglia che cadde nel 1248, in cambio di assicurazioni sul possesso della città di Granada e di una serie di accordi che includevano il suo riconoscimento come sovrano e la disponibilità dell’esercito musulmano. Tornando a Granada come vassallo del re di Castiglia, dopo la caduta appunto di Siviglia, l’imbarazzato Muhammad I ibn Nasr annunciò che «non v'è vincitore se non Dio» (lā ghālib illā Allāh), frase che compare come motto dei Nasridi in tutta l'Alhambra.
Grazie all’accordo con il regno di Castiglia e alla partecipazione alla conquista cristiana di Siviglia, Muhammad I poté governare anche in città come Malaga ed Almerìa. Questo gli procurò l’avversione dei suoi correligionari. A causa di ciò, dopo la morte di Ferdinando nel 1252 e gli attacchi dei suoi alleati cristiani, patteggiò con i Merìnidi del Nord d’Africa.
Con Muhammad I nacque così il regno Nàsride. La sua dinastia raccolse il testimone dell’Islam, riuscendo a mantenerlo ancora per due secoli e mezzo. Il sultanato nàsride di Granada (1232 – 1492) fu l’ultimo stato musulmano a sopravvivere alla conquista cristiana. Granada, stretta a sud dal sultanato del nord d’Africa e a nord dai regni cristiani, ambita da entrambi per 260 anni, chiese aiuto alternativamente ai cristiani, in cambio di gravosi tributi, o ai musulmani Merìnidi del Marocco, a seconda che il suo aggressore fosse l’uno o l'altro.
Nel regno nàsride continuarono però le lotte interne che, come si è visto, furono una costante nella storia di al-Andalus fino alla definitiva resa del 1492.
7/ Al-Andalus fu una società arabo-islamica e non multi-etnica
La società andalusa ebbe al suo interno minoranze ebraiche e cristiane sottoposte ad uno statuto di “protezione”, ma fu una società arabo-islamica a tutti gli effetti.
Come ha scritto Manuela Marín[39], «comunità cristiane e, in minor numero, ebree, formarono parte del “paesaggio” religioso di al-Ándalus per una gran parte della sua esistenza, anche se, a partire dall’XI secolo diminuirono progressivamente fino a quasi sparire nel periodo finale della sua storia. La loro esistenza si basava su una cornice legale elaborata all’interno dell’Islam atta a situare le precedenti religioni rivelate (cristianesimo ed ebraismo, le “genti del Libro”) su un piano socialmente inferiore al proprio ma che concedeva ai cristiani e agli ebrei la gestione interna delle proprie comunità e il mantenimento dei propri usi e costumi e delle leggi familiari e religiose. […] i musulmani potevano sposarsi con donne cristiane ed ebree (anche se cristiani ed ebrei non potevano sposare donne musulmane), il che favorì in molti casi la conversione all’Islam di cristiane sposate con musulmani. Si calcola che verso la metà del X secolo la società andalusì – o, per lo meno, quella urbana – era in maggior parte musulmana e che il processo di islamizzazione aveva raggiunto il proprio apogeo. Non bisogna dimenticare che nell’Islàm non esiste la conversione forzata. Le popolazioni dei luoghi incorporati al potere politico musulmano potevano conservare la propria religione, come fecero in al-Ándalus le comunità cristiane ed ebree di cui si ha notizia. Chi si convertì, fino a formare la maggioranza della popolazione, lo fece per una varietà di motivi non difficili da spiegare: dalla similitudine con le religioni preesistenti all’attrazione verso una credenza strettamente monoteista e ai vantaggi materiali e sociali che supponeva l’integrarsi al credo dei vincitori».
8/ I dhimmis, sottoposti a tassazione specifica a sottolineare lo statuto di concessione da parte dell’Islam per la permanenza di non musulmani all’interno della società
Nelle società islamiche tradizionali, e quindi anche in al-Andalus, cristiani ed ebrei potevano essere tali nelle loro chiese e sinagoghe, ma era loro interdetto di proporre la fede al di fuori, in ambienti pubblici. In pubblico e, quindi in tutti gli ambienti di lavoro e di svago, poteva essere professata solo la religione islamica - questa è ancora oggi la situazione di molte nazioni a maggioranza islamica.
Veniva agevolata ogni conversione dal cristianesimo o dall’ebraismo all’Islam, ma era interdetta la conversione di un musulmano al cristianesimo o all’ebraismo. Se una persona musulmana fosse divenuta cristiana era rea di morte. Ciò valeva anche per un cristiano passato per comodità all’Islam. Se avesse manifestato di voler ritornare alla fede cristiana, sarebbe stato apostata e, quindi, reo di morte.
Era interdetto alle donne musulmane di sposare uomini cristiani, altrimenti, per la preminenza della figura maschile sulla femminile, sarebbe nato il rischio del battesimo dei figli. Era agevolato, invece, ogni matrimonio di donne cristiane con uomini musulmani perché la discendenza sarebbe stata da quel momento in poi musulmana.
Insomma per libertà religiosa si intendeva – e talvolta si intende ancora oggi – la libertà di restare cristiani e di trasmettere la fede in famiglia, ma non di parlarne all’esterno della propria casa, non di poterla annunziare a chi non la conosce.
In particolare nelle società islamiche tradizionali e, quindi, anche in al-Andalus, cristiani ed ebrei potevano rimanere tali, ma in una condizione di subordinazione che era espressa dal loro statuto di dhimmi:
«Dhimma è l’espressione araba che designa appunto una “sorta di contratto, indefinitamente rinnovato, per il quale la comunità musulmana accorda l’ospitalità-protezione ai membri delle altre religioni rivelate, a condizione che essi stessi rispettino la dominazione dell’Islam. Si chiamano dhimmīs i beneficiari della dhimma e ahl al-dhimma o semplicemente dhimma tutta la loro collettività»[40].
La dhimma non era, comunque, una condizione personale, una specie di diritto/dovere individuale:
«La dhimma era un accordo – sia esso visto come patto o concessione – conferito alla comunità, non all’individuo; il dhimmī aveva uno status e un ruolo solo in quanto membro di una comunità riconosciuta come tale»[41].
Un elemento che contraddistingueva lo status di dhimmīs era l’onerosa tassazione detta Jizya:
«Jizya: imposta sulle persone prelevata sugli abitanti non-musulmani dei paesi musulmani. I giuristi l’hanno definita come una sorta di compensazione per la non-adozione dell’islam da parte di queste persone ed, in particolare, per la non partecipazione militare»[42].
Tale aggravamento degli oneri fiscali, conservava, però, soprattutto un valore simbolico che poteva essere più o meno rimarcato:
«Secondo l’interpretazione normale la jizya non era solo una tassa, ma anche una simbolica espressione di subordinazione. Il Corano e la tradizione usano spesso l’espressione dhull o dhilla (umiliazione o avvilimento) per indicare lo status che Dio ha assegnato a coloro che rifiutano Maometto, e in cui devono essere tenuti finché persistono in questo rifiuto»[43].
9/ La possibilità di ascendere in carriera per motivi di competenza
In Al-Andalus alcuni ambiti del sapere furono particolarmente coltivati. Innanzitutto, ovviamente, le scienze coraniche. Ma grande spazio ebbero anche quelle discipline che non entravano in conflitto con il Corano, come la medicina, l’astronomia, la matematica.
Si può dire anzi che, insieme alle società islamiche d’Egitto, della Mesopotamia e della Persia, l’Andalusia rappresenta uno dei momenti vertice della valorizzazione della ricerca culturale nella storia araba e persiana.
Il successivo predominio turco sul mondo arabo, più ancora che la Reconquista, depauperò in maniera decisiva la ricerca scientifica e letteraria araba. I cinque secoli di dominio ottomano fecero sì che il mondo arabo si presentasse, agli inizi del ‘900, con un notevole ritardo di sviluppo culturale rispetto agli altri popoli del bacino del Mediterraneo. Invece gli intellettuali di al-Andalus erano allo stesso livello culturale degli intellettuali greci e latini del loro tempo.
Proprio la cultura permetteva in al-Andalus un’ascesa sociale, come spiega Manuela Marín:
«Anche se sono esistiti arabi originari che si dedicarono allo studio e alla trasmissione di queste conoscenze specialistiche, una gran parte degli ulema andalusì della prima epoca discendevano da convertiti all’Islàm e provenivano da ambienti di commercianti ed artigiani. Sono questi “professionisti” delle scienze islamiche (studiosi del Corano, della tradizione profetica e del diritto) che rappresenteranno il maggior fattore di coesione nelle società urbane, giacché al loro ruolo di trasmettitori della scienza si aggiunge il fatto che essi incarnano l’ideale di uguaglianza così fortemente presente nell’ideologia islamica. Al di là delle origini etniche e delle genealogie illustri, gli uomini di scienza, gli ulema, rappresentano l’assunzione dell’identità musulmana come unica categoria sociale degna di venir tenuta in considerazione»[44].
La ricerca, però, non era libera quando andava a toccare questioni morali, teologiche o filosofiche, poiché in questi casi le autorità religiose vigilavano sull’ortodossia coranica delle pubblicazioni. Emblematico è il caso della figura filosoficamente più rilevante di al-Andalus, Averroè, pensatore di altissimo valore, i cui scritti furono condannati al rogo dalle autorità islamiche di al-Andalus e solo il fatto che egli fosse amico stretto del califfo di Cordoba gli permise di avere salva la vita e di non essere giustiziato insieme al rogo dei suoi scritti: la pena di morte venne commutata in esilio. Il suo pensiero sarà totalmente ignorato dalla tradizione filosofica musulmana successiva ed i suoi scritti sono giunti a noi solo perché tradotti in ebraico dai rabbini del tempo.
10/ Al-Andalus e la questione del rapporto fra ragione e rivelazione (e, quindi, della legittimità o meno della violenza o della libertà religiosa)
Proprio in uno dei periodi più integralista in al-Andalus, il periodo in cui la regione fu governata dagli Almohadi, sorsero i due massimi pensatori dell’Islam e dell’ebraismo andaluso (e forse mondiale): Averroè (1126-1198), di cui si è già fatto riferimento, e Maimonide (1138-1204). Entrambi furono costretti all’esilio da al-Andalus, come si vedrà, e sfuggirono ad una condanna a morte già sicura.
La loro riflessione, oltre che su temi diversissimi, si concentrò sul rapporto fra rivelazione divina ed uso della ragione.
Proprio a Cordoba un secolo prima era stata espressa da Ibn Hazm di Cordoba (994-1064) una delle posizioni più refrattarie al valore della ragione, perché la ricerca razionale sembrava potesse mettere in questione il primato che il Corano ha nella visione islamica della rivelazione.

Statua a Cordoba di Ibn Hazm
Come ricordò papa Benedetto XVI nella famosa lectio di Ratisbona sul tema del rapporto fra fede e ragione, «per la dottrina musulmana […] Dio è assolutamente trascendente. La sua volontà non è legata a nessuna delle nostre categorie, fosse anche quella della ragionevolezza[45] […] un'opera del noto islamista francese R. Arnaldez […] rileva che Ibn Hazm si spinge fino a dichiarare che Dio non sarebbe legato neanche dalla sua stessa parola e che niente lo obbligherebbe a rivelare a noi la verità. Se fosse sua volontà, l'uomo dovrebbe praticare anche l'idolatria[46]».
La tesi di Ibn Hamz di Cordoba sembra risuonare nel più tardivo Dialogo con un musulmano, scritto dall’imperatore Manuele II Paleologo di Costantinopoli negli anni 1394-1402 al tempo in cui già i Turchi stavano prendendo il predominio sugli arabi e stavano già assediando Costantinopoli con le loro armate – nel giro di qualche decennio avrebbero posto termine all’impero bizantino.
L’imperatore «in modo sorprendentemente brusco, brusco al punto da essere per noi inaccettabile [N.B. de Gli scritti: si ricordi che papa Benedetto XVI affermò più volte di non condividere l’affermazione di Manuele Paleologo su Maometto, ma si limitò a citarla poiché l’imperatore proprio in quella frase giungeva alla questione che a lui interessava e cioè se Dio potesse agire contro la ragione, ad esempio incitando alla violenza se la libertà e la ragione umana non riconoscevano la rivelazione divina], si rivolge al suo interlocutore semplicemente con la domanda centrale sul rapporto tra religione e violenza in genere, dicendo: "Mostrami pure ciò che Maometto ha portato di nuovo, e vi troverai soltanto delle cose cattive e disumane, come la sua direttiva di diffondere per mezzo della spada la fede che egli predicava"[47]. L'imperatore, dopo essersi pronunciato in modo così pesante, spiega poi minuziosamente le ragioni per cui la diffusione della fede mediante la violenza è cosa irragionevole. La violenza è in contrasto con la natura di Dio e la natura dell'anima. "Dio non si compiace del sangue - egli dice -, non agire secondo ragione, „σὺν λόγω”, è contrario alla natura di Dio. La fede è frutto dell'anima, non del corpo. Chi quindi vuole condurre qualcuno alla fede ha bisogno della capacità di parlare bene e di ragionare correttamente, non invece della violenza e della minaccia… Per convincere un'anima ragionevole non è necessario disporre né del proprio braccio, né di strumenti per colpire né di qualunque altro mezzo con cui si possa minacciare una persona di morte…"[48]».
Papa Benedetto XVI così sintetizzava la questione posta da Manuele Paleologo: «L'affermazione decisiva in questa argomentazione contro la conversione mediante la violenza è: non agire secondo ragione è contrario alla natura di Dio»[49].
Si potrebbe andare ancora oltre la questione posta da Benedetto XVI e dire con le parole predilette da papa Francesco (l’espressione è nostra): «Non agire secondo misericordia è contrario alla natura di Dio». Cioè si può essere certi che qualsiasi affermazione che attribuisca a Dio violenza e odio ed inciti ad usare violenza e odio contro altri sia falsa e idolatrica, perché contraria alla natura di Dio.
Ebbene, le discussioni filosofiche del XII secolo a Cordoba testimoniano che alcune personalità dell’epoca sentirono la stessa necessità di Manuele Paleologo II, di papa Benedetto XVI e di papa Francesco cioè quella di chiarire se l’uso della ragione fosse non solo lecito dinanzi alla fede, ma anzi meritorio, perché desiderato da Dio stesso.
Fernand Van Steenberghen[50] ricorda come la “dottrina della doppia verità” che fu rimproverata ad Averroè[51] non mirava a dichiarare falsa la teologia – ovviamente islamica – in favore della filosofia, ma piuttosto ad affermare diversi approcci convergenti alla verità, determinati da una riflessione sulle diverse possibilità culturali degli uomini: filosofi, teologi, semplici fedeli. Certo il suo approccio mirava ad affermare la dignità ed il rispetto che era dovuto alla ricerca filosofica da parte della teologia:
«Ibn Roschd (Averroè) […] consacra il trionfo di Aristotele presso gli arabi. Egli professa per il filosofo un’ammirazione vicina al culto. Oltre ai suoi scritti originali, egli ha lasciato tre serie di commenti sui libri di Aristotele, commenti che eserciteranno un influsso profondo sull’esegesi peripatetica presso i latini e che gli varranno il titolo di Commentator. Bisogna ricordare in primo luogo gli sforzi compiuti da Averroè per enunciare in termini precisi i rapporti tra la filosofia e la religione. Il problema si era posto da lungo tempo per i filosofi arabi, perché i teologi dell’Islam non avevano assistito senza reagire ai progressi della speculazione razionale. Averroè distingue tre specie di uomini: gli uomini di dimostrazione o gli spiriti scientifici: sono i filosofi; gli uomini di dialettica, che si contentano di argomenti probabili: sono i teologi; gli uomini di esortazione, che vivono d’immagini e di sentimenti: sono i semplici fedeli. Il Corano, che è la verità stessa poiché viene da Dio, si rivolge a tutti gli uomini, ma ogni categoria di anime deve comprenderlo e interpretarlo al suo proprio livello; i filosofi soli vanno al di là del senso esteriore, superficiale e simbolico, per penetrare il senso interiore e nascosto del testo. Bisogna mantenere la distinzione rigorosa di questi tre ordini e non mischiarli con metodi d’insegnamento ibridi. Averroè riesce così ad assicurare l’autonomia della filosofia, che rappresenta la verità assoluta e l’interpretazione sapiente del Corano; essa è indipendente dalla teologia, sapere nel quale domina l’interpretazione verosimile, e dalla fede popolare, che è al livello dei semplici».

Averroè dinanzi al rogo dei suoi libri perpetrato
dal califfo Al-Mansura Cordoba, nel film egiziano
Il destino del regista copto Youssef Chahine
Averroè venne però condannato per eresia e scampò alla morte solo perché amico del califfo Al-Mansur che lo condannò all’esilio. I suoi libri vennero bruciati dai giuristi musulmani e le sue ricerche non vennero più utilizzate dai successivi maestri di filosofia islamica. Le sue opere però vennero salvate grazie ai maestri ebrei e dalle traduzioni cristiane in latino:
«Se buona parte delle opere di Averroè ci sono pervenute, lo dobbiamo ai filosofi ebrei. Le copie arabe ne furono sempre assai rare, poiché l’accanimento con cui gli Almohadi perseguitarono la filosofia e i filosofi fu tale da impedirne la moltiplicazione e la diffusione. Invece i dotti rabbini della Spagna cristiana e della Provenza le raccolsero, ne redassero versioni in ebraico, anzi copie dell’originale arabo in caratteri ebraici. Quanto alle origini dell’averroismo latino, esse risalgono alle traduzioni latine dei commenti di Averroè ad Aristotele redatte da Michele Scoto, probabilmente durante il suo soggiorno a Palermo (1228-1235) in qualità di astrologo alla corte dell’imperatore Federico II di Hohenstaufen»[52].
Nell’Islam, invece, il suo pensiero sarà dimenticato.
Maimonide, grande maestro dell’ebraismo, visse in quegli anni sempre a Cordova. Anche lui scrisse sul rapporto fra rivelazione – questa volta ebraica – e fede. Ma anche Maimonide dovette sopportare una pesante persecuzione. Infatti, sotto gli Almohadi, Maimonide e la sua famiglia furono costretti ad una forma di cripto-giudaismo, cioè a fingersi musulmani. Non è del tutto chiaro se fecero un’esplicita professione di fede musulmana a ciò costretti perché altrimenti sarebbero stati uccisi, come vorrebbe l’unica fonte esplicita in merito. Gli storici tendono a rifiutare questa ipotesi perché Maimonide fu un personaggio talmente noto che i suoi nemici, se fosse stata vera la sua conversione, per quanto forzata, all’Islam, avrebbero potuto utilizzare il fatto per screditarlo[53]. Probabilmente, quindi, Maimonide ed i suoi si limitarono a fingere di non essere più ebrei e fuggirono prima a Fès (nell’odierno Marocco), poi ad Akko e successivamente in Egitto, dove Maimonide fu medico personale del qādī al-Fādil, luogotenente di Saladino – morì in Egitto e il suo corpo venne poi traslato a Tiberiade, dove ora riposa.

Pagine manoscritte di Maimonide in arabo scritto con lettere ebraiche
È comunque interessante, per comprendere quanto fosse duro il regime degli Almohadi, ricordare che Maimonide nei suoi trattati dichiarò che per un ebreo fingere di convertirsi all’Islam per evitare la morte era lecito. L’unico testimone della sua presunta conversione ricorda similmente, se il fatto dovesse essere vero, che lo stesso qādī d’Egitto, saputo della cosa, avrebbe salvato Maimonide, proprio perché contrario all’uso della violenza in campo religioso proprio degli Almohadi:
«Un giorno, quando era all’apice del potere e della notorietà al Cairo, Maimonide fu riconosciuto da un compatriota musulmano che sapeva della sua precedente conversione e lo denunciò per apostasia dall’Islam, richiedendo la pena di morte. Fortunatamente per Maimonide, il fatto fu risaputo dal qādī al-Fādil, suo amico e padrone. Il qādī sentenziò che, dato che la conversione di Maimonide all’islam, avvenuta a Cordova, era stata ottenuta con la forza, non era valida dal punto di vista legale e religioso, e il suo ritorno all’ebraismo non costituiva quindi apostasia»[54].
L'intensità delle tribolazioni sopportate dagli ebrei maghrebini è evidenziata anche da una terrificante lettera inviata da Fustat (in Egitto) scritta nel 1148 da Solomon ben Judah Hakohen di Sijilmasa, un profugo del Maghreb al padre - che commerciava a Mirbat, una città portuale della penisola araba sull’Oceano Indiano:
«Tu vorrai sapere notizie del Maghreb, che faranno bruciare le orecchie di tutti coloro che le sentiranno [...] [Abd al-Mu’min] conquistò Tlemcen e uccise tutti coloro che vi risiedevano eccetto quelli che trasgredirono [cioè, che si convertirono all'Islam] [...] Dopo essere entrato in città [Sijilmasa], radunò tutti gli ebrei ed offrì loro l'opzione di trasgredire [convertirsi all'Islam], e dopo sette mesi di pressioni, durante i quali essi [gli ebrei] pregarono e digiunarono, uno dei suoi ufficiali venne e richiese che trasgredissero. Loro si rifiutarono, e centocinquanta ebrei furono trucidati per l'unità del Nome di Dio [...] e il resto trasgredì. Il primo dei trasgressori fu Joseph ben ‘Imran, il dayyan di Sijilmasa. Per questo io mi lamento e piango... E le comunità del Maghreb furono tutte distrutte a causa dei loro peccati; nessuno rimase [...] che portasse un nome ebreo. Coloro che furono uccisi furono uccisi, e coloro che trasgredirono trasgredirono»[55].

Rovine dell'antico minareto di Tlemcen (oggi in Algeria)
dove vennerotrucidati tutti gli ebrei della città che
non si vollero convertire all'Islam
La drammaticità della situazione appare evidente anche dai diversi toni che lo stesso Maimonide utilizza a seconda degli interlocutori cui si rivolge. Se, abitualmente, è diplomatico o addirittura positivo nel descrivere i dominatori islamici del tempo, di tutt’altro genere è la sua famosa lettera scritta agli ebrei dello Yemen per metterli in guardia ed invitarli alla prudenza. Così ne scrive B. Lewis:
«Fu […] basandosi sull’esperienza personale, oltre che per motivi di preoccupazione religiosa, che ritenne opportuno inviare una lettera di consigli agli ebrei dello Yemen nel 1172, quando anch’essi stavano affrontando il problema della conversione forzata. Vi è uno stridente contrasto fra la lettera inviata da Maimonide al suo traduttore dall’ebraico in Europa, in cui parla della ricchezza della lingua araba e della superiorità della scienza araba, e la lettera inviata agli ebrei perseguitati nello Yemen, in cui esprime amaro rincrescimento per la condizione di avvilimento degli ebrei sotto il dominio musulmano: “Voi sapete, fratelli miei, che a causa dei nostri peccati Dio ci ha gettati in mezzo a questo popolo, la nazione di Ismaele, che ci perseguita duramente, e che escogita tutti i modi per farci del male e avvilirci… Nessuna nazione ha mai fatto tanto male a Israele. Nessuna l’ha superata nell’avvilirci e umiliarci. Nessuna è stata capace di ridurci nel modo in cui questa ha fatto”. Queste critiche, scritte senza dubbio sotto la spinta delle sue stesse esperienze in Spagna e in Marocco, risvegliate dalle recenti notizie provenienti dall’Arabia meridionale, non possono essere accettate come un’esatta immagine della situazione generale. La posizione stessa di Maimonide, il suo orgoglio e il suo successo come medico di corte e capo comunitario al Cairo, attestano il contrario. Ma le sue osservazioni contengono certamente qualche elemento di verità»[56].
Al di là della persecuzione che Maimonide dovette subire in quanto ebreo, è estremamente significativo che anch’egli si rivolse ai «perplessi», questa volta ebrei, nel Trattato sull'arte della logica e nella Guida dei perplessi (composta fra il 1180 e il 1190). Con il termine di “perplessi” si debbono intendere i filosofi di religione ebraica che avevano difficoltà a conciliare i loro studi basati sulla ragione con il racconto biblico. Maimonide invita a mantenersi fedeli ad Aristotele ed anche a leggere lo stesso Averroè: per quel che riguarda i passaggi più difficili della Sacra Scrittura che sembrerebbero contraddire la filosofia, Maimonide invita ad approfondire i testi con un’esegesi che utilizzi l’allegoria dove il senso letterale non sembra compatibile con la ragione stessa.
Nella Guida dei perplessi, Maimonide affronta fra l’altro le prove dell’esistenza di Dio, facendo in qualche modo da apri-strada alle prove tomiste. Tratta anche la questione se la creazione della materia implichi la sua creazione ex nihilo o se si possa ipotizzare che la materia sia creata ab aeterno.
Maimonide, che fu stimatissimo in vita e diverrà uno dei maestri classici più importanti dell’ebraismo, venne condannato da diversi maestri ebrei suoi contemporanei che vietarono la lettura delle sue opere - si pensi solo a Nahmanide, Moshe ben Naḥman, maestro ebraico anti-razionalista di Barcellona che lo scomunicò come eretico.
Maimonide, che scrisse in arabo le sue opere filosofiche, venne subito tradotto in ebraico e in latino, di modo che ebrei e cristiani poterono conoscere i suoi scritti.
Maimonide ed Averroè divennero così parte di un patrimonio comune, grazie alle traduzioni. Si deve ricordare, per comprendere come l’occidente latino guardasse con interesse alla ricerca di questi saggi vissuti in al-Andalus, che Dante pose Averroè, filosofo musulmano, nel Limbo, perché la sua ricerca razionale meritava tutto il rispetto e non poteva non essere un’opera meritoria agli occhi di Dio.
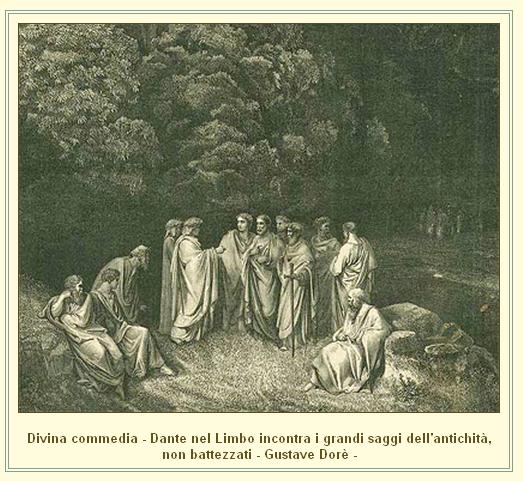
Dante incontra i grandi saggi non
battezzati, fra cui Averroè, nel Limbo
Già da questo solo fatto appare l’apertura della cultura cristiana medioevale al bene elaborato al di fuori della fede cristiana.
11/ Le traduzioni in arabo, latino, ebraico
Per comprendere il livello di cultura raggiunto da al-Andalus, ma anche per essere consapevoli dei suoi limiti culturali dinanzi alle aperture del contemporaneo mondo medioevale latino, è estremamente importante rendersi conto della circolazione di alcuni testi classici che fu ben superiore in al-Andalus rispetto a periodi anche successivi del mondo arabo.
Numerosi specialisti hanno affrontata la questione del passaggio dei testi classici greci all’Occidente medioevale, per la mediazione del mondo culturale andaluso. Gli studi hanno mostrato come l’Islam andaluso avesse interesse per ciò che lo aveva preceduto, in particolare per la cultura greca, soprattutto in campo medico, matematico, astronomico, logico. D’altro canto le traduzioni dall’arabo al latino hanno mostrato l’apertura simmetrica del mondo medioevale europeo ai portati della cultura araba ed ebraica del tempo.
Si tratta qui del rapporto con la cultura classica greca, perché il mondo islamico si è sempre disinteressato, invece, dell’ebraismo e non si è mai curato di conoscere l’ebraico per studiare l’Antico Testamento: l’Islam, infatti, rifiuta l’Antico Testamento, ritenendolo falsificato dagli ebrei, come del resto ritiene il Nuovo falsificato dai cristiani. Gli ebrei, invece, in quegli anni erano interessati alla cultura araba e scrivevano in arabo, anche perché erano obbligati a comunicare in arabo - si è già visto come molti scritti di Averroè si siano salvati solo perché tradotti in ebraico (e di lì in latino).
Van Steenberghen, in particolare ha studiato quali testi siano passati dalla cultura greca a quella araba e di lì a quella latina, dal momento che molti testi classici divennero noti solo man mano che il medioevo avanzava:
«Una buona parte dei Libri naturales [di Aristotele] è stata tradotta dall’arabo da Gerardo di Cremona († 1187): la Fisica, il Trattato della generazione, il Trattato del cielo, i libri I-II-III del Trattato delle meteore [...] Bisogna ancora menzionare qui la pseudoepigrafe aristotelica conosciuta sotto il nome di Liber de causis e chiamata anche Liber Aristotelis de expositione bonitatis purae. Questo opuscolo è formato di tesi estratte dalla Institutio theologiae di Proclo e accompagnate da dimostrazioni come i teoremi di Euclide[57]. [...] Per completare la nostra descrizione della biblioteca filosofica di cui dispongono i latini all’inizio del secolo XIII, dobbiamo menzionare la letteratura araba. Oltre a diversi scritti di matematica, astronomia, scienze naturali e medicina, tradotti nel corso dei secoli XI e XII, l’Occidente latino deve ai traduttori di Toledo una serie importante di opere filosofiche. Alle traduzioni già citate d’Aristotele e del Liber de causis, bisogna aggiungere: diversi scritti di Alkindi, tra cui il De intellectu; il De differentia inter animam et spiritum di Costa ben Luca; il De scientiis, il De ortu scientiarum e il De intellectu di Alfarabi, così come la sua Distinctio super librum Aristotelis de naturali auditu; il Liber definitionum e il De elementis dell’ebreo Isaac Israeli; il Fons vitae dell’ebreo Avecebron; infine e soprattutto parti considerevoli della grande enciclopedia filosofica di Avicenna, chiamata in arabo Libro della guarigione e conosciuta presso i latini sotto il nome di Sufficientia; parafrasi di Aristotele, questa enciclopedia ha largamente contribuito alla diffusione delle sue dottrine alla fine del secolo XII»[58].
Si vede così come il mondo andaluso sia stato aperto agli influssi greci classici, anche se non approfondì invece un’adeguata conoscenza del pensiero filosofico e teologico dei latini medioevali contemporanei, e come il medioevo latino abbia investito nella traduzione dei testi arabi per conoscere per loro tramite la filosofia e la scienza classica greca. Grande è quindi il debito della cultura medioevale occidentale agli intellettuali di al-Andalus.
Questa visione complessiva è ormai presentata anche nei manuali di filosofia delle superiori, come mostrano, ad esempio, Perone-Ferretti-Ciancio:
«All’inizio del XIII secolo la maggior parte delle opere di Aristotele erano ormai divenute accessibili ai latini. Dai tempi di Boezio si possedeva la cosiddetta logica vetus (Categorie, Interpretazione, Isagoge di Porfirio). La logica nova (Analitici, Topici, Confutazioni sofistiche) era divenuta accessibile solo nel XII secolo, assieme alla maggior parte dei cosiddetti Libri naturales (comprendenti la Fisica, le opere di scienze naturali, come Il Cielo, La Meteorologia, ecc., il trattato Sull’anima). La Metafisica e l’Etica a Nicomaco, conosciute almeno in parte già verso la fine del XII secolo, saranno conosciute integralmente più tardi nel corso del XIII secolo. Oltre le opere di Aristotele, all’inizio del secolo si conosceva anche la maggior parte della letteratura araba ed ebraica […], fra cui soprattutto l’enciclopedia filosofica di Avicenna, che presentandosi come una parafrasi delle dottrine di Aristotele, doveva particolarmente favorirne la conoscenza. I commenti ad Aristotele di Averroè saranno conosciuti dopo il 1230. La conoscenza delle opere di Aristotele e della letteratura aristotelica era stata resa tecnicamente possibile grazie ad una intensa opera di traduzioni sia dal greco che dall’arabo. Come già si è accennato nel capitolo precedente, […] in Spagna l’arcivescovo Raimondo di Toledo (1126-1151) aveva organizzato nella sua diocesi un vero e proprio collegio di traduttori dall’arabo, fra cui particolarmente famosi furono Domenico Gundisalvi e Giovanni Ispano. In Sicilia, un importante centro di traduzioni dal greco fu Catania, ove operò Enrico Aristippo (m. 1162). Alla corte di Federico Il, sempre in Sicilia, lavorerà Michele Scoto (1180-1235), già traduttore a Toledo e a cui si deve in gran parte la traduzione dall’arabo di Averroè. Numerose traduzioni greco-latine sono inoltre dovute all’iniziativa di Roberto Grossatesta, vescovo di Lincoln dal 1235 al 1253 e professore ad Oxford. Da ricordare infine Guglielmo di Moerbeke che, alla corte di Urbano IV, riprenderà, verso il 1260, la traduzione dal greco, o la revisione delle traduzioni esistenti, delle opere di Aristotele (fra cui la traduzione della Metafisica di cui si servirà San Tommaso per il suo commento)»[59].
Furono soprattutto gli intellettuali cristiani di Toledo, ormai riconquistata, che si specializzarono in traduzione di testi arabi ed ebraici in latino[60].
Rémi Brague, docente in Francia di Storia della filosofia araba, ha proposto un criterio per valutare il grado di apertura di una data cultura coniando l’espressione “secondarietà”: una cultura è aperta quando si riconosce “seconda” rispetto a qualcosa che l’ha preceduta e non pretende di cancellarlo, bensì lo sa valorizzare. Così spiega Brague, in riferimento al mondo romano che fu, a suo dire, insieme al cristianesimo, modello di “secondarietà”:
«L’espressione è forse maldestra, ma non ne ho trovata una migliore. Nel mio libro Europe. La voie romaine io la integro con altre formule, come quella della “cultura d’inserzione”, in opposizione alle “culture di digestione”. Intendo dire soltanto che il Nuovo Testamento viene dopo l’Antico Testamento, e i Romani dopo i Greci. Non solo riguardo al tempo, ma anche nel senso che quelli che venivano dopo percepivano la propria dipendenza rispetto a ciò che li precedeva, e che costituiva un modello. I Romani hanno fatto del bene e del male, come è capitato a tutte le civiltà. Ma occorre dar loro atto che si sono riconosciuti culturalmente inferiori in rapporto ai Greci, e hanno compreso che il loro compito storico era anche di diffondere una cultura che non era la loro. Essere “secondari” significa sapere che ciò che si trasmette non proviene da sé stessi, e che lo si possiede solo in modo fragile e provvisorio. Questo implica tra l’altro che nessuna costruzione storica ha niente di definitivo. Deve essere sempre rivista, corretta, riformata»[61].
A partire da questa sua peculiare visione così lo stesso R. Brague presenta sinteticamente l’apporto di al-Andalus – e più in generale del mondo arabo medioevale – alla trasmissione della cultura antica:
«Vi sono sempre stati molteplici miti orientalisti disponibili sul mercato, secondo le epoche. È prevalsa, talvolta, la tendenza a minimizzare il ruolo degli Arabi, il che è assai ingiusto. Oggigiorno, la bilancia pende nel senso opposto e alcuni – non tra gli studiosi seri, certamente, ma tra i rappresentanti dei media e i politici – vorrebbero farci credere che l’Europa debba tutto all’islam. La verità, come spesso accade, è a metà strada, in quello spazio grigio dove si possono porre delle questioni precise: chi? che cosa? dove? quando? come? perché? e dove non si ottengono che risposte parziali e sempre bisognose di essere corrette. In realtà, i testi tradotti in arabo nel IX secolo e poi dall’arabo nel XII-XIII secolo contengono grossomodo tutta la scienza greca (matematica, astronomia, medicina, botanica) ma solamente una parte della filosofia (Aristotele con dei commentari, oltre a parti di testi neoplatonici) e nulla della letteratura greca. Per avere i poeti epici, lirici e tragici, gli storici, Platone e i neoplatonici per intero, si dovette attendere ciò che giunse da Costantinopoli nel XV secolo. In quell’epoca Marsilio Ficino, a Firenze, tradusse in latino tutto Platone, tutto Plotino e anche il corpus di scritti attribuito a Ermete Trismegisto. Tornando alla Baghdad del IX secolo, riscontriamo che i traduttori erano quasi tutti cristiani, per il semplice motivo che essi erano spesso bilingui, o addirittura trilingui, parlando il greco, il siriaco e l’arabo. In compenso, i committenti delle traduzioni (come i medici e i “segretari”, ovvero i funzionari dell’amministrazione), che pagavano per questi lavori, appartenevano a tutte le confessioni, tra cui l’islam. Nel XII e nel XIII secolo gli abitanti della cristianità latina, che noi chiamiamo oggi “Europa”, tradussero Aristotele e il resto della sapienza greca, pressappoco contemporaneamente: lo fecero in parte dall’arabo, soprattutto in Spagna, ma anche direttamente dal greco, cosa che si verificò specialmente in Sicilia. Dopo questa impresa, occorre riconoscere che la sorgente un tempo attiva nell’Oriente arabo si è sostanzialmente prosciugata»[62].
La società di al-Andalus fu, insomma, fra tutte le società islamiche esistite nella storia, quella che più seppe fare tesoro del passato che la precedeva, coltivando nei suoi intellettuali una stima verso la cultura greca classica, anche se non si preoccupò minimamente di trasmettere al popolo tale tesoro. Molto meno al-Andalus seppe apprezzare il portato culturale teologico e filosofico ebraico o cristiano.
12/ L’assenza di un libero associazionismo popolare
L’egualitarismo che permetteva agli intellettuali di emergere in al-Andalus, al di là del ceppo delle famiglie di origine, aveva come controparte l’assenza di quelle istituzioni popolari, così frequenti invece nel mondo latino contemporaneo (si pensi solo ai Comuni o alle Corporazioni), di modo che la vita sociale era molto più determinata dal sovrano e dalla sua corte oltre che dagli ufficiali dell’esercito:
«Come contropartita alla fluidità di un sistema basato sul primato delle relazioni personali, si osserva in al-Ándalus l’assenza di formule associative o istituzionali che accolgano ed appoggino gli interessi dei gruppi sociali o che esercitino un ruolo di intermediario tra il potere del principe e i suoi sudditi»[63].
Con termini moderni, si potrebbe dire che la società di al-Andalus, come le altre società islamiche tradizionali, non riconobbe importanza al principio di sussidiarietà, e l’assenza di tale visione della società favorì i singoli, ma non l’emergere di istituzioni libere e creative, mentre si mantenne un controllo più stretto delle dinamiche sociali.
13/ La schiavitù come fenomeno abituale in al-Andalus
Un elemento che non deve essere dimenticato per comprendere la società di al-Andalus è il fatto che in essa era normale la schiavitù. Si è già visto che essa derivava in massima parte dalle campagne di guerra, poiché era abituale, a differenza di ciò che avveniva nei coevi regni latini, prendere come schiavi giovani, donne e bambini. Gli schiavi provenivano dai diversi regni d’Europa (sia dal nord della penisola iberica, sia dalle coste mediterranee), o dalla tratta di schiavi che li importava dall’Africa, ovviamente dalle tribù non islamizzate.
Così scrive la Marín:
«Per completare il variegato paesaggio umano di al-Ándalus non bisogna dimenticare di menzionare la presenza di schiavi di origine molto diversa ma soprattutto provenienti dall’Europa cristiana e dall’Africa subsahariana. Come nel resto dell’Islàm medievale, la schiavitù in al-Ándalus era fondamentalmente di tipo domestico o militare. Molte delle madri degli emiri o califfi andalusì furono schiave rumi (romane, cioè bizantine) o berbere; il lavoro domestico nelle case di famiglie benestanti dipendeva spesso da schiave galiziane o franche. Nell’alcázar califfale svolsero un ruolo importante gli schiavi eunuchi, che dominarono l’apparato amministrativo fino a intervenire direttamente nella successione della famiglia sovrana prendendo partito per l’uno o l’altro dei candidati al potere. Tutti gli schiavi di origine europea erano chiamati “slavi” per estensione e, come i berberi “nuovi”, crebbero notevolmente di numero durante la seconda metà del X secolo; anch’essi riuscirono, alla caduta del califfato, a conquistare il controllo di alcuni dei regni di taifas, specialmente nelle regioni orientali di al-Ándalus»[64].
Solo per fornire un riferimento concreto uno storico arabo del tempo, nel descrivere la costruzione di Madinat al-Zahrá’ (936-937) voluta da ‘Abd al-Rahmán III, così ricorda:
«Il numero di servitori maschi era di 13.750 e per essi erano necessarie quotidianamente 13.000 libbre di carne, senza contare uccelli e pesce. C’erano anche 3.350 (qualcuno dice 3.387) fra paggi, schiavi ed eunuchi»[65].
Da questo breve testo si vede il differente stato giuridico di chi è servitore, cioè stipendiato regolarmente, e di chi è schiavo o eunuco.
14/ I mozarabi
Prima di affrontare la questione dell’esplicita persecuzione dei cristiani in al-Andalus, è utile gettare uno sguardo alla progressiva diminuzione percentuale della loro presenza.
Secondo stime recenti degli studiosi – da prendere con cautela, dato che non abbiamo censimenti ufficiali dell’epoca – i cristiani erano ancora il 90% della popolazione nell’anno 750, per passare all’80% nell’850, al 50% un secolo dopo, al 20% agli inizi dell’XI secolo, al 10% intorno al 1150 agli inizi della dominazione Almohade[66]. Queste cifre, già da sole, danno un’idea di quanto la società di al-Andalus si identificasse con l’Islam e tendesse in tutti i modi a spingere alla conversione o alla fuga le minoranze.
Fra gli elementi che debbono essere considerati – si è già vista in dettaglio la situazione di Cordoba, Granada e Siviglia – è la quasi totale assenza di antichi luoghi cristiani di culto, poiché essi furono in diversi modi distrutti, alienati, sostituiti da moschee. Insieme alla progressiva diminuzione della popolazione cristiana questa assenza aiuta ad intuire qualcosa della complessità del problema della presenza cristiana in al-Andalus: la scomparsa di cattedrali, battisteri, monasteri, diaconie e luoghi di culto, che pure dovevano essere esistiti prima dell’invasione araba, è impressionante.
Mentre tutta l’attenzione abituale degli storici è centrata sulle tensioni che si ebbero fra i regni cristiani mai espugnati dalla conquista araba e le popolazioni stesse dei musulmani conquistatori, poca attenzione viene riservata al gruppo dei cristiani che sopravvissero all’interno dei territori conquistati.
I cristiani che vissero sotto il dominio di al-Andalus sono chiamati “mozarabi”. Il termine è la trascrizione della parola araba mustarab («arabizzato») ed è più recente del fatto stesso: infatti, il termine appare solo all'inizio del XII secolo, dopo la conquista di Toledo, negli atti del potere regio della Castiglia che riconoscevano l'originalità giuridica di questa minoranza cristiana, erede dei visigoti e influenzata da costumi orientali a motivo del contatto secolare con l'islam.
Si è già visto che la loro condizione fu quella di comunità che aveva una libertà interna, ma che all’esterno aveva invece una libertà limitata, determinata dal divieto di predicare, dall’impossibilità di accogliere eventuali persone non battezzate interessate alla fede, dal divieto di sposare donne musulmane, dall’obbligo di versare una considerevole tassa a motivo del non essere musulmani in una società musulmana.
Nonostante questa condizione di sottomissione, la presenza dei cristiani mozarabi, anche se passarono dall’essere la totalità della popolazione al divenire il 10% alla metà del XII secolo, non venne mai meno in al-Andalus. I mozarabi elaborarono pian piano una loro liturgia, iniziarono a produrre testi in arabo, elaborarono un proprio modo di edificare luoghi di culto.
J. Fontaine[67], grande studioso della cultura mozarabica, così presenta il paradosso dei mozarabi:
«Tra i manoscritti e le opere d’arte, che costituiscono per noi la testimonianza di una cultura mozarabica, la maggior parte, se non la totalità, si trovano oggi conservati in province che, al momento in cui gli edifici religiosi furono costruiti e i manoscritti copiati o miniati, si trovavano al di fuori delle regioni della penisola ancora sottomesse al potere islamico». Come a dire che quella cultura poté esprimersi all’esterno solo dopo che si liberò dal giogo di al-Andalus.
Pochissimo è rimasto degli edifici ecclesiali mozarabi nelle zone sotto la dominazione dell’Islam andaluso. Si sono conservate solo la Chiesa di Santa Maria di Melque vicino a Puebla de Montalban, in provincia di Toledo, e la Chiesa rupestre di Bobastro, Mesas de Villaverde, nelle montagne vicino Malaga.
Gli edifici mozarabi nei territori della Reconquista possono essere, invece, suddivisi in quattro differenti zone[68]: la mozarabia leonese (nella quale spicca il famoso complesso di San Miguel de Escalada oltre a Santiago de Peñalba, San Cebrián de Mazote e Santa Maria di Wamba), quella galiziana e lusitana (con San Miguel de Celanova e San Pedro de Laurosa), la zona aragonese-catalana (con la cripta di San Juan de la Peña, le chiese di Santa Maria de Marquet e di Sant Julián de Boada ed il monastero di Sant Miquel de Cuixà), la zona centrale o Castigliana (con San Baudelio de Berlanga e con la Torre di doña Urraca).

San Baudelio de Berlanga
A titolo esemplificativo della situazione si può leggere il testo dell’iscrizione di rifondazione della chiesa di San Miguel de Escalada, iscrizione attualmente scomparsa ma ancora leggibile nel 1784 quando fu trascritta da Manuel Risco, che così recitava:
«Questo luogo, dedicato fin dall’antichità all’arcangelo Michele e eretto come piccolo edificio, prossimo a cadere in rovina, rimase a lungo in condizioni disastrose, finché l’abate Alfonso, venendo con i suoi compagni da Cordoba, loro patria, sollevò la casa che era in rovina ai tempi del potente e serenissimo principe Alfonso. Crescendo il numero dei monaci, eresse di nuovo questo bel tempio, con lavoro ammirabile [... ] Senza opposizione di alcuna autorità e senza oppressione del popolo, ma per la costante vigilanza dell’abate Alfonso e dei fratelli, questi lavori furono conclusi in dodici mesi, quando già regnava Garcia e la regina Mumadona. Nell’anno 951 (N.d.T. con gli adattamenti al nostro calendario, l’anno di consacrazione è così il 913). Fu consacrato per mano del vescovo Genadio il dodici delle calende di dicembre».

San Miguel de Escalada
L’iscrizione permette di intravedere la condizione di fuggitivi da Cordova dei costruttori della Chiesa di San Miguel de Escalada. Il complesso di San Miguel è noto anche per essere stato la sede di uno degli scriptorium più importanti della cultura mozarabica, quello nel quale Magius, nell’anno 950, illustrò il famoso Beato (cioè una copia dei Commentarii dell’Apocalisse di S. Giovanni, scritto dall’autore noto come Beato di Liebana, nel 786).

Il male viene incatenato (Magius che illustra il Beato di Liebana)
I mozarabi ebbero una loro liturgia che si sviluppò con caratteristiche proprie anche per le difficoltà a comunicare con l’esterno. Tale liturgia venne usata ufficialmente nella penisola iberica fino alla seconda metà del sec. XI, quando si impose la liturgia romana. Venne, però, conservata nei secoli seguenti, dal XII al XV, in alcune parrocchie di Toledo e, dal sec. XVI ai nostri giorni, nella cappella del “Corpus Christi” della primaziale di Toledo, grazie all’opera intelligente del cardinal Francisco Ximenes de Cisneros che volle preservarla dalla scomparsa istituendo un apposito capitolo che ne proseguisse la celebrazione.

La cappella mozarabica del Corpus Christi è quella
sulla destra della facciata con la sua piccola cupola
«Si può affermare sicuramente che la liturgia mozarabica nel suo insieme non è di origine orientale, ma occidentale, e in essa il carattere generale e i numerosi riti furono importati dall’Italia, probabilmente da Roma, dai primi predicatori del Vangelo in Spagna: il resto è opera dei vescovi, dottori, letterati, musici della penisola (cf. M. Férotin, Liber ordinum...). Liturgia quindi nettamente di origine latina, precisamente romana nei suoi inizi, però sviluppata specialmente dal sec. VI (in cui l’unità politica, attuata dal re Leovigildo diede impulso all’unità liturgica, con la conversione di suo figlio Recaredo alla fede cattolica [587]) fino all’inizio del sec. VII nell’ambiente patrio senza altre influenze straniere. A plasmare questa unità furono i padri dell’epoca visigotica, fra cui maggiormente benemeriti: Pietro di Lerida (secc. V-VI), San Leandro di Siviglia (morto nel 599), Giovanni, vescovo di Saragozza (morto nel 631). Meritano speciale menzione gli arcivescovi di Toledo che con grande impegno lavorarono non solo nel restaurare la liturgia, ma anche nell’arricchirla di nuovi elementi: Eugenio (morto nel 657), che ebbe un interesse speciale per il canto che da lui si chiamò canto eugeniano; Sant’Ildefonso (morto nel 669), autore di molte messe e di alcuni cantici in onore di San Leocadia di Toledo; San Giuliano (morto nel 690), che compose inni ed un Messale»[69].
15/ Gli episodi di esplicita persecuzione dei cristiani in al-Andalus e i muladiès
Se generalmente i mozarabi vissero in una società che conferiva loro diritto all’esistenza, purché avessero pagato la tassa dovuta ai non musulmani e rispettato i limiti imposti alla loro libertà, la storia di al-Andalus ebbe anche momenti di esplicita persecuzione con l’uccisione di numerosi martiri. In alcuni casi fu sufficiente il fatto che le persone in questione fossero cristiane, in altri casi il crimine di cui furono accusati fu quello di lesa religione (cioè essendo cristiani vennero accusati di offendere con la loro fede verità coraniche) o di apostasia (erano cioè cristiani fattisi musulmani per convenienza che ad un certo punto decidevano di manifestare la fede cristiana che avevano custodito in segreto con la conseguenza di essere condannati a morte perché musulmani apostati).
Sono noti i casi[70] di Eurosia, uccisa nel 714 a Jaca, nei Pirenei aragonesi, dei fratelli Valentino ed Engrazia, uccisi a Sepulveda in Castiglia, del vescovo Vittore, martirizzato nel 743 a Baeza insieme ad Alessandro e Mariano, dell’eremita Daniele ucciso a Gerona all’inizio del IX secolo, dei fratelli Adolfo e Giovanni di Siviglia, nati dal matrimonio tra un musulmano ed una cristiana, uccisi nel 822.
Un gruppo di martiri che, con la sua testimonianza, permette di cogliere le vicende di quei tempi da una prospettiva peculiare fu quello dei cosiddetti “martiri volontari” di Cordoba, tra l’851 e l’859. Le fonti antiche, in particolare gli scritti di Sant’Eulogio, che fu uno degli ultimi di questa schiera di martiri, e di Paolo Alvaro, descrivono in dettaglio queste storie.
Dinanzi al lento recedere della presenza cristiana, che era sì tollerata, ma a condizione che fosse interdetta ogni diffusione del vangelo, si affermò presso una schiera di monaci, sacerdoti, vergini e laici la convinzione che fosse necessario tornare ad annunciare Cristo. Alcuni di loro, cristiani che mai avevano defezionato, entrarono nella Mezquita di Cordoba e proclamarono la verità del cristianesimo e l’errore dell’Islam.
Altri, invece, che si erano convertiti formalmente all’Islam per convenienza o paura, ma avevano continuato a vivere un cripto-cristianesimo, si presentarono nella stessa moschea o alla presenza delle autorità, dichiarando di essere cristiani. Una cinquantina di persone, nel corso di quegli anni, furono così decapitate ed i loro corpi bruciati e le ceneri disperse nel fiume Guadalquivir, per evitare che i cristiani venerassero le loro reliquie. L’accusa rivolta loro fu quella di apostasia o lesa religione. Ciò avvenne sotto gli emiri ‘Abdul-Rahman II e Muhammad I. Nell’onomastica odierna di Cordoba il nome del Campo de los martires ricorda il luogo di martirio di questi cristiani cordobensi. All’interno della Catedral-Mezquita-Catedral, nelle sedute del livello inferiore del Coro della Cappella maggiore, sono intagliati in legno i 46 martiri mozarabi di Cordoba.

Santa Digna raffigurata nel coro della cattedrale
di Cordoba con la scena del suo martirio sullo sfondo

Sant'Anastasio raffigurato nel coro della cattedrale
di Cordoba con la scena del suo martirio sullo sfondo
«È certamente vero che il movimento dei martiri voleva lottare contro il progredire della lingua araba e della fede musulmana tra i cristiani, un fenomeno che spesso divideva le famiglie e che talvolta obbligava le giovani a convertirsi alla nuova religione solo perché i genitori o fratelli di queste si erano convertiti. Non sembra vero, invece, che il movimento sia rimasto un fenomeno marginale. Ne è prova la forte corrente migratoria mozarabica verso i regni cristiani del Nord, che contribuì notevolmente al ripopolamento del bacino del Duero durante il regno di Ordono I (850-866) e di Alfonso III (866-910); e soprattutto il Calendario di Cordova, redatto in arabo dal vescovo Recemundo nel 961, dimostra che molti dei martiri erano ancora festeggiati nella comunità mozarabica un secolo dopo il loro sacrificio»[71].
Dopo il gruppo dei martiri di Cordoba, si registrano ancora, fra le vicende più note, sotto ‘Abdul-Rahman III nel 923 il martirio di Eugenia, nel 925 di Pelagio, tredicenne, nel 931, di Argentea, figlia di Bin Hafsun, e di Vulfura.
Nel 953 vennero martirizzati i duecento benedettini del monastero di San Pedro de Cardeña, vicino Burgos. Sant’Antonio da Padova decise di passare dall’ordine agostiniano a quello francescano vedendo i corpi dei primi cinque martiri francescani in Marocco riportati in Portogallo (nel 1220 a Coimbra).
L’esempio di questi martiri spinse, nel 1227, altri 7 francescani in Marocco che subirono a loro volta il martirio. Nel 1228 altri due francescani furono martirizzati a Valencia. È il difficile periodo successivo alla presa del potere della dinastia degli Almohadi che, come si è visto, soppiantarono l’altra dinastia berbera, ugualmente fondamentalista, degli Almoravidi. È negli anni della dinastia Almohade che si assiste alla scomparsa di un cristianesimo autoctono in Africa del Nord. Le ultime testimonianze di una gerarchia locale risalgono al 1049 per la Libia, al 1091 per la Tunisia, al 1150 per l’Algeria. Nel 1159 gli Almohadi costrinsero gli ultimi cristiani all’esilio o all’apostasia. Così Al-Ghazali commenta questo modo di procedere:
«Certamente non è bene che si eserciti una pressione in materia di religione, ma bisogna riconoscere che la spada o la frusta sono talvolta più utili della filosofia o della convinzione. E, se la prima generazione non aderisce all’Islam che con la lingua, la seconda aderisce anche con il cuore e la terza si considererà come musulmana da sempre».
Uccisi con l’accusa di apostasia furono poi Bernardo di Alzira con le sorelle Zoraida e Zaida. Martiri furono ancora il mercedario Pietro Pascal nel 1300, i francescani Giovanni di Cetina e Pietro di Dueñas (i beati Beatos Juan De Cetina e Pedro De Dueñas), decapitati nel patio dell’Alhambra di Granada, appena costruito, nel 1397 per mano dello stesso re Mohamed VII, detto nelle fonti cristiane Abenbalba.
Anche il catalano Raimondo Lullo, originario di Majorca, figlio di uno dei capi militari che strapparono l’isola ai musulmani, entrato nel Terz’Ordine francescano ed avendo dedicato la sua vita agli studi islamici per prepararsi all’evangelizzazione in terra islamica, fu lapidato al suo secondo viaggio a Bougie/Béjaïa, nell’attuale Algeria, e morì in seguito alle ferite, mentre veniva ricondotto a Majorca.
Come si è detto, la pressione via via crescente per una conversione dei cristiani all’Islam fece crescere le conversioni. Iniziò così, ben prima dei conversos e dei moriscos, la difficile storia dei “cristiani nascosti”. I convertiti dal cristianesimo all’Islam erano detti muladíes (il singolare, in spagnolo, è muladí). Alcune famiglie di muladíes persero via via consapevolezza del loro passato di fede cristiana, in altre, invece, questo fatto divenne motivo di ribellione non appena vi fu la possibilità.
Così ne parla Fontaine:
«A partire dalla seconda metà dell’VIII secolo si verificano da parte degli iberici del sud conversioni in massa, spontanee o forzate, alla religione dei dominatori. furono poi gli autori delle grandi rivolte del IX secolo. Visti con la stessa diffidenza dai cristiani e dai musulmani di ceppo islamico, finirono per aggravare l’ostilità nei confronti dei cristiani da parte dei teologi ortodossi dell’Islam andaluso: i faqihs, la cui importanza crebbe con i successori di Abd-er-Rahman I. Questa tendenza si rafforzò durante il regno del suo successore Hisham I (796-822) seguace dell’ortodossia rigorista e, per così dire, integralista, della dottrina malikita, diffusa precedentemente dal signore di Medina, Malik ben Anas, morto nel 796.
Si registra in questo periodo la repressione sanguinosa di diverse rivolte, la più nota delle quali fu quella che mise a ferro e a fuoco un intero sobborgo di Cordova nell’818, ma ci furono anche eventi come la tremenda “giornata del fossato”, nella quale un muladì, nominato dall’emiro governatore di Toledo, convocò e fece giustiziare per tradimento decine di notabili dell’antica capitale visigotica, che si era spesso ribellata»[72].
16/ La suddivisione degli spazi nell’Alhambra di Granada e il ruolo della donna in al-Andalus
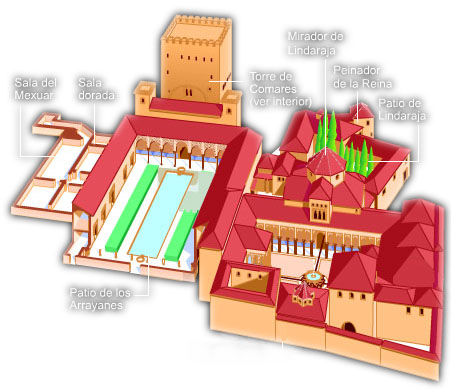
Immagine che mostra le grandi partizioni dell'Alhambra.
La zona riservata alle donne dell'harem è quella
sulla destra intorno al patio de los Leones
L’Alhambra con il Generalife permette di rendersi conto di quale livello di raffinatezza e di lusso avesse raggiunto la civiltà di al-Andalus. Certo a nessuno dei sudditi era concesso tale livello di vita, ma si comprende come i sultani, invece, sapessero apprezzare la bellezza. L’Alhambra colpisce per la sua armonia architettonica e per il suo inserimento nel creato – si pensi solo al mormorio delle acque che accompagnava la vita e alla cura della vegetazione nel Generalife (dall’arabo Jannat al-'Arif - Giardino dell'Architetto, dove chiaramente l’architetto è il Creatore).
Il palazzo si articolava per una serie di ambienti sempre più privati: in particolare è evidente una triplice macro-struttura.
La prima zona, che comprendeva il Mexuar, cioè la Sala del Consiglio, con l’annessa piccola moschea sul fondo, ed il Cuarto dorado, era dedicata ai pubblici affari politici e giudiziari. Subito prima di esso vi era la Madrasa, cioè il luogo per gli studi coranici.
La seconda zona era quella nella quale il sultano riceveva le personalità illustri. È il complesso che si distribuisce intorno al patio de los Arrayanes. In fondo al patio, sul lato corto, stava la sala del trono, oggi detta sala de los Embajadores, preceduta dalla sala de la Barca, dalla parola araba baraqah (benedizione) che si ripete nella decorazione, che era come un vestibolo prima della sala del trono.
La terza zona è quella che si potrebbe chiamare dell’harem, dove nessuna personalità esterna era ammessa, poiché vi si trovavano le stanze del re e le diverse camere dell’harem con le spose e le concubine, oltre che gli appartamenti degli eunuchi. È il complesso che si distribuisce intorno al patio de los Leones.
La disposizione del palazzo aiuta a comprendere come fosse particolare in al-Andalus, rispetto al medioevo latino, il ruolo della donna. L’esistenza della poligamia richiedeva un ambiente apposito per la convivenza delle donne che non potevano uscire dai loro ambienti se non accompagnate e per determinate circostanze.
Proprio l’esistenza di questa zona riservata al re, alle sue donne (alcune delle quali cristiane o convertite dal cristianesimo) e agli eunuchi permette di comprendere come sia possibile che nella sala sul lato corto del patio de los Leones, la sala detta de los Reyes, esistesse una decorazione con immagini umane, di per sé vietata dall’Islam[73].
Le pitture che ornano i soffitti sono su pelli, probabilmente perché fosse possibile la rimozione se se ne fosse determinata la necessità.
Le pitture della sala de los Reyes sono testimonianza diretta di qualcosa che è nota anche da testi letterari, come gli scritti di Ibn Jaldun. Mentre l’ortodossia ufficiale dell’Islam di allora proibiva - come tuttora avviene - non solo la rappresentazione di Dio, ma anche della figura umana, i tre soffitti affrescati all’interno della sala de los Reyes sono segno di quegli interscambi e contaminazioni che allora avvenivano fra la cultura cristiana e quella musulmana.
Nel primo dei dipinti si vede la caccia del cinghiale e dell’orso, insieme alla cattura di un leone, con un cacciatore cristiano ed uno musulmano che desiderano conquistare il cuore di una donna; appare anche la Fonte della giovinezza.
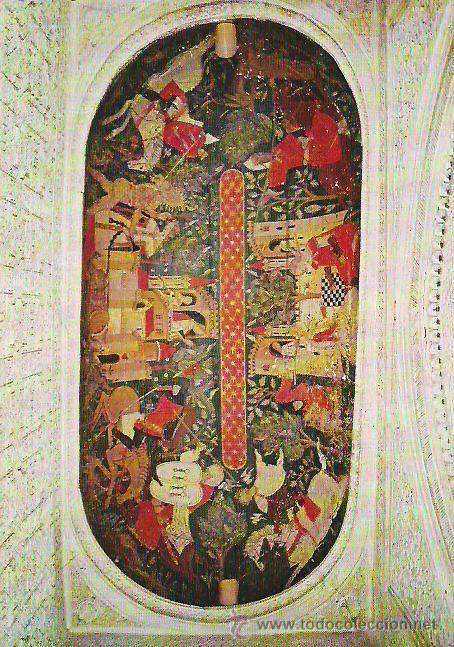
Dipinti con lotte fra cavalieri
musulmani e cavalieri cristiani
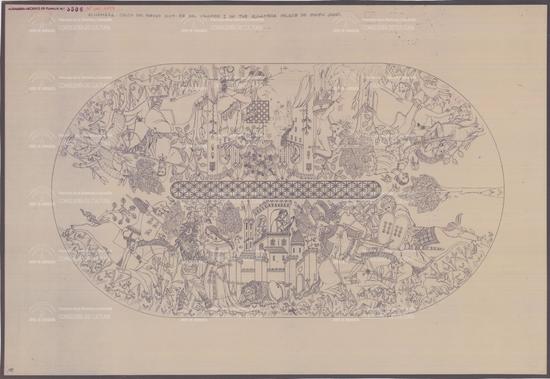
Dipinti con lotte fra cavalieri musulmani e
cavalieri cristiani (con elaborazione grafica)
Nel secondo si vede il castello dell’Amore, con nuovi episodi di caccia e con un uomo che gioca con una scacchiera, il salvataggio di una donzella e un cavaliere musulmano che uccide un cavaliere cristiano.

Dipinto con il castello dell'amore

Dipinto con il castello dell'amore
(con elaborazione grafica)
Nel terzo si vedono 10 dignitari islamici, forse i sovrani granadini in successione.

Dipinto dei re
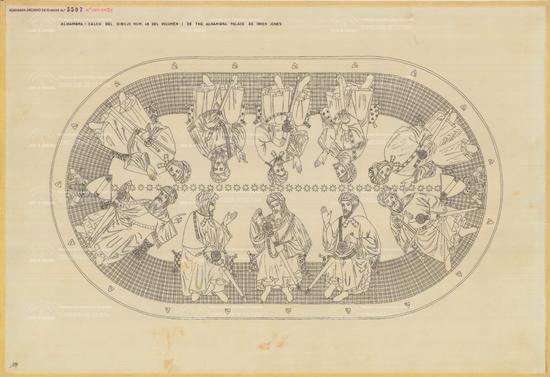
Dipinto dei re (con elaborazione grafica)
Le pitture dell’Alhambra mostrano come l’utilizzo della raffigurazione della persona umana, che già era conosciuta nell’Islam omayyade (vedi i castelli nel deserto dell’odierna Giordania) riappaia anche in altri momenti della storia islamica. Una analoga contaminazione si trova nel soffitto ligneo del Palazzo dei Normanni di Palermo, dove sono tuttora conservate le raffigurazioni di personaggi della corte palermitana araba.
17/ Le lotte intestine che indebolirono al-Andalus lungo tutta la sua storia ed, in particolare, le tensioni fra arabi e berberi
La differenza etnica e religiosa marcava l’identità dei gruppi dirigenti:
«Sia l’origine etnica, sia l’affiliazione religiosa erano elementi basici per la definizione dell’identità individuale o collettiva in al-Ándalus ed è perciò necessario dedicare a questo aspetto un’attenzione speciale. L’Islàm, come religione, fu rivelato agli arabi e in lingua araba, il che conferì a questo popolo e al suo modo di esprimersi un prestigio che lo situava al di sopra del resto delle popolazioni che progressivamente si convertirono a esso. In al-Ándalus i gruppi di origine araba non smisero mai di essere una minoranza rispetto al complesso della popolazione ma godettero sempre di questo prestigio aggiunto dovuto alla propria origine e, almeno nella prima epoca della storia andalusì, esercitarono un controllo praticamente totale sul potere politico, amministrativo e militare»[74].
A fianco degli arabi, che erano una ristretta minoranza, emerse il gruppo etnico dei berberi. Molte delle lotte intestine che, a scadenze diverse, travagliarono al-Ándalus ebbero come motivo remoto anche questa differenza originaria – si pensi, soprattutto, agli Almoravidi e agli Almohadi che, provenendo dal nord Africa, compirono una vera e propria opera di conquista militare - e come si è visto di guerra santa - contro le popolazioni musulmane già presenti in al-Andalus. Nella stessa Granada la bipolarità della struttura cittadina che venne strutturandosi da un lato sulla collina di Elvira (ribattezzata in Albaycin), dall’altro sulla collina dell’Alhambra, fece sì che la seconda divenisse, di volta in volta, rifugio dei difensori locali arabo-andalusi o degli invasori nordafricani maghrebini. Al-Andalus, insomma, fu, per ragioni geografiche, sempre fortemente legato ai gruppi di potere che si avvicendavano nel Maghreb.
Manuela Marín così spiega:
«Con l’Islam i contingenti berberi giunsero in al-Ándalus in numero molto superiore a quello degli arabi e, anche se non si tratta di un processo ben documentato, molti altri dovettero giungere a stabilirsi nella penisola, non sempre come guerrieri o soldati. I berberi erano già musulmani e lottavano in nome dell’Islam. Quelli che si stabilirono nelle città si arabizzarono rapidamente e, stando ai dati disponibili, si incorporarono con facilità alle élites governanti [...] Tra le famiglie berbere più importanti ci fu chi mantenne la nisba tribale berbera ma ci furono anche casi di adozione di segni onomastici arabi, come accadde con la popolazione convertita di origine locale. Ciò significa che il prestigio genealogico di cui godevano gli arabi, in quanto rettori della società, era superiore a quello dei berberi, e ciò si traduce nella perdita o nell’attenuazione dei segni onomastici di questi ultimi. Nella seconda metà del X secolo nuovi contingenti berberi si integrarono nell’esercito califfale. Questi berberi, a volte qualificati come “nuovi”, svolsero un ruolo decisivo durante il periodo di guerre civili seguito alla scomparsa del califfato; nell’XI secolo conquistarono il potere in alcuni dei regni di taifas in cui si suddivise al-Ándalus, come in quello di Granada. Poco arabizzati in alcuni casi, e con una forte permanenza delle proprie strutture tribali e sociali, questi nuovi berberi produssero un rinnovamento dei gruppi dirigenti andalusì, il che provocò una lunga serie di confitti sia con le popolazioni su cui dominarono, sia con altri poteri locali»[75].
La preminenza dell’etnia araba generava un desiderio di maturare le condizioni per appartenervi:
«Non bisogna dimenticare che per la popolazione non araba imparentarsi con l’élite araba era un mezzo di ascesa sociale e di integrazione con i gruppi di potere. D’altro canto, bisogna tenere in considerazione che la trasmissione genealogica, nel sistema di parentela arabo, è esclusivamente patrilineare. Cioè si è arabi al cento per cento se si è figli di un uomo arabo, senza che l’etnia della madre venga presa in considerazione. Per questo l’appartenenza alla propria parentela si mantiene anche se si produce una mescolanza con popolazioni di origine non araba»[76].
Ma, al di là, della differenza etnica fra arabi e berberi, al-Andalus fu sempre travagliata da scontri di potere continui con frequenti vendette politiche e rovesciamenti di potere, cosa che, ovviamente, favorì anche la Reconquista.
18/ La fine del regno nasride di Granada

I regni di Castilla e Leon nel 1360
Il regno di Granada sarebbe finito anche senza l’intervento di Isabella di Castiglia e Ferdinando di Aragona. Infatti l’impero turco, dopo aver espugnato Costantinopoli, aveva proseguito la sua azione sia nei Balcani, sia nel Nord Africa. Il sultano di Costantinopoli si proponeva come nuovo califfo e pretendeva l’obbedienza non solo religiosa, ma anche politica di tutti i paesi musulmani fin lì guidati dagli arabi.
Nel 1480 il sultano turco attaccò Otranto nell’intento di risalire da quel luogo lungo la penisola italiana. Il papa Sisto IV chiese a tutte le nazioni di unirsi in alleanza per scongiurare il pericolo. I reali della Spagna appena riunificata assicurarono il loro sostegno, ma l’aiuto tardò ad arrivare. Dopo essere stati assediati in Otranto per alcuni mesi, i turchi lasciarono la città pugliese, poiché il sultano Maometto II morì. Probabilmente in occasione dei colloqui per la difesa dell’Italia si discusse con gli ambasciatori della nascente Spagna anche del pericolo turco e dell’evoluzione che stava avvenendo in tutto il mondo arabo e che presto avrebbe toccato anche Granada e il regno nasride. I re di Castiglia e Aragona dovettero avere ancor più chiaro il corso degli eventi che si andava profilando e la prossima conquista turca dell’ultimo lembo di al-Andalus.
Se il regno nasride di Granada era allora un vassallo della Spagna, tutto sarebbe cambiato all’arrivo dei turchi, ben più potenti e desiderosi di conquistare più territori possibili.
Alle questioni internazionali si sommavano i dissapori interni alla dinastia nasride. Frequenti sollevazioni dei governatori, lotte dinastiche e intrighi di palazzo erano la costante. È possibile averne una conferma dalla lista dei sultani che governarono, molti dei quali furono assassinati a tradimento, deposti o reintegrati in breve lasso di tempo.

Il regno nasride di Granada
Alla fine della prima metà del XV secolo, Granada non poteva più ricorrere ai Merìnidi del Marocco che erano in decadenza e arrivarono a chiedere aiuto all’Egitto e agli Ottomani dopo che questi ebbero conquistato Costantinopoli nel 1453. La perdita nel 1462 di Gibilterra caduta in mano ai regni cristiani indebolì il regno nasride, poiché era il collegamento naturale con il Maghreb.
Il matrimonio tra Ferdinando d’Aragona e Isabella di Castiglia e l’unione dei loro regni nel 1479 fu ovviamente il passo decisivo che segnò l’inizio della fine.
A tutto questo si deve aggiungere che, commettendo un grave errore politico e militare, i nasridi attaccarono per primi il nascente regno di Spagna, probabilmente perché ritenevano che i reali fossero presi in quegli anni da ben altri problemi, preoccupati com’erano di conferire unità al nuovo Stato.
Invece la nuova entità politica del regno di Spagna si mostrò più unito delle previsioni nasridi, mentre furono gli ultimi re di al-Andalus a combattersi fra loro. Infatti, la cosiddetta guerra di Granada che pose fine all’esistenza di al-Andalus vide ben tre sultani (le fonti cristiane li chiamavano “re”) in contrasto e precisamente Abu l-Hasan 'Ali (1464-1482, 1483-1485) chiamato nelle fonti cristiane del tempo Alboacen o Muley Hacen, Abū ‘Abd Allāh Muhammad XII detto «Boabdil» o el Chico (1482-1483 e 1486-1492), figlio del precedente, e Muhammad XIII ibn Sa‘d (al-Zaghal "il Valente") (1485-1486), fratello del primo e zio del secondo.
La guerra cominciò quando il primo dei tre re, Abū l-Hasan ‘Alī, cioè il padre di Boabdil ed il fratello di al-Zagahl, non riconobbe il vassallaggio nei confronti della Castiglia e a sorpresa, nel 1481, attaccò e conquistò il castello di Zahara che apparteneva allora al regno di Castiglia.
Il re granadino, però, si abbandonò ai piaceri di corte cedendo il potere al suo visir tra il malessere e le sollevazioni dei suoi sudditi, mentre sua moglie e la sua concubina Zoraia, che era una cristiana rinnegata, lottavano per il diritto al trono dei loro rispettivi figli. Si inimicò così il figlio della moglie legittima, destinato ad essere erede al trono. Il giovane prenderà poi il nome di Abū ‘Abd Allāh Muhammad XII, e verrà detto Boabdil. La leggenda – con tratti storici – vuole che Abū l-Hasan ‘Alī giungesse ad uccidere i figli di primo letto e che si salvasse solo Boabdil, calato da una torre dell’Alhambra.
Boabdil, che vuol dire in arabo il “Piccolo”, raccolse il malcontento popolare, poiché i granadini temevano le conseguenze dell’imprudente attacco alla Castiglia. Per questo il figlio poté strappare Granada al padre, mentre questi era in battaglia contro i reali della nuova Spagna. Al ritorno dalla campagna militare vittoriosa non poté rientrare in Granada che era in mano al figlio, e così prese a governare i territori ad est di Granada, che avevano come città più importante Malaga.
Il figlio Boabdil, dovendosi mostrare risoluto come il padre, decise anche lui di agire contro gli spagnoli a Lucena, subito a sud di Cordoba (era la città dove era stato esiliato un tempo Averroè).
Venne, però, fatto prigioniero nel corso della campagna nel 1483. Isabella e Ferdinando, dopo averlo trattenuto per un certo tempo, decisero con furbizia di rimandarlo libero, chiedendogli però di lottare con loro contro il padre e, di fatto, rendendolo un vassallo – nell’accordo si chiedeva anche che Boabdil liberasse 400 schiavi cristiani ogni anno.
Boabdil accettò e tornò a Granada come vassallo degli spagnoli e, perciò, malvisto da parte dei granadini.
Quando gli spagnoli ripresero Zahara, l’ostilità dei granadini divenne palese, e Boabdil fuggì in Almeria. A Granada venne così richiamato come re il padre di Boabdil.
Ma nuovamente, sia perché il padre ebbe problemi fisici fino al punto di diventare cieco, sia perché i granadini erano scontenti della lotta che egli continuava a combattere contro il figlio, i granadini scacciarono nuovamente Abū l-Hasan ‘Alī e chiesero a suo fratello Muhammad XIII ibn Sa‘d - lo zio, quindi, di Boabdil -, che aveva sempre ben combattuto a fianco del re, di diventare re al suo posto. Il nuovo re venne soprannominato il Valente, al-Zaghal.
Si ritrovarono così a regnare tre re e la popolazione era divisa più che mai. Poco dopo il padre, Abū l-Hasan ‘Alī, morì nel 1485.
Al-Zaghal proseguì la politica del fratello e rimase ostile a Boabdil, mandando addirittura ad ucciderlo, ma questi fuggì. Al-Zaghal fece strage solo del fratello di Boabdil e di tutti i suoi partigiani che riuscì a catturare in Almeria.
Boabdil, nel frattempo, scappò presso gli spagnoli in cerca di un aiuto. Essi lo rinnovarono come loro vassallo fornendogli armi e sostanze. Riprese allora l’ ostilità fra il nipote e lo zio e le armate dei Mori si trovarono nuovamente divise in due partiti.
Lo zio Al-Zaghal riuscì a spingere suo nipote a difendere la parte dei territori ad ovest di Granada – in particolare Loja – per distrarre le truppe castigliane e per allontanarle da Granada. Ma Loja cadde e, di nuovo, Boabdil si sottomise ai castigliani.
Boabdil tornò allora a Granada ed entrò nell’Albaicín. Da lì, per 50 giorni, cercò di prendere l’Alhambra dove si era rinchiuso lo zio. Gli spagnoli, nel frattempo, attaccarono Malaga. Al-Zaghal, allora, offrì la pace al nipote per essere libero di accorrere in difesa di Malaga, ma il nipote, diffidente per l’ostilità che gli era stata fin lì riservata, rifiutò e si confermò nemico dello zio.
A Malaga le truppe di al-Zaghal vennero sconfitte. I granadini, allora, vista la sua sconfitta, si ribellarono ad al-Zaghal e rimisero sul trono Boabdil.
Ma a Boabdil era rimasta ormai solo Granada. Il 1489 forse fu l'anno più duro della guerra e la regina Isabella arrivò a vendere i suoi gioielli personali, per continuare a finanziare le operazioni militari. Finalmente cadde Baza nel dicembre del 1489. Poco dopo cadde Almería (1490) e subito dopo Guadix, Almuñécar e Salobreña: queste sconfitte portarono alla resa di al-Zaghal.
Al-Zaghal, ormai solo, si ritirò a Fez, nel Maghreb, ma lì fu condannato per aver diviso le forze dei Mori e per punizione venne accecato con un ferro arroventato.
Si giunse così all’assedio di Granada, rimasta ormai l’ultima città di al-Andalus. La città era, per di più, sovrappopolata perché lì si erano rifugiati mori provenienti da tutto il regno nasride. Nel frattempo, l’avanzata turca nel mediterraneo ed in Europa destava sempre più preoccupazione.
Infine, Boabdil si arrese, consapevole ormai che uno scontro militare avrebbe portato solo ad una inutile strage. Granada cadde così senza spargimento di sangue, a differenza delle altre città dove si era combattuto.
La resa avvenne il 2 gennaio 1492 mediante un accordo – le Capitolazioni - che garantiva ai musulmani l’esercizio della propria religione e la conservazione della lingua e dei costumi, condizioni forse troppo generose per poter essere rispettate dai vincitori.
19/ Quale interpretazione dare di al-Andalus? Riflessioni conclusive
La storia dell’Andalusia musulmana è stata spesso riletta in chiave ideologica. Nei secoli passati si sono calcate le tinte fosche, per mostrare come fosse stata opportuna la Reconquista. Come dice ottimamente Manuela Marín:
«Poche epoche della storia della penisola iberica hanno suscitato tante discussioni e sono state oggetto di interpretazioni tanto divergenti come quella andalusì. [...È nota] l’esistenza di una corrente storiografica, che può venire classificata come “tradizionalista”, secondo la quale questa tappa della storia peninsulare doveva rientrare in una linea di continuità che preserva l’identità spagnola a partire dalla romanizzazione fino alla “riunificazione” dei territori ispanici sotto i Re Cattolici. Secondo questa visione essenzialista della storia, la vicenda di al-Ándalus si trasforma, dopo il suo dissolversi come entità politica, in un episodio – di lunga durata – il cui ricordo doveva venir cancellato dalla memoria collettiva o, in ogni caso, permanervi sotto il segno del rifiuto più assoluto»[77].
Oggi prevale la tendenza opposta, quella di idealizzare al-Andalus attribuendogli i connotati di una tolleranza fra diverse culture e di una raffinatezza diffusa che sono altrettanto ideologici quanto l’affermazione che la Spagna moderna è la prosecuzione dell’Iberia pre-islamico. È sempre Manuela Marín a sottolinearlo:
«Due sono stati i temi sorti con maggior forza da questo uso mitizzante e che continuano a svilupparsi con insistenza e, probabilmente, senza possibilità di ritorno.
Il primo di questi due temi ha conosciuto una fortuna molto maggiore di qualsiasi delle sue interpretazioni precedenti e sarà difficile che, nelle circostanze attuali, possa venire sottoposto ad una rivalutazione: si tratta dell’immagine di al-Ándalus come società della tolleranza e della convivenza, nella quale fioriscono le “tre culture” in un ambiente di mutua comprensione e che fu soppressa violentemente dai conquistatori cristiani. Questa invenzione consolatrice permetteva di accettare che non tutto nella storia della Spagna era stato inquisizione e “viva le galere!”. Anzi, autorizzava a rivendicare una parte del passato e a mostrarla come esempio da seguire nelle non sempre limpide acque del presente, non solo in Spagna: il modello di convivenza delle tre religioni monoteiste ha applicazioni in altri luoghi del Mediterraneo ed esistono numerosi esempi di suoi usi politici e propagandistici, sia in Spagna, sia al di fuori di essa.
Il successo di questa proposta interpretativa di al-Ándalus è cresciuto alimentato da commemorazioni varie e dalla diffusione di concetti come il meticciato e la multiculturalità, entrambi dotati di un certo carattere paternalista (molto più accusato nel caso della “tolleranza”). In nome delle tre culture e della loro armoniosa convivenza sono stati convocati congressi scientifici e riunioni di rappresentanti delle tre religioni interessate: lo slogan ha impregnato il discorso politico e si è trasformato in una comoda risorsa per affermare retoricamente la bontà dell’aperturismo verso altre culture. Invocare l’immagine dell’ al-Ándalus tollerante e multiculturale è un procedimento di semplice efficacia e a rischio zero: pertanto la sua permanenza è garantita fino a quando non sorgerà un’altra distorsione storica di maggior forza.
Nel secondo tema di questa recente mitizzazione di al-Ándalus, le virtù decantate della società andalusì non si radicano unicamente nella sua apertura tollerante ma derivano naturalmente da essa. Quella che è stata chiamata “l’arte di vivere” andalusì ha plasmato, in questo secondo livello del mito, uno spazio di delicati piaceri sensuali, modello offerto all’ammirazione leggermente invidiosa della società postindustriale. Il gusto per i profumi, i giardini, la buona cucina, la musica e le belle donne diventa così peculiare degli andalusì, esperti conoscitori e degustatori dei piaceri vitali più raffinati. Vengono pubblicati libri di cucina andalusì e romanzi ambientati nella Cordova califfale in cui è possibile percepire chiaramente l’eco del fascino occidentale verso i sistemi sensuali d’Oriente. Si è così giunti a costruire il mito di una società andalusì reinventata nei nostri giorni per esprimere gli aneliti di coloro che abitano la stessa penisola cinquecento anni dopo e che si immaginano un mondo ideale in cui la soddisfazione del desiderio avveniva con finezza e fervore. Forse con minore diffusione dell’idea della convivenza e delle tre culture, questo aspetto del mito andalusì non è, tuttavia, meno attraente e presenta già conseguenze curiose, come l’apparizione in Andalusia di piatti “mozarabici” in alcuni ristoranti o l’imposizione a neonati (soprattutto bambine) di nomi con risonanze arabe. […]
Il desiderio di rivendicare un’“arte di vivere” andalusì nasconde l’evidente realtà storica che il raffinamento dei costumi, che oggi risveglia il desiderio di una sua emulazione, era confinato a gruppi sociali ridottissimi. Mentre a nessuno viene però in mente di estendere lo splendore della corte di Versailles, per fare un esempio, a tutta la società francese del XVII secolo, nel caso di al-Ándalus vengono generalizzati senza pudore i gusti e gli appetiti della classe dirigente allargandoli a tutti gli strati della società e si giunge alla conclusione che gli andalusì erano, per natura, gente di una raffinatezza e saggezza speciali e particolari. Si dimentica che il Generalife non era un giardino aperto al pubblico e che la dieta normale dell’immensa maggioranza della popolazione non includeva nessuno dei piatti descritti nei ricettari di cucina giunti fino ai nostri giorni»[78].
Con questo studio si è cercato di individuare, invece, alcuni nodi storici che sono decisivi per comprendere in cosa sia consistita l’esperienza di al-Andalus.
Note al testo
[1] Si può citare, ad esempio di questa visione irenica dell’Andalusia musulmana, con l’immediato contrappasso di discredito verso la Reconquista, il testo per bambini plurilingue che è in vendita all’Alhambra di Granada che così scrive: «All’inizio dell’VIII secolo arrivarono gli Arabi, la cui religione è l’islamismo. Noi li abbiamo chiamati musulmani, maomettani, saraceni… Per le loro imprese, dovute al loro grande coraggio e determinazione, divennero signori della Spagna intera, escluso un angolino su al nord. Erano, per di più, sapienti ed eruditi, e raggiunsero il culmine del loro splendore con il Califfato di Córdoba. Però si impelagarono in discordie e competizioni fra di loro e in continui scontri con i cristiani; e così intaccarono la loro unità e si divisero in una miriade di piccoli regni indipendenti (chiamati taifas). E di questo, ovviamente, approfittarono i cristiani per riconquistare parte delle terre che avevano perduto (i regni di Asturie, di León, di Castiglia, di Navarra, di Aragona, e altri)» (R. Villa-Real, L’Alhambra raccontata ai bambini, Ediciones Miguel Sànchez, Granada, 2000, pp. 4-5) - si noti che non si accenna minimamente ad una guerra di conquista, ma si dice semplicemente “arrivarono”, mentre per la Reconquista si utilizza il termine “approfittarono”, termine che, agli occhi di un bambino, non suona bene.
[2] I vandali, in realtà, attraversarono la penisola iberica ma solo per dirigersi in Africa del nord ed il loro passaggio non lasciò tracce rilevanti. L’origine gotica del termine è la più convincente, perché consistente fu invece l’apporto dei visigoti alla storia della penisola; cfr. Heinz Halm, "al-Andalus und Gothica Sors", Die Welt des Orients, 66, 1989, pp. 252ss. (fonte Wikipedia).
[3] Ibn al-Kardabūs, Historia de al-andalus, (F. Maíllo Salgado ed.), Akal, Madrid, 2011, p. 68.
[4] Ibn al-Kardabūs, Historia de al-andalus, (F. Maíllo Salgado ed.), Akal, Madrid, 2011, p. 65.
[5] Cfr. su questo Breve nota sull’hadith riguardante Costantinopoli (Kustantiniyya): Maometto profetizza che la capitale dell'impero bizantino cadrà in mano islamica ??? http://www.gliscritti.it/blog/entry/756.
[6] Ibn al-Kardabūs, Historia de al-andalus, (F. Maíllo Salgado ed.), Akal, Madrid, 2011, pp. 62-63.
[7] Si ricorda anche la pena della crocifissione che veniva inflitta: cfr. Ibn al-Kardabūs, Historia de al-andalus, (F. Maíllo Salgado ed.), Akal, Madrid, 2011, p. 89.
[8] Ibn al-Kardabūs, Historia de al-andalus, (F. Maíllo Salgado ed.), Akal, Madrid, 2011, p. 61.
[9] Ibn Idari, Bayan al-Mugrib II, 109, del testo arabo, citato in Anales de Córdoba musulmana (863 - 912), Antonio Arjona Castro (a cura di) doc. n. 47, disponibile on-line al link http://www.webislam.com/articulos/26541-anales_de_la_cordoba_musulmana_863_912.html. Per la parte completa relativa a al-Andalus, cfr. Ibn Idari al-Marrakusi (1999). Historia de Al-Andalus (Traducción y Estudio Histórico-Crítico de Francisco Fernández González). Málaga: Ediciones Aljaima.
[10] Kura di Elvira, 2.900; Yayyan = Jaén, 2.280; Qabra, 1.800; Baguh = Priego, 900; Takarunna, 299; al-Yazira = Algeciras, 290; Ishtiyya = Ecija, 1.200; Qarmuna, 185; Shiduna = Sidonia, 6.790; Rayya, 2.600; Fahs al-Ballút, 400; Mawrur 1= Morón, 1.400; Tudmir, 156; Rubina, 106; Qal’at Rabát, e Urit= Calatrava e Oreto, 387.
[11] Sull’abbandono della Novalesa, oltre alle fonti antiche come la Cronaca di Novalesa (G. Alessio, a cura di, Einaudi, Torino, 1981, p. 306, cfr. G. Cantino Wataghin, L’abbazia dei Santi Pietro e Andrea di Novalesa: il contributo delle indagini archeologiche al recupero della sua memoria, in Novalesa. Nuove luci dall’Abbazia, M.G. Cerri / a cura di), Electa, Milano, 2004 e : Pejrani Baricco - S. Uggé - G. Cantino Wataghin, Novalesa. Scavi nell’Abbazia dei SS. Pietro e Andrea, in Notiziario, QSAP 25 (2010), pp. 236-243.
[12] Cfr. B.Z. Kedar, Una nuova fonte per l’incursione musulmana del 934-935 e le sue implicazioni per la storia genovese, in Oriente e Occidente tra medioevo ed età moderna. Studi in onore di Geo Pistarino, a cura di L. BALLETTO, II, Genova 1997, p. 609; A.A. Settia, Monasteri subalpini e presenza saracena: una storia da riscrivere, in Dal Piemonte all’Europa: esperienze monastiche nella società medievale. Relazioni e comunicazioni presentante al XXXIV congresso storico subalpino (Torino, 27-29 maggio 1985), Torino 1988, pp. 293-310 (anche, con il titolo I Saraceni sulle Alpi: una storia da riscrivere, “Studi storici”, 28, 1987, pp. 127-143); L. Balletto, Le incursioni saracene del secolo X nell’area subalpina, “Rivista di storia, arte e archeologia per le province di Alessandria e di Asti”, C (1991), pp. 9-26.
[13] Liudprandus, Antapodosis, in Liudprandi Opera, a cura di J. Becker, Hannoverae et Lipsiae 1915, pp. 104-105 (IV, 2-5).
[14] Su questo cfr. Fraxinetum saracenorum, di Carlo Carosi, on-line su questo stesso sito http://www.gliscritti.it/blog/entry/3302 .
[15] Cfr. su questo Gli arabi nel Lazio nei secoli IX e X, di Giuseppe Cossuto e Daniele Mascitelli, on-line su questo stesso sito http://www.gliscritti.it/approf/2007/saggi/arablazio/arablazio.htm .
[16] Su tutto questo, cfr. J. Fontaine, Mozarabico. L’arte. Cristiani e musulmani nell’alto medioevo, Jaca Book, Milano, 1983.
[17] Ibn ‘Idari al-Marrakushi, al-Bayan al-mughrib fi akhbar muluk al-Andalus wa’l-Maghrib, inizi del XIII secolo; nostra traduzione dalla traduzione in inglese di Assia Lamzah, II: 229-230.
[18] Cfr. l’articolo risolutivo sulla questione di Jean Pierre Molénat, La place des chrétiens dans la Cordoue des Omeyyades, d’après leurs églises (VIIIe-Xe siècles), “Al-Qanṭara”, Vol 33, No 1 (2012), pp. 147-168, disponibile anche in PDF on-line.
[19] Ibn ‘Idari al-Marrakushi, al-Bayan al-mughrib fi akhbar muluk al-Andalus wa’l-Maghrib, inizi del XIII secolo; nostra traduzione dalla traduzione in inglese di Assia Lamzah, II: 229-230.
[20] Jean Pierre Molénat, La place des chrétiens dans la Cordoue des Omeyyades, d’après leurs églises (VIIIe-Xe siècles), “Al-Qanṭara”, Vol 33, No 1 (2012), p. 154, disponibile anche in PDF on-line.
[21] Di seguito il riferimento bibliografico che riprendiamo direttamente dall’articolo di Jean Pierre Molénat citato: «Le passage a été édité par Muhammad ‘Abd al-Wahhāb Ḫallāf, dans le fascicule Waṯā’iq fī ahkām, pp. 77-80). Une partie de ce texte se trouve également dans un fragment kairouanais publié par Miklos Muranyi (Beiträge zur Geschichte der Hadīṯ, texte IX, p. 369), et il est cité par Wanšarīsī (al-Mi‘yār, t. 2, p. 245-249). Nous avons pu constater dans l’édition des Ahkām al-kubrā donnée par Rašīd Nu‘aymī (Ibn Sahl, Dīwān al-ahkām, t. 2, pp. 1173-1174, «fī man‘ ahl al-ḏimma ihdāṯ al-kanā’is», dont les photocopies nous ont été aimablement communiquées par Delfina Serrano), comme dans celle de Yahyā Murād (Ibn Sahl, Dīwān al-Ahkām, pp. 628-629), la conformité avec le texte publié par Ḫallāf. Le texte de Wanšarīsī est résumé par V. Lagardère, Histoire et société, n.° 1-203, p. 55».
[22] L’analisi letteraria dei testi degli storci arabi coincide perfettamente con le analisi archeologiche riportate da Pedro Marfil Ruiz, Córdoba de Teodosio a Abd al-Rahmán III, in Anejos de AEspA, XXIII, 2000, pp. 117-141, disponibile on-line al link http://www.laac.es/pdf/marfilteodosio.pdf. Per approfondimenti, c fr. anche la voce Cordova, di A. Marcos Pous - A.M. Vicent Zaragoza, in Enciclopedia dell' Arte Medievale (1994) Treccani, disponibile on-line.
[23] Cfr. voce “Elvira, concilio di”, in Dizionario patristico e di antichità cristiane (DPAC, Marietti, Casale Monferrato, 1983, vol. I, coll. 1144-1145).
[24] Á.R. Aguilera, Granada arqueológica, Ed. La General. Caja de Granada, Granada, 2001, p. 79; per un’analisi globale degli scavi archeologici in Albaicín, l’Elvira romana e cristiana, cfr. Granada en época Romana: Florentia Illiberitana, Ed. Museo Arqueológico y Etnológico de Granada-Junta de Andalucía, Granada, 2008.
[25] Cfr. D. Ortu, La città di Sevilla tra Visigoti e Arabi, in Ricerca e confronti 2010. ATTI delle Giornate di studio di archeologia e storia dell’arte a 20 anni dall’istituzione del Dipartimento di Scienze Archeologiche e Storico-artistiche dell’Università degli Studi di Cagliari (Cagliari, 1-5 marzo 2010), pubblicati on-line su ArcheoArte. Rivista elettronica di Archeologia e Arte, Supplemento 2012 al numero 1 e disponibile al link http://ojs.unica.it/index.php/archeoarte/article/view/557/449.
[26] Dove è pure il pulpito eretto dopo la Reconquista, dal quale si dice che abbiano predicato Vicente Ferrer, Francisco de Borja, Fernando de Contreras, il frate Diego José de Cádiz, Juan de Ávila.
[27] Cfr. Ibn al-Qutiyya, Ribera, J. ed., Tariij iftitah al-Andalus, Madrid, 1926, p. 8.
[28] J.L. Cave, Guía de la España Judía. Itinerarios de Sefarad, El Almendro, Cordoba, 2004, p. 111.
[29] J.L. Cave, Guía de la España Judía. Itinerarios de Sefarad, El Almendro, Cordoba, 2004, p. 69.
[30] Una descripción anónima de al-Andalus (1983), pp. 197-199.
[31] L’elenco è stato elaborato da J.M. Sáez Castán, a partire appunto da Una descripción anónima de al-Andalus. Per approfondimenti, vedi lo stesso studio J. M. Sáez Castán, Análisis crítico de La civilización hispano-árabe de Titus Burckhardt, pp. 257-258 (on-line al link http://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/15035/1/tesis_saez.pdf).
[32] Ibn Hayyan, Muqtabis, edic. Antuña, pp. 93-96.
[33] I dati storici sono tratti da una nostra traduzione di pannelli esposti all’interno delle sale museali nel Palazzo di Carlo V, nell’Alhambra di Granada, integrati da dati tratti daJ.Fontaine, Mozarabico. L’arte. Cristiani e musulmani nell’alto medioevo, Jaca Book, Milano, 1983 e dalle altre fonti citate.
[34] Cfr. per quanto segue sull’emirato di Cordoba: J. Fontaine, Mozarabico. L’arte. Cristiani e musulmani nell’alto medioevo, Jaca Book, Milano, 1983, con fotografie di Zodiaque.
[35] Manuela Marín, Storia della “Spagna musulmana” e dei suoi abitanti: al-Ándalus e gli andalusì, Milano, Jaca Book, 2001, pp. 33-34.
[36] Per approfondimenti, cfr. F. Beguinot, voce Almoràvidi, in Enciclopedia Italiana (1929), disponibile on-line.
[37] Per approfondimenti, cfr. F. Beguinot, voce Almohàdi, in Enciclopedia Italiana (1929), disponibile on-line.
[38] Cfr. su questo I musulmani di fronte al mistero della croce: rifiuto o incomprensione?, di M. Borrmans.
[39] Manuela Marín, Storia della “Spagna musulmana” e dei suoi abitanti: al-Ándalus e gli andalusì, Milano, Jaca Book, 2001, pp. 27-28.
[40] La definizione sopra-citata (da EI, II, 234, articolo Dhimma), è tratta da Etudes Arabes.Dossiers, Al-Dhimma. L’Islam et les minorités religieuses, n.80-81, 1991/1-2, Pontificio Istituto di studi arabi e d’islamistica (PISAI), Roma, p. 5.
[41] B. Lewis, Gli ebrei nel mondo islamico, Sansoni, Firenze, 1991, p. 108.
[42] Etudes Arabes.Dossiers, Al-Dhimma. L’Islam et les minorités religieuses, n.80-81, 1991/1-2, Pontificio Istituto di studi arabi e d’islamistica (PISAI), Roma, p. 5.
[43] B.Lewis in Gli ebrei nel mondo islamico, Sansoni, Firenze, 1991, pp. 20-22.
[44] Manuela Marín, Storia della “Spagna musulmana” e dei suoi abitanti: al-Ándalus e gli andalusì, Milano, Jaca Book, 2001, pp. 37-38.
[45] Cfr A.Th. Khoury (a cura di), Manuel II Paléologue, Entretiens avec un Musulman. 7 e Controverse. Sources chrétiennes n. 115, Parigi 1966, p. 144, nota 1.
[46] R. Arnaldez, Grammaire et théologie chez Ibn Hazm de Cordoue. Parigi 1956 p. 13; cfr Khoury p. 144. Il fatto che nella teologia del tardo Medioevo esistano posizioni paragonabili apparirà nell'ulteriore sviluppo del mio discorso.
[47] Controversia VII 2c: Khoury, pp. 142-143; Förstel, vol. I, VII. Dialog 1.5, pp. 240-241. Questa citazione, nel mondo musulmano, è stata presa purtroppo come espressione della mia posizione personale, suscitando così una comprensibile indignazione. Spero che il lettore del mio testo possa capire immediatamente che questa frase non esprime la mia valutazione personale di fronte al Corano, verso il quale ho il rispetto che è dovuto al libro sacro di una grande religione. Citando il testo dell'imperatore Manuele II intendevo unicamente evidenziare il rapporto essenziale tra fede e ragione. In questo punto sono d'accordo con Manuele II, senza però far mia la sua polemica.
[48] Controversia VII 3b – c: Khoury, pp. 144-145; Förstel Bd. I, VII. Dialog 1.6 pp. 240-243.
[49] «Solamente per questa affermazione ho citato il dialogo tra Manuele e il suo interlocutore persiano. È in quest'affermazione che emerge il tema delle mie successive riflessioni» - prosegue Benedetto XVI.
[50] Fernand Van Steenberghen, La filosofia nel XIII secolo, Vita e pensiero, Milano, 1972, p. 31.
[51] Per approfondimenti sulla riflessione di Averroè in merito al valore della filosofia, cfr. su questo stesso sito Averroè, di Cesare Vasoli http://www.gliscritti.it/blog/entry/3346 .
[52] H. Corbin, Storia della filosofia islamica, Milano, Adelphi, 1991, pp. 250-251.
[53] Cfr. su questo Moshe Halbertal, Maimonides: Life and Thought, Princeton University Press, 2013, pp. 23-33.
[54] B. Lewis in Gli ebrei nel mondo islamico, Sansoni, Firenze, 1991, pp. 102-105.
[55] Haim Zeev Hirshberg, "On the decrees of the Almohads and the Trade with India: A Letter from 1148", Isaac Beer Jubilee Book, Israel Historical Society, 1961, pp. 134-135, in ebraico.
[56] B. Lewis in Gli ebrei nel mondo islamico, Sansoni, Firenze, 1991, pp. 102-105.
[57] Prosegue van Steenberghen: «Secondo il padre Bédoret, l’autore di quel piccolo trattato è probabilmente il filosofo arabo Alfarabi, morto nel 949 o 950. Appoggiandosi sulla testimonianza di Alberto Magno e di due manoscritti, il padre Théry ed il padre Alonso hanno attribuito l’opuscolo ad un traduttore ebreo di Toledo, David, il collaboratore di Domenico Gundisalvi. Il padre Saffrey ritiene che questi autori esagerino la parte di David, al quale si dovrebbe solamente un lavoro di compilazione: David avrebbe estratto gli assiomi dalla traduzione araba di Proclo e vi avrebbe aggiunto i commenti ispirandosi ad Alfarabi, Avicenna ed altri autori arabi. Ma tutto ciò rimane ipotetico: “Non si sa nulla di sicuro a proposito delle origini e dell’autore del Liber de causis”. L’opuscolo arabo è stato tradotto in latino da Gerardo di Cremona, dunque prima del 1187».
[58] Fernand van Steenberghen, La filosofia nel XIII secolo, Vita e pensiero, Milano, 1972, pp. 67-69.
[59] U. e A. Perone – G. Ferretti – C. Ciancio, Storia del pensiero filosofico, II, SEI, 1983, p. 277.
[60] Cfr. S. Gil Jose, La escuela de traductores de Toledo y los colaboradores judios, Instituto provincial de investigaciones y estudios toledanos, Toledo 1985 e AA. VV., La escuela de traductores de Toledo, Disputacion Provincial de Toledo, Toledo 1996, realizzato in occasione della mostra La escuela de traductores de Toledo, tenuta a Toledo, settembre-dicembre 1996.
[61] Cristiani e “cristianisti”, Intervista di Gianni Valente a Rémi Brague, in “30Giorni”, ottobre 2004.
[62] Rémi Brague, Non c’è oriente senza cristiani, in Avvenire del 27/3/2015 (brano tratto dal libro-intervista di Giulio Brotti con Rémi Brague, Dove va la storia? Dilemmi e speranze, La Scuola, 2015.
[63] Manuela Marín, Storia della “Spagna musulmana” e dei suoi abitanti: al-Ándalus e gli andalusì, Milano, Jaca Book, 2001, pp. 39-40.
[64] Manuela Marín, Storia della “Spagna musulmana” e dei suoi abitanti: al-Ándalus e gli andalusì, Milano, Jaca Book, 2001, pp. 29-30.
[65] al-Maqqari, Nafh al-Tib, Analectes, según versión de Gayangos, trad. española de Claudio Sánchez Albornoz, La España musulmana, I, pp. 331 al 336. Texto árabe in al-Maqqari, Analectes, pp. 344, 346, 347; 370-372.
[66] Cfr. M.J. Viguera Molíns, Sobre la histora de los judíos en al-Andalus, in A, Sáenz-Badillos (ed.), Judíos entre arabes y cristianos. Luces y ombras de una convivencia, Ed. El Almendro, Cordoba, 2000, p. 32.
[67] J. Fontaine, Mozarabico. L’arte. Cristiani e musulmani nell’alto medioevo, Jaca Book, Milano, 1983, con fotografie di Zodiaque.
[68] Così J.-F. Rollan Ortiz, Iglesias mozarabes leonesas, Everest, León, 1992.
[69] L. Casanas Guasch, voce “Liturgia mozarabica”, in Enciclopedia Cattolica, Città del Vaticano, 1952, vol. VIII, coll. 1496-1498.
[70] Per le diverse vicende ricordate, cfr. C. Eid, A morte in nome di Allah. I martiri cristiani dalle origini dell’Islam a oggi, Casale Monferrato, Piemme, 2004.
[71] G. Martinez, voce “Mozarabo”, in Dizionario enciclopedico del Medioevo, (a cura di A. Vauchez; edizione italiana a cura di C. Leonardi), Città Nuova-Cerf-James Clarke & Co., vol II, pp. 1249-1251.
[72] J. Fontaine, Mozarabico. L’arte. Cristiani e musulmani nell’alto medioevo, Jaca Book, Milano, 1983, con fotografie di Zodiaque.
[73] Su tali dipinti, cfr. C. Bernis, Las pinturas de la sala de los Reyes de la Alahmbra, in Cuadernos de la Alahmbra 18, Granada, 1982, pp. 21-50.
[74] Manuela Marín, Storia della “Spagna musulmana” e dei suoi abitanti: al-Ándalus e gli andalusì, Milano, Jaca Book, 2001, p. 22.
[75] Manuela Marín, Storia della “Spagna musulmana” e dei suoi abitanti: al-Ándalus e gli andalusì, Milano, Jaca Book, 2001, pp. 28-29.
[76] Manuela Marín, Storia della “Spagna musulmana” e dei suoi abitanti: al-Ándalus e gli andalusì, Milano, Jaca Book, 2001, p. 23.
[77] Manuela Marín, Storia della “Spagna musulmana” e dei suoi abitanti: al-Ándalus e gli andalusì, Milano, Jaca Book, 2001, pp. 50-51.
[78] Manuela Marín, Storia della “Spagna musulmana” e dei suoi abitanti: al-Ándalus e gli andalusì, Milano, Jaca Book, 2001, pp. 55-58.



