L’opposizione polare in Romano Guardini, ben più profonda delle moderne teorie della complessità: di tale visione non si può far a meno per comprendere la vita umana, il dibattito sociale e la stessa fede, di Andrea Lonardo
Riprendiamo sul nostro sito uno studio di Andrea Lonardo, redatto a partire dalle sintesi di M. Borghesi, che saranno citate nell’articolo. Restiamo a disposizione per l’immediata rimozione se la sua presenza sul nostro sito non fosse gradita a qualcuno degli aventi diritto. I neretti sono nostri ed hanno l’unico scopo di facilitare la lettura on-line. Per approfondimenti, cfr. le sezioni Filosofia e Cristianesimo.
Il Centro culturale Gli scritti (27/7/2025)
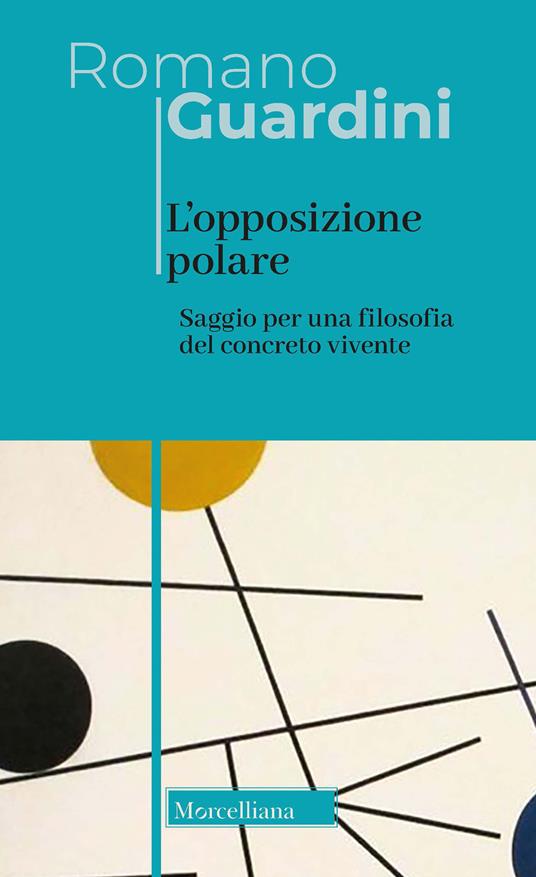
1/ Esemplificare per incamminarsi
Per Guardini non è la complessità, ma l’opposizione polare la chiave per comprendere l’esistenza umana e i contesti sociali.
La realtà umana vive e prospera non dove si dimentica uno dei poli in tensione, non dove lo si sintetizza dialetticamente con il suo opposto, bensì dove entrambi vengono “tirati all’estremo” e valorizzati, senza mai dimenticare, però, la tensione con il polo opposto.
Vale la pena esemplificare subito - in maniera forse troppo semplice, ma utile per un primo approccio alla questione - alcuni aspetti della tensione polare che ogni uomo vivente sperimenta ogni giorno, per giungere solo poi a trattare di come Guardini la presenti.
Nell’uomo esistono l’affettività e la razionalità. C’è chi insiste sull’importanza del cuore e c’è chi insiste sulla necessità della ragione: ebbene il cuore e la ragione sono in effetti “opposti” e si potrebbe pensare o ad una scelta fra i due o ad una qualche mediazione che ammorbidisca i due punti di vista.
Non così per l’opposizione polare. Infatti, se, in nome della ragione, si dimenticasse l’assoluta importanza degli affetti, ecco che l’uomo impoverirebbe. Ma se, all’opposto, in nome degli affetti, si dimenticasse l’assoluta centralità della ragione, ecco che gli affetti non avrebbero futuro.
Non una scelta allora fra la carità e la cultura, fra l’amore e la riflessione, e nemmeno una sintesi equilibrata fra i due: solo una esaltazione di entrambi i membri dell’opposizione permette alla vita di fiorire. Guardini afferma che l’opposizione polare è la regola della vita, sia individuale che sociale.
Una seconda opposizione, a mo’ di esempio previo, ancora solo per una prima comprensione di massima. Nell’uomo esiste l’esigenza di un ordine, di regole, di stabilità e qualcuno direbbe che la vita fiorisce dove si propone una tale armonia.
Ma altri subito risponderebbero che solo dove c’è innovazione creativa e novità al punto di scompigliare l’ordine, solo lì ci sarebbe futuro.
Si potrebbe pensare ad un aut aut fra le due dimensioni. O ad una mediazione che salvasse l’uno e l’altro aspetto. No, si tratta invece di “spingere” all’estremo ognuno dei due membri dell’opposizione perché solo in questo modo si riesce a rendere conto della realtà della vita.
Infatti, senza la presenza dirompente della creatività, si ingenererebbero individui metodici e fiacchi, tesi al dovere e chiusi al futuro. Ma, al contempo, se ogni nuova proposta dimenticasse quella tradizione già sperimentata e quell’ordine armonico che regge da secoli e che solo fornisce la possibilità di radicarsi e fiorire, niente maturerebbe.
Di nuovo, non un’opposizione fra novità e tradizione, non una banale composizione, ma l’esigenza di esaltarle e di farne percepire tutta la necessità: entrambe debbono essere sovraesaltate e sommamente considerate.
Si pensi, infine, ancora all’immanenza e alla trascendenza. È una delle grandi opposizione su cui si è costruita tanta filosofia del XIX e XX secolo.
Ebbene, nella visione di Guardini, un uomo – ma anche una società - cui fosse sottratto il compito storico e immanente di crescere nel lavoro, nel guadagno, nella materialità e nella socialità dell’esistenza, non potrebbe mai colmare tale assenza con la pura trascendenza. All’opposto, tutto il progresso storico e sociale, se fosse costruito sulla dimenticanza di un’apertura al trascendente diverrebbe immediatamente dittatura e consumismo senza speranza.
Nuovamente, non una sintesi, non un tacito accordo, non una pura opposizione. L’immanenza e la trascendenza debbono essere esaltate e perseguite con decisione, richiamandosi costantemente l’una all’altra, pena l’inaridimento delle prospettive.
Si capisce subito quanto questo sia decisivo in prospettiva comunitaria e sociale. Una società che trascurasse il lavoro, il guadagno, la ricerca tecnologica o, all’opposto, che mettesse fra parentesi l’esigenza della verità e della fede, sarebbe destinata a diventare poco umana, meno umana, addirittura dis-umana.
Similmente una Chiesa che puntasse tutto sulla sola fede o all’opposto sulla sola carità, sul solo annuncio del Vangelo o sulla sola prospettiva sociale perderebbe immediatamente quella dimensione polare che sola la rende veramente universale e capace di corrispondere all’uomo così come egli è.
Forse l’opposizione polare è ancora più necessaria oggi, dinanzi ad una generazione di intellettuali che ha esaltato il dualismo in forma manichea, propugnando in politica e nelle visioni sociali della vita la scelta di uno dei due corni del dilemma a discapito dell’altro. Oggi si è ancora più in grado di comprendere quanto sia liberante e prospettica la chiave di lettura proposta con decisione da Guardini.
2/ L’originalità della prospettiva guardiniana, ma anche la sua rispondenza alla riflessione del tempo
Scrive Borghesi che Guardini dà «luogo a un “nuovo pensiero” della cui originalità l’autore è perfettamente cosciente»[1].
L’opposizione polare è del 1925 e viene pubblicata con il titolo Der Gegensatz. Versuche zu einer Philosophie des Lebending-Konkreten (L’opposizione polare. Tentativi per una filosofia del concreto-vivente).
È l’opera fondamentale di antropologia filosofica di Guardini e ciò che viene lì chiarito traspare poi, fra le righe, in filigrana, in qualsiasi altro suo studio filosofico o teologico.
Borghesi la descrive giustamente come la confluenza di diverse dimensioni vissute e avvertite dall’autore: «il prodotto finale appare come un fiume che raccoglie molti affluenti: l’elaborazione della propria biografia segnata dalla malinconia, un modello delle polarità psicologiche, una concezione del cattolicesimo come coincidentia oppositorum, il disegno di un’antropologia integrale che unisca affettività e razionalità, la speranza di offrire un contributo dialogico nel mondo post-bellico segnato da dilacerazioni profonde. Tutto questo è Der Gegensatz (L’opposizione polare)»[2].
Certo Guardini dimostra di ben conoscere la filosofia dei primi decenni del Novecento e, in particolare, le riflessioni di Simmel e di Jasper che intesero elaborare una “filosofia della vita”. Importanti sono le parole del sotto-titolo del volume che dichiarano l’intenzione di presentare una filosofia del “concreto-vivente”. È questo che Guardini intende fare: non una qualche teoria astrusa, ma la chiarificazione della modalità propria di ciò che è concretamente la vita dell’uomo. È una pretesa seria, pur nel modo di argomentare tipico dell’autore, sempre rispettoso e umile.
Scrive Guardini, enunciando il suo assunto:
«L’intero umano nella sua globalità come nei suoi aspetti particolari […] è strutturato in base all’opposizione per poter essere vivente. Il fenomeno dell’opposizione è un tratto fondamentale della vita umana. Qualunque sia il fenomeno di cui si tratti - anatomico-fisiologico o emotivo, intellettuale o volitivo, individuale o sociale - il fatto dell’opposizione è il modo con cui il fenomeno si dà, è la forma strutturale ed operativa della vita»[3].
Come Kant aveva, in un ben diverso senso, enucleato la “tavola delle categorie”, così Guardini ricostruisce nel suo studio quelle che sono, a suo avviso, le “categorie” fondamentali e costitutive del dispiegarsi della vita umana:
«In molti anni, osservazioni singole e la riflessione mi hanno fatto scoprire un certo numero di realtà ultime in rapporto di opposizione. Credo che si tratti di ciò che cerchiamo. Molte conferme in diversi ambiti dell’autoesperienza umana sembrano avvalorare il fatto che qui ci troviamo davvero di fronte alle forme di opposizione fondamentali del vivente-umano. Questa serie di opposti si presenta addirittura con la pretesa esclusiva che non esistano altre forme ultime di opposizione, altrettanto fondamentali. Anzi la pretesa è che tutti gli opposti ancora individuabili debbano essere ricondotti a quella serie, come il particolare sta all’universale»[4].
Prima di presentarle in dettaglio è utile riportare quanto scrive Borghesi sui due poli dell’opposizione, richiamandosi, come fa lo stesso Guardini, ai due grandi capostipiti della filosofia greca, Eraclito e Parmenide, i filosofi del “panta rei” e dell’“l’essere è e il non essere non è”:
«La serie, divisa in due ordini fondamentali, vede da un lato il polo “dinamico”, “eracliteo”, e, dall’altro, il polo statico, proprio di una visione “parmenidea”. Eraclito e Parmenide appaiano come i casi limite di un’oscillazione polare, di un movimento alternato della vita che passa dall’atto alla quiete, dal genio ribelle alla necessità della forma, dall’individualismo all’esigenza di una totalità organica. Sul piano di una visione tipologica dell’uomo le due serie corrispondono a due tipi fondamentali: il ribelle creativo e anarchico di contro all’organizzatore, metodico e razionale»[5].
All’interno di tale polarità Guardini afferma che gli “opposti categoriali” – espressione con cui si deve intendere gli opposti nelle forme in cui vengono sperimentati dalla vita stessa – sono “intraempirici” e “transempirici”.
“Intraempirici” vuol dire che quegli opposti sono interni e propri della persona stessa, sperimentabili da ognuno nella propria vita personale.
“Transempirici” vuol dire che quegli opposti sono sperimentabili dalla persona stessa, ma guardando al di là, oltre, la propria stessa vita.
Gli opposti categoriali intraempirici sono trovati da Guardini in questa triplice schema:
-Atto (Dinamica) ↔ Struttura (Statica)
-Informale (Eccedenza) ↔ Formale (Forma)
-Singolarità (Differenziazione) ↔ Totalità (Integrazione)
Ciò vuol dire che ogni uomo è vivo perché il suo stesso organismo possiede un movimento vivo (atto/dinamica), innanzitutto fisico, ma al contempo è vivo proprio perché la sua esistenza, a partire nuovamente dalla sua stessa corporeità, ha una relazione stabile fra le sue azioni (struttura/statica).
Si pensi a come Gaudium et spes – qui le considerazioni sono nostre – dichiara con forza la storicità dell’uomo, sempre diverso, con sempre nuovi linguaggi e contesti, ma al contempo afferma con la stessa forza che egli è sempre lo stesso e che i suoi desideri e i suoi problemi più grandi non mutano con il tempo, ma si ritrovano identici in ogni epoca (GS 10; cfr. su questo L’attualità dell’eterno, l’inattualità dell’attualità, di Andrea Lonardo).
Allo stesso modo l’uomo rompe continuamente la forma (informale/eccedenza), ma allo stesso tempo vive di un ordine, di un’esperienza che lo costituisce, di una ritualità che egli stesso elabora (Formale/forma).
Si pensi, ad esempio, a come questo illumina l’opposizione tragicamente resa “non più polare” da Karl Barth fra “fede” e “religione” (aut aut, o la fede o la religione), quasi che l’originalità della fede potesse vivere senza la liturgia[6]. Barth ha ragione quando vuole che la fede debba sempre purificare la “religione”, ma ha torto quando pensa che la fede possa vivere prescindendo dalla “religione” e dal “rito”.
Infine l’uomo è sempre diverso da qualsiasi altro uomo, ma al contempo vive in un costante processo di integrazione e di comunione con i suoi simili (Singolarità /differenziazione ↔ Totalità /integrazione).
Si pensi qui a come l’uomo sia fatto per la comunione, sia fatto per la relazione e l’incontro, ma come possa viverle bene solo scegliendo allo stesso tempo il silenzio, il raccoglimento, la riflessione sull’esperienza, la lettura, ecc. Come scrisse con enorme acutezza Bonhoeffer in La vita comune: “Chi non sa stare solo tema la comunità, chi non sa stare in comunità tema la solitudine”. L’uomo deve reggere da solo all’impatto con la vita, ma al contempo deve vivere nel mare magnum della vera compagnia.
Gli opposti transempirici sono, invece:
-Produzione ↔ Disposizione
-Originalità ↔ Regola
-Immanenza (Inabitare) ↔ Trascendenza (Stare al di sopra)
Il primo ricorda che l’uomo vive creando, innovando, producendo (produzione), ma, al contempo, organizzando a partire da ciò che gli è dato (disposizione). Non due opposti anche qui da sminuire, ma da portare alle estreme conseguenze, poiché solo la vita umana è in grado di essere con-creatrice di Dio, ma essa si riconosce sempre come posta, come data, come donata, non come autocostruita.
Questo opposto illumina la condizione post-moderna che spesso dimentica che prima del diritto viene il “dono”, prima della libertà viene la libertà di chi ha voluto generarci, che la vita non è a nostra disposizione, ma viene dall’alto; solo tale memoria, rende l’uomo libero per generare ancora, per creare, per proporre liberamente e anche questo “produrre” e “creare” è costitutivo e libera dalla passività che è dis-umana, come lo è la mancanza di riconoscenza e gratitudine.
Il secondo ricorda come l’uomo sia tale in quanto è originale, in quanto desidera essere autentico (originalità), ma al contempo egli non può vivere se non esaltando la forza dell’accettazione del reale (regola). Chi non vuole e non riesce ad essere sé stesso finisce per massificarsi e tale è la spinta apparentemente irrefrenabile cui il politicamente corretto e la società dei consumi spinge tutti: solo chi fa “obiezione di coscienza” si umanizza pienamente. Ma al contempo l’uomo appartiene ad un popolo, ad una tradizione e matura nell’incontro con i classici e nella scelta di una forma di vita stabile che lo costruisce.
Il terzo opposto ricorda come il “concreto-vivente” umano viva esplicando sé stesso nella dimensione storica e sociale (immanenza/inabitare), ma al contempo non possa minimamente prescindere pure dalla ricerca della verità e di Dio, per orientarsi nella propria e nell’altrui esistenza (trascendenza/stare al di sopra). Anche qui si vede come tale opposizione si pone come criterio critico verso chi sia indifferente all’azione storica – si pensi a tante visioni della religione intimistiche e non volte ad una testimonianza nel mondo. Ma, al contempo essa contesti ogni forma di vita personale e sociale che si presenti come negazione o anche solo sottovalutazione della trascendenza: tale dimenticanza della trascendenza impoverisce forzatamente qualsiasi progetto educativo, quasi che si possa dare l’umano senza la coscienza del peccato originale o senza una speranza oltre la vita o senza la ricerca della verità e se sia avvenuta la rivelazione di Dio.
Commenta, in sintesi, Borghesi, ricordando come L’opposizione polare cerchi di illuminare le tipologie psicologiche fondamentali attraverso le “categorie” degli opposti:
«Come è possibile vedere […] i poli coincidono qui con i tipi psicologici fondamentali. È il caso delle prime tre coppie di opposti, quelli “intraempirici” (atto/struttura, informale/formale, singolarità/totalità) i quali indicano, nei loro poli, due tipi umani antitetici: dinamico/quieto, dionisiaco/apollineo, individualista/comunitario»[7].
Borghesi prosegue:
«Allo stesso modo, ai tre opposti “transempirici” (produzione/disposizione, originalità/regola, immanenza/trascendenza) corrispondono le coppie tipologiche di creativo/ordinatore, originale/calcolatore, introverso/estroverso»[8].
Guardini enuncia infine i due opposti “trascendentali”, indicando con tale termine non gli opposti che si incontrano nell’esperienza concreta, ma in quanto presenti nell’opposizione in sé stessa.
Essi sono:
-Affinità ↔ Distinzione (Particolarizzazione)
-Unità ↔ Pluralità (Molteplicità)[9].
3/ L'assenza della polarità significherebbe che il “concreto-vivente” è patologico, vuol dire che è malato
Ma, appunto, l’opposizione polare non si accontenta di affermare che esistono “tipi” che accentuano l’uno o l’altro degli opposti, bensì procede molto più in là affermando che dove un polo dimenticasse l’altro o lo trascurasse e anzi non lo esaltasse, l’umano diventerebbe patologico, malato.
Perché
: solo mantenendo l’opposizione polare la vita fiorisce in pienezza.
Per Guardini la polarità vivente è una “legge” che esiste nell’esperienza stessa del “concreto-vivente”.
Altri autori del tempo – Guardini fa riferimento soprattutto a W. Sombart – avevano affrontato la questione della diversità dei “tipi umani”.
Ma per lui tali indagini – presenti anche oggi in tanti testi sociologici o in tanti manuali tutoriali sul benessere – sono viziati da una doppia unilateralità.
Infatti,
«la prevalenza di un polo non può escludere la compresenza dell’altro. Dal punto di vista della legge della polarità vivente, enucleata in Der Gegensatz, ogni polo (“tipo”) non deve affermarsi in assolutezza, pena la distruzione dell’esistenza, ma attuarsi in un rapporto complementare con il polo opposto»[10].
Guardini afferma con forza:
«Non quindi “sintesi” di due momenti in un terzo. E neppure un intero, di cui i due momenti costituiscano le “parti”. Ancor meno un miscuglio in una sorta di compromesso. Si tratta invece di un rapporto originario del tutto particolare; di un fenomeno originario. Ciascun opposto non può essere dedotto dall’altro, né ritrovato a partire dall’altro. […] Non si potrà mai dedurre la “struttura” dall’“atto”, né il “mutamento” dalla “durata”; non sarà mai possibile partire dalla struttura e senza soluzione di continuità sfociare di colpo nella dinamica. Entrambi i versanti dell'opposizione hanno consistenza essenzialmente autonoma e sussiste tra loro un confine reale, qualitativo. Si può passare dall’uno all’altro solo per mezzo di un atto specifico, un salto qualitativo. Ma entrambe le parti si danno sempre contemporaneamente; pensabili e possibili solo l’una grazie all’altra. Questa è opposizione: due momenti stanno ciascuno in sé senza poter essere dedotti, trasposti, confusi e tuttavia sono indissolubilmente legati l’uno all’altro; anzi si possono pensare solo l’uno nell’altro e l’uno grazie all’altro»[11].
E Borghesi conclude, presentandolo l’orizzonte guardiniano:
«Ciò significa che ogni “tipo” è sano solo nella misura in cui è se stesso e, insieme, accoglie un momento del suo contro-tipo. In caso contrario, come Guardini sapeva per esperienza personale, rischia di divenire patologico»[12].
4/ Una luce per svelare le ideologie e generare invece società
La visione di Guardini è talmente onnicomprensiva che egli “giudica” il mondo e le sue visioni proprio a partire dalla stessa opposizione polare.
Anche la costruzione di una società e, prima ancora, l’elaborazione di essa nel pensiero, necessitano dell’opposizione polare, altrimenti l’azione politica non potrà che divenire patologica, malata e produttiva di malattie sociali estremamente gravi.
Guardini, con la sua “opposizione polare” anticipa nel pensiero il corso del mondo che sta rapidamente cambiando intorno a lui, dove sistemi statalisti di sinistra o di destra – il comunismo, il fascismo e il nazismo – vorranno tutto sottomettere al principio comunitario-statalista, mentre visioni opposte – quella capitalistica e consumistica – inizieranno a pretendere un’esaltazione del soggetto e della sua libertà individuale assoluta, intesa come soddisfacimento di ogni possibile piacere.
Insomma l’opposizione polare è visione non solo necessaria a comprendere il singolo individuo, ma anche a comprendere cosa sia il bene sociale. Addirittura permette di illuminare l’arte, il suo fiorire e il suo impoverirsi o divenire parziale.
Ne scrive Borghesi:
«Queste considerazioni riguardanti i tipi valgono, per Guardini, anche per le “visioni del mondo”. Alle fondamentali opposizioni polari enucleate in Der Gegensatz non corrispondono, infatti, solo i tipi psicologici fondamentali, ma anche la sistematica delle visioni del mondo possibili. È il caso della vita come dinamica, atto, la quale
«può diventare così forte, da condizionare tutta la concezione dell’essere. Pensiamo ad Eraclito; all’attivismo, al pragmatismo e al personalismo dinamico della nostra epoca; alla disposizione di fondo dell’impressionismo nella poesia e nella pittura; all’impulso fondamentale che scaturisce da immagini dell’uomo, come quelle che si definiscono “gotiche” o “faustiane”»[13].
Allo stesso modo
«la consapevolezza che la vita è un che di fermo può diventare così forte, che individui o epoche vivono, creano e costruiscono a partire da questa idea. Si pensi alla filosofia di Parmenide o all’architettura degli Egizi o a ciò che si chiama arte e atteggiamento ieratico. Per questo atteggiamento essere significa continuità costante, durata statica, identità immobile. Esso propende per un’impostazione di fondo contemplativa, anziché attiva; conservativa, anziché attiva; aristocratica anziché democratica. Il giudizio dell’essere è superiore al giudizio di valore, il Logos all’Ethos, l’essere all’agire»[14].
Analogamente a quanto accade nella trasposizione ideal-filosofica della prima coppia degli opposti intraempirici, anche alla seconda (forma/eccedenza, formale/informale) corrispondono due visioni del mondo. La prima si richiama «ai Greci, o meglio a un ambito preciso della grecità, l’Apollineo, per usare un termine di Nietzsche. In esso forma, bellezza e verità erano la stessa cosa»[15]. La seconda indica al contrario, «quel qualcosa che si sottrae alla forma, la elimina, la fa saltare. La vita lì è ciò che è “privo di forma e di modalità”»[16]. È la visione dionisiaca che trova nel pensiero di Nietzsche la sua formulazione ideale.
Dalla terza coppia degli intraempirici (totalità/singolarità, integrazione/differenziazione) dipendono da un lato le visioni del mondo totalizzanti, orientate al sistema, «politicamente come tendenza allo Stato; nei rapporti umani come volontà orientata all’umanità; per quanto riguarda le cose, come volontà diretta verso il cosmo. Opera d’arte totale; sapere totale; educazione totale; cultura onnicomprensiva»[17].
Dall’altro le visioni che esaltano l’“istante” e il “singolo”, come in Kierkegaard. Qui «la figura singola nella sua particolarità rappresenta l’autentico - pensiamo all’arte di Rembrandt che è l’opposto di quella dei Greci. L’accento cade sul destino individuale piuttosto che su qualsiasi processo globale - pensiamo alla concezione individualistica della società e della storia. Il significato non sta nel tratto complessivo dell’accadere, ma nel singolo individuo e nella sua azione momentanea; non nello Stato, ma nell’individuo»[18].
Passando agli opposti transempirici, la prima coppia (produzione/disposizione) vede il contrasto tra visioni creative e visioni ordinatrici, organizzative:
«Nei quadri di Matthias Grünewald emergono figure da un fondo creativo. Essi non realizzano tipologie preesistenti, ma ne pongono di nuove; inaugurano nuovi domini dell’essere. Anche l’architettura gotica è talvolta così ed anche la scultura gotica; così gli uomini di Shakespeare, la musica di Beethoven, la politica di Napoleone»[19].[20].
Più volte Guardini ritorna sulle conseguenze sociali di una visione ideologica che prediliga uno dei due opposti e porti alla sottovalutazione o alla scomparsa dell’altro:
«Il quadro si chiude con le ultime due coppie di opposti: quelli trascendentali. Queste (affinità/distinzione, unità/pluralità) sono alla base, da una parte «di uno dei più importanti modelli di visione del mondo: quello “monistico”, orientato all’unità»[21], e, dall’altra, a un opposto «modello di visione del mondo: quello orientato alla differenza, il pluralismo»[22].»[23].
Con esemplificazioni che non sono di Guardini, si può pensare a come una reale integrazioni di popoli e culture diverse dentro uno stesso Stato abbia bisogno sia di principi condivisi per giungere ad una vera e concreta unità vivente, ma all’opposto anche di vero e dialettico pluralismo e non solo di uno o dell’altro.
O ancora come l’Europa possa essere una, eppure il principio di “nazione” possa continuare a restare inviolato e anzi esaltato insieme alle tradizioni di ogni singolo paese, di modo che si possa essere europeisti e al contempo amanti della propria identità nazionale.
Poiché i due opposti polari non possono mai essere ridotti in una semplificazione banale che annulli un corno della questione.
5/ Alla radice dell’opposizione polare: essa corrisponde ed è verificata dalla “visione cattolica del mondo”
Un elemento deve essere ancora essere messo in luce, perché è decisivo e permette prospettive di lunghissimo periodo e sguardi che danno respiro.
Guardini ebbe una Cattedra universitaria che oggi tragicamente forse non potrebbe nemmeno essere pensata – e proprio tale assenza ha qualcosa da insegnare a ciò che manca oggi ad un vero intellettuale. Fu titolare presso l’università di Berlino dal 1922 della Cattedra di Religionphilosophie und katholische Weltanschauung, cioè di Filosofia della religione e visione cattolica del mondo (Cfr. su questo su Gli scritti “Visione del mondo” cattolica, Weltanschauung cattolica (da Romano Guardini))[24].
Nella Repubblica di Weimar si ritenne, infatti, che nell’Università di Berlino, a maggioranza protestante, potesse essere preziosa la presentazione della “visione cattolica del mondo”, quasi ad entrare in dialogo, in un dialogo fra Confessioni diverse.
Tragicamente – e fu un segno chiarissimo della netta posizione anti-cattolica del regime - nel 1939 il nazismo revocherà la nomina di professore a Guardini, sopprimendo contestualmente la cattedra di Religionphilosophie und katholische Weltanschauung.
Questa espressione - katholische Weltanschauung – è estremamente intrigante.
In diversi suoi testi Guardini cerca di spiegare come egli giunse ad elaborare le sue lezioni e, prima ancora, il suo pensiero. Il filosofo e teologo tedesco scrive:
«In una conversazione per me gravida di conseguenze egli [Max Scheler] mi disse: «Lei dovrebbe fare ciò che dice il termine Weltanschauung, ossia contemplare il mondo, le cose, l’uomo, le opere, ma fare tutto ciò come un cristiano cosciente delle sue responsabilità, dicendo ciò che vede in termini scientifici». Ed io mi ricordo ancora che egli mi specificò: «Esamini per esempio i romanzi di Dostoevskij e prenda posizione su di essi dal suo punto di vista cristiano; metterà così in luce una parte dell’opera considerata, dall’altra il suo stesso punto di partenza».»[25].
Un secondo testo illumina la questione, mostrando come prima di Guardini col termine di Weltanschauung si intendesse una visione sempre cangiante delle cose, a seconda dei contesti storici sempre nuovi, mentre egli intese proporre una considerazione dell’oggettività personale della fede in quanto si rivela capace di leggere la realtà con uno sguardo armonico e stabile:
«Inizialmente essa [la Weltanschauung] era l’espressione del relativismo moderno e del soggettivismo in questioni religiose, che non credeva più ad una verità, ma soltanto ad una visione condizionata dai presupposti personali, storici ed etnici (cfr. Dilthey, Troeltsch, Jaspers). Poi venne il significato attribuitogli dal totalitarismo politico, ecc. A ciò si contrappone il mio tentativo di dargli la sua collocazione tra la fede nella rivelazione dall’una parte e la considerazione od osservazione empirica dall’altra»[26].
E ancora Guardini ne ha scritto, specificando che con tale visione egli non intese la pretesa di tutto giudicare nel dettaglio, quanto piuttosto proprio do fornire una chiave di lettura, però vera e reale:
«Questa “totalità”, questo “mondo”, a cui essa si volge non significa [...] che ogni singolo particolare sia effettivamente colto e ordinato in sintesi; essa non consiste in una completezza dei contenuti oggettivi, ma in un ordine, orientamento e significato delle cose colto dal primo istante e in ogni particolare. La Weltanschauung vede ogni cosa a priori ‘in modo totale’, la vede come una totalità in sé ed inserita in una totalità. Quest’ultima, questo ‘mondo’, non è a sua volta, un risultato finale che ne emerga quando si sono colte tutte le sue parti, ma esiste a priori»[27].
Ebbene, proprio l’opposizione polare è un pilastro portante di tale “visione cattolica del mondo”, proprio perché essa è “cattolica”, cioè capace di vedere le cose katà olon, cioè “secondo il tutto” e “a partire dal tutto”, dall’insieme, dall’ampiezza dello sguardo che vede “la profondità, l’altezza, la larghezza e ciò che supera tutto questo” (cfr. Ef 3, 18-19).
Da un lato l’opposizione polare è una delle caratteristiche della “visione cattolica del mondo”, d’altro canto è proprio tale visione cristiana che permette di comprendere appieno cosa sia l’opposizione polare e perché essa sia imprescindibile.
Perché la fede è uno sguardo sul mondo e non si dà fede senza, al contempo, cogliere il mondo, ma, contemporaneamente, è solo tramite la fede che si legge adeguatamente la vita, la storia e il cosmo, per cui non si dà adeguatamente “mondo” senza la fede.
Insomma, per Guardini l’opposizione polare è il modello ermeneutico di ogni possibile visione del mondo. Ed egli la trae proprio dalla “visione cattolica del mondo”.
Lo si vede bene quando scrive a proposito della Chiesa:
«Una lunga fatica riflessiva circa la struttura (ontologica) della vita mi aveva insegnato che tutta la realtà dell’uomo sussiste secondo certe strutture tipologiche e può in base ad esse venire classificata. […] Vero è che [nella Chiesa] si ritrovano tipi dell’umano d’ogni genere, ma essa non è risolvibile in alcuno di loro. Sempre c’è stato il pericolo che l’uno o l’altro di questi prendesse il sopravvento nella Chiesa e la assorbisse in sé; la storia delle eresie narra la serie di tali fenomeni. Ma essi non hanno mai potuto sopraffare la chiesa nel suo intimo nucleo. Hanno potuto soltanto qualche volta ridurla o impoverirla, ma chi conosce la verità della sua storia sa che la sua essenza è sempre rimasta completa e una. Ciò vuol dire: in lei c’è qualcosa che sta sopra tutte le strutture e le loro opposizioni. Essa non si risolve in nessuna struttura ma le abbraccia tutte. Adolf von Harnack ha trovato la giusta espressione per questo fatto, quando parlò di coincidentia oppositorium nella Chiesa, intendendo, a dire il vero, una confusione di contraddizioni. Realmente vive nella Chiesa qualcosa che - paragonabile all’energia che nell’atomo lega insieme tutti i suoi elementi - supera la tensione corrente tra le strutture e rende possibile una totalità che in base a tutte le concezioni sociologiche non sarebbe possibile sulla terra»[28].
Il valore generativo dell’opposizione polare è presente, allo stesso modo – solo per fornire un ulteriore esempio -, quando egli scrive del rapporto fra libertà umana e grazia divina:
«Ricorrendo a un’immagine figurata, per il nostro pensiero la totalità dell’esistenza ha non uno, ma due centri, non è un cerchio, bensì un’ellisse. A monte di questi due punti si risale fino a qualcosa di ultimo, che per noi è irraggiungibile. Appena si cerca di venire a capo del problema in linea teorica, o s’esclude la libertà dell’uomo e s’arriva al fatalismo, o s’esclude l’onnipotenza di Dio e si giunge ad un Dio che si limita a stare a guardare come nel deismo. In entrambi i casi, ne risulta distrutta la verità viva»[29].
Ma il principio dell’opposizione polare è così radicato e radicale nello sguardo di Guardini che si comprende come in ogni realtà umana e cristiana egli la veda in azione come determinante.
Su Guardini, vedi su questo stesso sito, oltre ai testi già citati:
La fede e il mondo
-Leggere e presentare i grandi (da Romano Guardini)
-Prendere sul serio il mondo (da Romano Guardini)
-L’uomo è fatto per l’incontro, cioè per trascendere sé stesso (da Romano Guardini)
-Religiosità come dimensione integrante anzi eletta della personalità umana (da Giuseppe Ruta su Romano Guardini)
-Antropocentrismo o teocentrismo, grazia o libertà? (da Romano Guardini)
-Cristo e il mondo (da Romano Guardini)
I luoghi di Guardini
-Romano Guardini a Berlino. Appunti di Andrea Lonardo 2/ Romano Guardini, di Maria Virginia Geremia Borruso 3/ Romano Guardini, uno dei maestri della Rosa Bianca, di Silvano Zucal
-Romano Guardini sepolto nella chiesa di San Ludovico a Monaco di Baviera (Ludwigskirche): il filosofo fu allontanato nel 1939 dalla cattedra di Katholische Weltanschauung dai nazisti. Breve nota di Andrea Lonardo da Wikipedia
-Università, pedagogia ed educazione dei giovani
-Perché l’educazione è il dispiegarsi di noi stessi e al contempo la ferma determinazione di modificare noi stessi? Romano Guardini spiega cosa è l’educazione, enunciando gli opposti polari che debbono essere tenuti in tensione
-«Come si dovrebbe insegnare teologia a fianco delle discipline “laiche”, per esempio in una Facoltà di Medicina, di Diritto o di Scienza dell’educazione?». Dialogo a partire da Romano Guardini e dalla sua cattedra di Weltanschauung, di Andrea Lonardo
-Il lavoro intellettuale e la ricerca, tra lo spaventosamente grande e una qualche configurazione, di Romano Guardini
-Educare non significa che un pezzo di materia inanimata riceva una forma, come la pietra per mano d’uno scultore (da Romano Guardini)
-Pastorale giovanile (da Romano Guardini)
-La coscienza tra Romano Guardini e Papa Francesco, di Pietro Messa
1/ Guardini: è la libertà il vero effetto Europa, di Monica Scholz-Zappa 2/ Romano Guardini, il filosofo dell'educazione. Parla Barbara-Hanna Gerl-Falkovitz 3/ Ecco perché Romano Guardini è (ancora) la voce giusta per il nostro tempo, di Roberto Righetto
La chiesa
-“La vera e propria scelta cristiana non ha luogo davanti al concetto di Dio e neppure di fronte alla figura di Cristo, ma davanti alla Chiesa.”, di don Achille Tronconi (meditazione a partire da un testo di Romano Guardini, nella lettera a mons. G.B. Montini, 29 marzo 1952)
-Chiesa reale, storica, attuale, non ideale (da Romano Guardini)
-«Vorrei lasciarvi un pensiero semplice, che mi sta molto a cuore: un pensiero sulla Chiesa, sul suo mistero, che costituisce per tutti noi - possiamo dire - la ragione e la passione della vita». Benedetto XVI cita Guardini sulla Chiesa e promette incondizionata obbedienza al nuovo Papa nel saluto al Collegio dei Cardinali
Liturgia, rito e preghiera
-Così è delle vere parole: il discorso che non implica relazione col silenzio diventa un cicaleccio. Solo nel silenzio avvertiamo il palpito della vita, nel silenzio le forze si raccolgono, ci si fa più chiaro il nostro stesso intimo, i pensieri e i sentimenti assumono contorni definiti (da Romano Guardini)
-Del segno della croce, di Romano Guardini
-Ridate alle parole il loro senso. Introduzione a I santi segni, di Romano Guardini
-Dell'inginocchiarsi, di Romano Guardini
-Il silenzio (da Romano Guardini)
-Compieta (da Romano Guardini)
-Il noi della liturgia (da Romano Guardini)
-Adorazione (da Romano Guardini)
-Contemplare la liturgia (da Viaggio in Sicilia di Romano Guardini (in R. Guardini, “Spiegel und Gleichnis. Bilder und Gedanken [Specchio e parabola. Immagini e pensieri]”, Grünewald-Schöningh, Mainz-Paderbon, 1990, pp. 158-161), resoconto della visita a Monreale del 1929)
Filosofia e teologia
-Essenza del cristianesimo Romano Guardini (da L’essenza del cristianesimo)
-Resurrezione, non semplicemente immortalità: la relazione con Dio che si ristabilisce per grazia (da Romano Guardini)
-Se si riuscisse a penetrare fino al 'Cristo originario'... (da Romano Guardini)
Questioni particolari
-Far risplendere la verità, senza alcun altro scopo (da Romano Guardini)
-Come invecchiare bene. I consigli di un grande teologo, di Romano Guardini
-Il nuovo, motivo della vita, la ripetizione, invece, della noia, da Romano Guardini
[1] M. Borghesi, L’opposizione polare in Romano Guardini. Una chiave per interpretare la vita e la storia, in “Ekklesía” 18 (2023), p. 16 (l’intero articolo che sarà più volte citato è alle pp. 16-21). Di Borghesi, sull’opposizione polare in Guardini, cfr. più estesamente, M. Borghesi, Romano Guardini. Antinomia della vita e conoscenza affettiva, Milano, Jaca, 2018, pp. 19-84.
[2] M. Borghesi, L’opposizione polare in Romano Guardini. Una chiave per interpretare la vita e la storia, in “Ekklesía” 18 (2023), p. 16.
[3] R. Guardini, L’opposizione polare. Tentativi per una filosofia del concreto-vivente, Brescia, Morcelliana, p. 189.
[4] R. Guardini, L’opposizione polare. Tentativi per una filosofia del concreto-vivente, Brescia, Morcelliana, pp. 89-90.
[5] M. Borghesi, L’opposizione polare in Romano Guardini. Una chiave per interpretare la vita e la storia, in “Ekklesía” 18 (2023), p. 17.
[6] Cfr. su questo Fede e religione (su K. Barth), da J. Ratzinger, Il dialogo delle religioni ed il rapporto tra ebrei e cristiani, in La Chiesa, Israele e le religioni del mondo, Edizioni San Paolo, Cinisello Balsamo, 2000, pp.72-73 e Fede e religione in Karl Barth: alle origini del dibattito teologico contemporaneo. Un’intervista a Pierangelo Sequeri ed un articolo di Italo Mancini.
[7] M. Borghesi, L’opposizione polare in Romano Guardini. Una chiave per interpretare la vita e la storia, in “Ekklesía” 18 (2023), p. 18.
[8] M. Borghesi, L’opposizione polare in Romano Guardini. Una chiave per interpretare la vita e la storia, in “Ekklesía” 18 (2023), p. 18.
[9] Questa la tabella concreta come la ricostruisce Borghesi a partire dai massimi studiosi di Guardini (cfr. M. Borghesi, L’opposizione polare in Romano Guardini. Una chiave per interpretare la vita e la storia, in “Ekklesía” 18 (2023), p. 17):
I. Categoriali
[A] Intraempirici [cioè interni e propri della persona stessa, sperimentabili da ognuno nella propria vita]
-Atto (Dinamica) ↔ Struttura (Statica)
-Informale (Eccedenza) ↔ Formale (Forma)
-Singolarità (Differenziazione) ↔ Totalità (Integrazione)
[B] Transempirici [cioè nell’ambito di ciò che è sperimentabile dalla persona stessa, sperimentabile oltre la propria vita]
-Produzione (Creare) ↔ Disposizione (Organizzare a partire da ciò che è dato) [creazione, ma anche accettazione di qualcosa di dato]
-Originalità ↔ Regola
-Immanenza (Inabitare) ↔ Trascendenza (Stare al di sopra)
II. Trascendentali [cioè nell’oppositività in quanto tale]
-Affinità ↔ Distinzione (Particolarizzazione)
-Unità ↔ Pluralità (Molteplicità).
[10] M. Borghesi, L’opposizione polare in Romano Guardini. Una chiave per interpretare la vita e la storia, in “Ekklesía” 18 (2023), p. 18.
[11] R. Guardini, L’opposizione polare. Tentativi per una filosofia del concreto-vivente, Brescia, Morcelliana, pp. 100-101.
[12] M. Borghesi, L’opposizione polare in Romano Guardini. Una chiave per interpretare la vita e la storia, in “Ekklesía” 18 (2023), p. 19.
[13] R. Guardini, L’opposizione polare. Tentativi per una filosofia del concreto-vivente, Brescia, Morcelliana, p. 95.
[14] R. Guardini, L’opposizione polare. Tentativi per una filosofia del concreto-vivente, Brescia, Morcelliana, p. 98.
[15] R. Guardini, L’opposizione polare. Tentativi per una filosofia del concreto-vivente, Brescia, Morcelliana, p. 102.
[16] R. Guardini, L’opposizione polare. Tentativi per una filosofia del concreto-vivente, Brescia, Morcelliana, p. 102.
[17] R. Guardini, L’opposizione polare. Tentativi per una filosofia del concreto-vivente, Brescia, Morcelliana, p. 107.
[18] R. Guardini, L’opposizione polare. Tentativi per una filosofia del concreto-vivente, Brescia, Morcelliana, p. 108.
[19] R. Guardini, L’opposizione polare. Tentativi per una filosofia del concreto-vivente, Brescia, Morcelliana, p. 114.
[20] M. Borghesi, L’opposizione polare in Romano Guardini. Una chiave per interpretare la vita e la storia, in “Ekklesía” 18 (2023), pp. 19-20.
[21] R. Guardini, L’opposizione polare. Tentativi per una filosofia del concreto-vivente, Brescia, Morcelliana, p. 134.
[22] R. Guardini, L’opposizione polare. Tentativi per una filosofia del concreto-vivente, Brescia, Morcelliana, p. 196.
[23] M. Borghesi, L’opposizione polare in Romano Guardini. Una chiave per interpretare la vita e la storia, in “Ekklesía” 18 (2023), p. 20.
[24] Cfr. soprattutto, R. Guardini, La visione cattolica del mondo, Brescia, Morcelliana, 2005.
[25] R. Guardini, Stationen und Rückblicke, Grünewald-Schöningh, Mainz-Paderborn, 1995, pp. 19 ss.
[26] Da una lettera di R. Guardini ad H. Fries dell’1/7/1952, citata in H.-B. Gerl, Romano Guardini. La vita e l’opera, Brescia, Morcelliana, 1988, p. 307.
[27] R. Guardini, Vom Wesen katholischer Weltanschauung (1923), ora in Scritti filosofici, vol. I, p. 277.
[28] R. Guardini, La Chiesa del Signore, in R. Guardini, La realtà della Chiesa, Brescia, Morcelliana, 1973, pp. 128-129, citato in M. Borghesi, L’opposizione polare in Romano Guardini. Una chiave per interpretare la vita e la storia, in “Ekklesía” 18 (2023), pp. 20-21.
[29] R. Guardini, Diario. Appunti e testi dal 1942 al 1964, Brescia, 1983, Morcelliana, p. 28.



